Poche vie all’epoca dell’antica
Roma erano larghe dai 5 ai 6 metri; la maggior parte erano vicoli a meandro,
del genere di quelli orientali. Giovenale deplorava che i carri facessero
un gran frastuono sul selciato ineguale e alla notte rendessero impossibile
il dormire, mentre la folla che di giorno si pigiava rendeva il camminare
una vera lotta. “Per quanto cerchiamo di affrettarci siamo bloccati da
una schiera che ci si fa di fronte e una densa massa di gente ci preme
alle spalle. Uno mi pianta un gomito nelle costole, un altro la stanga
di una portantina, un altro mi batte sulla testa una trave, un altro ancora
una botticella di vino. Le mie gambe sono inzaccherate di fango; enormi
piedi mi calpestano da ogni parte: un soldato mi pianta lo scarpone chiodato
sulla punta dei piedi.” Le strade principali erano pavimentate con larghi
blocchi pentagonali di lava, qualche volta fissati nel suolo così
fortemente che alcuni sono rimasti al loro posto ancora ai giorni nostri.
Non c'era illuminazione stradale; chi si avventurava nel buio portava con
sé una lanterna o si faceva seguire da uno schiavo che reggeva una
torcia; nell'un caso come nell'altro correva il rischio d'essere attaccato
da più di un ladro. Le porte erano chiuse con chiavi e chiavistelli
e le finestre fermate la notte col catenaccio e quelle a piano terreno
erano munite, come ora, del resto, da sbarre di ferro. A questi pericoli
Giovenale aggiunge gli oggetti solidi e liquidi che venivano gettati dalle
finestre dei piani superiori. Insomma, egli pensava, solo un pazzo andava
fuori a pranzo senza fare testamento. Poichè non c'erano veicoli
pubblici per trasportare i lavoratori dalle loro case sul luogo del lavoro,
molti della plebe vivevano in casamenti di mattoni nel cuore della città
o in camere dietro o sopra i loro negozi. Un casamento occupava di solito
tutto un isolato: per questo era chiamato insula. Molti di essi erano alti
sei o sette piani e costruiti con tanta leggerezza
che spesso ne crollava qualcuno uccidendo centinaia di inquilini. Augusto
limitò l'altezza frontale degli edifici a 10 piedi romani (1 piede
= cm 29 circa; 1 oncia = 1/12 del piede), ma pare che la legge permettesse
elevazioni maggiori nella parte retrostante, perché Marziale dice
“di un povero diavolo alla cui soffitta si accede con duecento scalini
(alzata dello scalino = circa 18cm)”. Molti casamenti avevano negozi a
pianterreno, alcuni i balconi al secondo piano: pochi erano congiunti in
alto ai casamenti di fronte con passaggi ad arco, che scavalcavano la strada
e contenevano altre camere o specie di tettoie poco sicure abitate da plebei
poveri. Queste insulae riempivano quasi la Nova via, il Clivus Victoriae
sul Palatino e la Suburra, un quartiere rumoroso e pieno di postriboli,
fra il Viminale e l'Esquilino. Qui abitavano i rivieraschi dell'Emporium,
i macellai del Macellum, i pescivendoli del Forum Piscatorium, i boari
del Forum Boarium, i venditori di erbaggi del Forum Holitorium, gli operai
delle fabbriche romane, i commessi e i piccolissimi impiegati. I quartieri
poveri di Roma arrivavano fino a lambire il Foro. Le strade che partivano
dal Foro erano affiancate da negozi e risuonavano dello strepito delle
contrattazioni. Fruttivendoli, librai, profumieri, tintori, fiorai, fabbri
ferrai, farmacisti e altri, che provvedevano alle necessità della
vita e ai capricci della vanità, ingombravano la strada con i loro
banchi che sporgevano molto in fuori. I barbieri esercitavano il loro mestiere
all'aria aperta, alla presenza di tutti. Le osterie erano così numerose
che Roma sembrava a Marziale una sola enorme taverna. Ogni commercio tendeva
a porre il suo centro particolare in un quartiere, in una strada e spesso
dava il nome ad una località; cosi i sandalai erano tutti riuniti
nel Vicus Sandalarius, i fabbricanti di finimenti nel Vicus Lorarius i
vetrai nel Vicus Vitrarius, i gioiellieri nel Vicus Margaritarius. In questi
negozi gli artisti italici facevano il loro lavoro, eccetto i più
grandi di essi che guadagnavano molto e vivevano nel lusso. Lucullo diede
ad Arcesilao un milione di sesterzi perchè gli facesse la statua
della dea Feù~tas e Zenodoro ne ricevette quattrocentomila per il
colosso di Mercurio. Architetti e scultori erano classificati coi medici,
gli insegnanti e i chimici fra quelli che esercitavano le artes liberales,
arti degne degli uomini liberi: ma coloro che facevano in Roma lavori artistici
erano o erano stati per lo più schiavi. Alcuni signori facevano
imparare ai loro schiavi l'incisione o la pittura o altre arti e poi ne
vendevano i lavori in Italia e all'estero. In queste botteghe il lavoro
era rigidamente suddiviso: alcuni erano specializzati in statuette votive,
altri in cornici dorate, altri tagliavano gli occhi di vetro per le statue;
i pittori erano specializzati, gli uni in arabeschi, gli altri in fiori
o in paesaggi o in animali, o nella figura umana e lavoravano a turno sullo
stesso quadro. Parecchi artisti erano esperti falsificatori in grado di
fare opere "antiche" di qualsiasi età si volesse. I Romani dell'ultimo
secolo a. C. erano facili da ingannare, perchè come la maggior parte
dei nuovi ricchi avevano la tendenza a valutare gli oggetti dal prezzo
e dalla rarità anzichè dalla loro bellezza e utilità.
Durante l'Impero, quando non era più una distinzione l'essere ricco,
il gusto migliorò e un sincero amore per la perfezione procurò
a molte migliaia di famiglie romane oggetti e ornamenti di una bellezza
quale pochissimi avevano conosciuto in Egitto, in Mesopotamia e in Grecia.
L'arte era per l'antichità quello che l'industria è per l'età
moderna. Gli uomini allora non potevano godere di quella abbondanza di
prodotti utili che ora ci viene dalle macchine, ma potevano però,
se ne avevano il gusto, circondarsi a poco a poco di oggetti, la cui forma
diligentemente rifinita dava a quanti vivevano in mezzo ad essi la delicata
e serena gioia delle cose belle.
Un visitatore che avesse cercato
di studiare le abitazioni del medio ceto le avrebbe trovate lontane dal
centro, sulle vie principali che se ne staccavano. Gli esterni in mattone
e stucco erano ancora fatti come in passato nello stile piatto e solido
suggerito dalla mancanza di sicurezza e dal gran caldo: i borghesi romani
non badavano troppo alle esigenze del gusto dei passanti. Poche case avevano
più di due piani. Le cantine erano rare: i tetti erano ricoperti
di scintillanti tegole rosse: le finestre munite di imposte o talvolta
di lastre di vetro. L'entrata era di solito costituita da una doppia porta,
con ciascuna delle metà girevole su cardini di metallo. I pavimenti
erano di creta o di mattonelle, spesso a tessere quadrate di mosaico: non
vi erano tappeti. Attorno all'atrio centrale si raggruppavano le stanze
principali della casa: da questa pianta architetturale derivarono il chiostro
e il cortile quadrangolare dei collegi. Nelle case più ricche, una
o più stanze venivano usate come stanze da bagno, di solito con
vasche molto simili alle nostre. L'idraulica giunse con i Romani a una
perfezione mai raggiunta prima del secolo XX. Tubi di piombo portavano
l'acqua dagli acquedotti e dai canali nella maggior parte dei casamenti
e delle case: gli infissi e i rubinetti erano di bronzo e alcuni artisticamente
lavorati. Doccioni e grondaie di piombo facevano defluire l'acqua
dal tetto. La maggior parte delle camere erano riscaldate, almeno con bracieri
portatili a carbone; poche case, tutte le ville e i palazzi e i bagni pubblici
avevano il riscaldamento centrale ottenuto con caldaie a legna o a carbone
che fornivano aria calda alle varie stanze attraverso tubi e bocchette
aperte nel pavimento e nelle pareti. Nel primo Impero fu fatta alla
casa del ricco romano un'aggiunta di origine ellenistica. Per fornire un
intimità, non sempre possibile nell'atrio, si costruì, dietro
l'atrio, un peristylium, un cortile a cielo scoperto, adorno di fiori,
cespugli e statue, circondato da un porticato con al centro una fontana
o una piscina. Attorno a questo cortile si costruì una nuova serie
di stanze; un triclinium o sala da pranzo, un oecus “casa” per le donne,
una pinacotheca per le collezioni d'arte, una bibliotheca per i libri,
una Lararium per gli dèi della casa: potevano anche esserci delle
camere da letto in più e piccole alcove chiamate exedrae o salottini
d'angolo. Le case meno ricche avevano un semplice giardino anzichè
il peristylium e se si doveva rinunciare anche al giardino i Romani ponevano
vasi sulle finestre o coltivavano fiori e piante sul tetto. “Certi larghi
tetti”, dice Seneca,” avevano persino arboscelli e alberi da frutto e viti
e piante fronzute piantate in casse di terra”: molte di queste terrazze
possedevano anche dei solaria per fare i bagni di sole. Molti Romani si
stancavano del frastuono e del movimento della città e fuggivano
verso la pace e l'ozio che la campagna offre. Ricchi e poveri insieme avevano
un sentimento della natura superiore a quello che ci è possibile
riscontrare nell'antica Grecia. Giovenale pensava che fosse pazzo quell'uomo
che viveva nella capitale, quando con l'affitto annuo di un oscuro stambugio
a Roma poteva comprarsi una graziosa casetta in qualche piccola tranquilla
città dell'Italia e circondarla di “un giardino ben curato da fare
la gioia di un centinaio di Pitagorici”. La gente abbiente se ne andava
da Roma all'inizio della primavera nelle ville ai piedi dell'Appennino
o sulle spiagge dei laghi o del mare. Plinio il Giovane ci ha lasciato
una splendida descrizione della sua villa di Laurento sulla costa del Lazio.
Egli la definisce “abbastanza vasta per i miei bisogni, senza che ne sia
troppo dispendiosa la manutenzione”, ma a mano a mano che procede nella
descrizione ci assalgono seri sospetti sulla sincerità della sua
modestia. Descrive “una piccola veranda, riparata da vetrate e da grondaie
sporgenti... una bella sala da pranzo quasi lambita dalle ultime creste
delle onde” e con tanta luce che entrava dalle finestre spaziose, dalle
quali si contemplavano tre vasti panorami sul mare, quasi tre diversi mari:
“un atrio da cui si scorgevano in lontananza boschi e montagne”; due salotti,
una biblioteca semicircolare, le cui finestre ricevevano il sole tutto
il giorno: una stanza da letto e parecchi altri locali per i domestici.
Nell'ala di fronte vi erano “un elegante salotto”, un'altra sala da pranzo,
e quattro piccole stanze: un quartierino per il bagno, costituito da “un
grazioso spogliatoio”, un frigidarium, un tepidarium con tre vasche riscaldate
a temperature diverse e un calidarium con l'acqua calda: tutte riscaldate
da tubi ad aria calda. Fuori dalla villa c'erano una vasta piscina, uno
spiazzo per il gioco della palla, un magazzino, un giardino, uno studio
privato, una sala per i banchetti e una torre-osservatorio con due appartamenti
e una sala da pranzo. “Dimmi ora” Plinio conclude “non ho io ragione di
dedicare tempo e affetto a questo mio delizioso rifugio ?”. Se un senatore
poteva possedere una villa simile sul mare e un'altra a Como, possiamo
facilmente immaginare il lusso splendente della villa di Tiberio a Capri
o di quella di Domiziano ad Alba Longa, per non parlare di quella che Adriano
si fece costruire pochi anni dopo a Tivoli. Per trovare qualche cosa che
vi stesse a pari per sfarzo, il forestiero doveva entrare nei palazzi dei
milionari e degli imperatori sul Palatino. Nell'architettura domestica
i Romani non si curavano di imitare la Grecia classica, dove le case erano
state modeste e solo i templi grandiosi; i Romani anzi modellarono i loro
palazzi sulle residenze dei re ellenistici quasi orientalizzati: lo stile
dei Tolomei venne a Roma con l'oro di Cleopatra e l'architettura regale
affiancò la politica monarchica. |
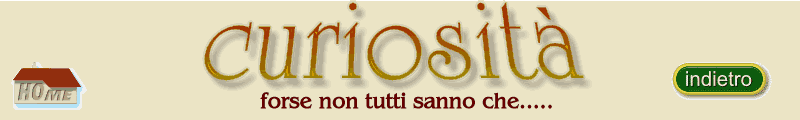 ..
..