| Hammurabi, per 43 anni re di
Babilonia nel periodo fra il 1728 ed il 1686 a.C. è forse il più
antico legislatore di ogni tempo, sebbene altre ricerche stabiliscano che
già alcuni secoli prima, la stessa di Babilonia, gli Ittiti e gli
Egizi avevano prodotto raccolte legislative. Nel 1902, per opera di una
spedizione archeologica francese, condotta dal De Morgan, vennero alla
luce tre frammenti di una stele dell’altezza di circa due metri e mezzo
contenente un sorprendente testo giuridico costituito da 300 paragrafi,
suggerito da Hammurabi. La promulgazione di questo codice venne realizzata
non prima del 34° anno del regno a dimostrazione che il re babilonese
impiegò alcuni anni per analizzare a fondo la realtà umana
e socio-economica del suo Paese il cui territorio era circoscritto tra
il Tigri e l’Eufrate per un’estensione di ben 120.000 chilometri quadrati.
Il codice è un coacervo di norme la cui logica giuridica supera
di gran lunga quella di altri codici appartenenti all’antico oriente ed
è in parte sorprendentemente valida anche ai nostri giorni. I paragrafi
che vanno dall’88 al 108 trattano delle operazioni di credito, degli scambi,
dei commercianti e degli agenti. Prima di analizzare alcuni aspetti di
questi paragrafi, diciamo subito che gli studiosi che si occupano della
genesi delle prime attività economiche sono giunti ad una interessante
ed avvalorabile conclusione: alcuni meccanismi e strumenti economici che
potrebbero a prima vista sembrare tipici delle società più
modeme ed evolute, risalgono in realtà ad alcuni millenni addietro.
Uno dei casi più straordinari riguarda l’assegno bancario. L’archeologo
Leonard Woolley, grande conoscitore della civiltà mesopotamica,
assicura, anche dall’esame del citato codice di Hammurabi, che già
i Sumeri 4 mila anni fa ricorrevano ad una forma neppure troppo primitiva
di assegni. Questo popolo era riuscito a mettere in piedi un complesso
sistema di scambi inventando una specie di lettera di credito. La soluzione
era pratica ed al tempo stesso ingegnosa: i commercianti che trasferivano
il loro carico di merci in una certa città, arrivati a destinazione,
vendevano i loro prodotti ricevendone in pagamento un “assegno” costituito
da una tavoletta di argilla sulla quale veniva inciso il prezzo della merce
contrattata in peso di rame o d’argento. La medesima tavoletta poteva essere
girata e serviva quindi per acquistare altre merci e così via. Naturalmente
questi “assegni” dovevano avere una copertura garantita ed a questo pensavano
i rappresentanti del potere politico e amministrativo facendo rispettare
le leggi vigenti sugli scambi commerciali. Il commercio che si svolgeva
4 mila anni fa tra il Tigri e l’Eufrate, fu quindi dinamico ed innovativo
ed introdusse i primi rudimenti di un sistema bancario supportato, tra
l’altro, dalla tavoletta-assegno. Nella pratica, il sistema creato dai
Sumeri per rendere snelle le contrattazioni commerciali, si basava su una
rete di agenti che copriva non solo le città poste nella piana Tigri-Eufrate
ma anche zone più lontane come l’Anatolia. Si trattava di vere e
proprie “daring-houses” del commercio che svolgevano anche funzioni di
banche primitive. Nel codice di Hammurabi, il termine mercante veniva usato
in relazione ai diversi tipi di attività commerciale e precise leggi
disciplinavano le modalità con cui dovevano essere stipulati i contratti
economici fra mercanti e agenti di viaggio o anche fra semplici cittadini.
Per esempio, due articoli del codice di Hammurabi, regolavano l’affidamento
di beni ad un agente per la vendita in nome e per conto del proprietario:
“Se un mercante ha affidato ad un agente orzo, lana, olio o altro genere,
perché li venda al dettaglio, l’agente registrerà l’argento
ricavato dalla vendita e lo restituirà al mercante; l’agente prenderà
una tavoletta sigillata relativa all’argento che consegna al mercante.
. .“. E ancora: “Se l’agente è negligente e non prende una tavoletta
sigillata relativa all’argento che ha consegnato al mercante, l’argento
non registrato su una tavoletta sigillata non sarà posto sul suo
conto. L’articolo 108 del codice prevedeva che “. . . se non realizza
profitti, l’agente consegnerà al mercante il doppio dell’argento
che ha ricevuto”. Per tutte le controversie fra mercanti e agenti, interveniva
il Tribunale del Tempio dove era stato depositato il contratto e gli agenti
disonesti erano condannati a restituire il triplo del capitale che era
stato loro affidato. Sembra che il Tempio, ove veniva adorato il dio Shamash,
deputato alla salvaguardia degli scambi e dei patrimoni, gradisse non poco
l’espansione dei commerci: “Chi investe denaro a corto termine ed è
senza legge, che cosa guadagna? Resta deluso nel profitto e per l’impiego
siffatto del capitale. Chi investe invece denaro a lungo termine e riesce
a moltiplicare un siclo in due sicli, è gradito a Shamash e la sua
vita è prolungata”. Una conclusione assolutamente calvinistica.
Non c’è che dire. I Sumeri ed i Babilonesi, che succedettero nel
dominio del territorio delimitato dai due fiumi Tigri e Eufrate, avevano
applicato dei metodi bancari dei tutto nuovi per sostenere i produttori
agricoli: i “contratti futuri”. Secondo i quali l’agricoltore poteva vendere
la sua produzione prima di averla raccolta tramite un contratto stipulato
da un mercante. Questa intesa costituiva un vero e proprio titolo di credito
in quanto negoziabile. I templi fungevano da banche imponendo ai debitori
un interesse sulla somma anticipata: per i prestiti di orzo il tasso d’interesse
era del 20%. Questa condizione non deve apparire esosa, poiché i
privati prestatori pretendevano un tasso anche del 33%, che debordava però
da una legge (legge Eshumna) che garantiva che il tasso d’interesse fosse
mantenuto in limiti definiti. Il tempio dunque aveva una pratica funzione
calmieratrice del mercato dci tassi. Anche la legge di Hammurabi regolava
i tassi commerciali in modo drastico e preciso: “Se il mercante ha spinto
il suo interesse al di là di 100.000 sila per un gur d’orzo o al
di là di 1/6 di siclo e sei grani per un siclo d’argento e lo ha
riscosso, perderà tutto quello che ha dato in prestito” (1 siclo
= 180 grani -I gur = 300 sila). Le operazioni creditizie si reggevano su
veri e propri contratti, per garantire i contraenti da reciproci abusi:
“Se un mercante ha consegnato in prestito orzo e argento senza testimoni
o contratto, perderà tutto quello che ha consegnato”. i debiti venivano
garantiti con la nomina di un garante che, in caso d’insolvenza dei debitore,
era impegnato a saldare il debito: “Akhum ha preso l’orzo da Khalunaddu.
Nel giorno del raccolto restituirà sull’aia l’orzo e il relativo
interesse. Se Akhum non verserà l’orzo, Mutamu sarà il suo
garante” (da un contratto stipulato 4 mila anni fa nel mese di Kiskisum).
I Sumeri ed i Babilonesi conoscevano pure la capitalizzazione degli interessi
maturati. L”interesse dell’interesse”. Così come conobbero un fenomeno
tipico delle economie contemporanee: l’inflazione. Uno degli esempi più
antichi d’inflazione si verificò in Mesopotamia nel 2000 a.C. in
coincidenza con la caduta del regno di Akkad: la caduta verticale della
produzione agricola determinò un abnorme aumento dei prezzi. Un
testo letterario dell’epoca descriveva chiaramente gli effetti devastanti
dell’inflazione: “Il tuo oro possa essere venduto come se fosse solo argento,
il tuo argento possa essere venduto come se fosse argento Zaham (di scadente
qualità), il tuo rame possa essere venduto come se fosse solo piombo...”.
Dunque abbiamo scoperto insieme che i Sumeri e i Babilonesi già
oltre 40 secoli fa regolavano i loro traffici con assegni, lettere di credito,
futures, contratti. Applicavano interessi sui prestiti di capitale, adottavano
forme di garanzia, si attenevano a precise leggi di scambio e conoscevano
gli alti e bassi dell’economia compreso il fenomeno dell’inflazione. Tutto
questo per buona pace dei commerciante e banchiere pratese Francesco di
Marco Datini (1335-1410) che rimane comunque l’inventore dei più
moderni “strumenti di marcatura” quali la lettera di credito, l’assegno
bancario, la cambiale. Ce lo racconta l’imponente archivio datiniano di
Prato costituito da centomila lettere commerciali e da cinquecento grossi
registri contabili |
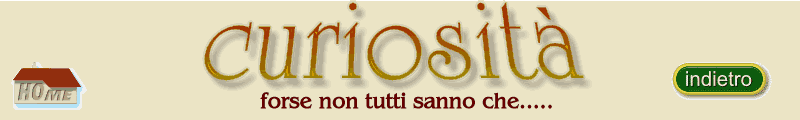 ..
..