| Pensando alla Roma dei Cesari,
la nostra fantasia, alimentata dall’arte neoclassica, dai plastici dei
musei e dai Kolossal hollywoodiani, corre subito al candore del marmo,
che era presente, sì, ma soltanto come uno dei tanti materiali di
costruzione, e non certo il più diffuso. Roma, invece, era una città
di mattoni, a volte nudi, più spesso intonacati in quelle tinte
vivaci che gli architetti contemporanei usano con tanta circospezione.
Si trattava di una grande metropoli, modernissima per alcuni versi, ma
per altri più simile alle capitali dei paesi in via di sviluppo
che alle città europee del ventesimo secolo: al tempo della sua
massima espansione ci vivevano un milione e mezzo di abitanti, di cui soltanto
un terzo donne, in quanto la manodopera servile era costituita in gran
parte da schiavi maschi, mentre l’esposizione dei bambini colpiva maggiormente
le femmine. Ovviamente non tutti, di quel milione e mezzo, abitavano in
ville sontuose dalle pareti affrescate, con legioni di schiavi a servirli.
Vediamo dunque come viveva un cittadino qualunque, libero ma di mezzi modesti,
in quell’agglomerato caotico e sovrappopolato che era l’Urbe padrona del
mondo. I romani si alzavano all’alba, com’è scontato in ogni società
che ancora non conosca la luce elettrica. Dopo una sommaria abluzione,
sbocconcellavano qualcosa, un po’ di pane o gli avanzi della cena
precedente, poi si recavano al lavoro, a meno che non fosse giorno di festa,
e di feste ce n’erano parecchie, perchè se mancava il giorno di
riposo settimanale, le celebrazioni civile e religiose uguagliavano quasi
le giornate lavorative. Il primo problema che il nostro romano - lo chiameremo
Gaio, il nome più diffuso a quei tempi - doveva affrontare, era
quello del traffico. Attraversare l’Urbe da un capo all’altro non
era facile, anche se fin da Giulio Cesare tutta la città era isola
pedonale durante le ore diurne, il che rendeva quelle notturne ben poco
riposanti, animate com’erano dal rumore dal rumore continuo dei carri di
merci. Non che di giorno la viabilità fosse migliore: la gente era
tanta, tantissima, le bancarelle intasavano i vicoli angusti, le carriole
tirate a mano si rovesciavano provocando ingorghi, e a poco valevano i
frequenti passaggi pedonali sopraelevati che attraversavano la strada da
un marciapiede all’altro. I grandi ricchi venivano trasportati in lettiga,
preceduti da schiavi che sgombravano il passo alla vettura gridando con
voce stentorea il nome dell’augusto passeggero; altri, meno pretenziosi,
si accontentavano di un palanchino; i più, come il nostro Gaio,
andavano a piedi. Artigiani e commercianti tuttavia, non dovevano
fare molta strada per recarsi a bottega, perchè in genere alloggiavano
su un soppalco del negozio stesso,o nel cubicolo retrostante. Le grandi
domus a un piano solo, con atrio, tabilino, triclini, peristili e numerose
esedre - di cui oggi vediamo un esempio nelle case pompeiane - a Roma erano
infatti rarissime, e appannaggio dei grandi privilegiati. Il grosso dei
quiriti viveva in affitto nelle grandi insulae a cinque o sei piani tanto
simili ai nostri palazzi condominiali, in bugigattoli dove le pareti divisorie
consistevano in fragili tramezzi coperti da una frettolosa mano di intonaco.
La speculazione edilizia era dilagante - un sottoscala al centro dell’Urbe
costava quanto una villetta in campagna - e ben pochi osservavano le norme
imperiali sulla sicurezza, così queste insulae smisurate crollavano
con preoccupante frequenza. I fortunati abitavano al pianterreno, che,
buio a parte, aveva molti vantaggi, primo tra tutti l’allacciamento all’acqua
corrente, naturalmente previo pagamento della tassa relativa. Qui, negli
atri rischiarati da torce e candelabri, i potenti ricevevano la folla dei
clientes - dai quali deriva la nostra locuzione “clientela politica” -
che, paludati nelle toga di gala presa a prestito, recavano omaggio al
patrono in cambio della sportula quotidiana di cibo, unica fonte di sostentamento
per migliaia e migliaia di disoccupati. Sì, perchè con la
concorrenza spietata di una manodopera servile a costo irrisorio, il problema
della disoccupazione era ancor più grave di oggi, tanto che alcuni
rinunciavano ai loro diritti di cittadini per vendersi come schiavi e vivere
al sicuro sotto la protezione di un padrone. Nell’insula, dunque, più
si saliva in alto, più crescevano i disagi: i gradini di pietra
per accedere ai piani superiori erano un lusso, mentre più spesso
ci si doveva arrampicare sulle fragili balconate di legno della facciata.
Nel sottotetto pioveva dentro, e gli inquilini erano costretti a sfinirsi
per portare su l’acqua potabile, o liberarsi da rifiuti ed escrementi.
Infatti, malgrado Roma abbondasse di latrine pubbliche a basso prezzo -
eleganti stanzette con ampi sedili di pietra a sei posti, dove l’utente
ingannava il tempo chiacchierando con gli amici - non tutti ne facevano
uso, e i più attendevano l’oscurità per vuotare dalla finestra
i vasi da notti, senza troppo rispetto per gli eventuali passanti, o sceglievano
di liberarsi nei grandi ziri di coccio ritirati ogni sera dai fulloni che
usavano i prodotti della minzione per tingere e detergere le stoffe. Se
a tutto questo si aggiunge che gli appartamenti d’affitto non erano nemmeno
dotati di focolare, si capisce come la maggior parte dei romani preferisse
stare fuori da mane a sera, nei fori, in strada o sotto gli eleganti portici
costruiti da sponsor in cerca di notorietà, e avesse la moderna
abitudine di mangiare al bar, che allora si chiamava thermopolium, e consisteva
in una vera e propria tavola calda dove per pochi assi ci si faceva servire
al banco una zuppa bollente, pane e salsiccia o una pizza di erbe, oltre
all’immancabile vino allungato. Per i più schizzinosi esistevano
le popinae e le cauponae, in cui si poteva mangiare seduti, e nel menu
era compresa la cameriera. Ovviamente, in una città piena
di uomini soli, la prostituzione dilagava, dai postriboli autorizzati a
quelli clandestini, dalle samberghe dove donne male in arnese attendevano
i clienti di più facile contentatura, alle case sfarzose delle grandi
etere, frequentate dal fior fiore dell’aristocrazia. C’erano anche bordelli
per gusti particolari, come quelli dell’ Esquilino, diventati di gran moda
da quando l’emancipazione della donna spingeva molti romani, abituati a
farla da padroni, tra le braccia di accondiscendenti schiavetti orientali.
Il nostro Caio trascorreva dunque la mattina in bottega, al foro, oppure
nelle molte basiliche che fungevano da tribunali, sempre affollate, perchè
i litigiosissimi quiriti erano pronti a far causa per un nonnulla. Nel
pomeriggio invece la vita sociale si spostava alle terme, dove nessun abitante
di Roma, ricco o povero, libero o schiavo, avrebbe mai rinunciato ad andare.
Il bagno era pressochè gratuito, in quanto molti degli stabilimenti
erano donati da filantropi desiderosi di perpetuare il loro nome o di farsi
propaganda in vista delle elezioni. Ma, oltre alla piscina comune, erano
disponibili anche saune, palestre, biblioteche, ristoranti, sale di massaggi
e di estetica, nonchè svariati negozi. Lì i quiriti ascoltavano
conferenze, corteggiavano signore, tessevano intrighi, decidevano affari,
carriere, matrimoni. Il tutto mentre si facevano raschiare con lo strigile
dai balneatores - il sapone non era ancora stato inventato - in attesa
del tuffo nella vasca fredda e del massaggio corroborante. Così
nell’Urbe, dove ancora non esisteva alcuna coscienza ecologica, c’era un
consumo d’acqua mai uguagliato nella storia: almeno tre volte quello attuale!
Durante il bagno, cominciava la caccia all’invito a cena. Non sempre però
l’anfitrione osservava le regole della buona creanza, e poteva accadere
che al nostro Caio venisse ammanita una misera coscia di gallina, mentre
vedeva sfilare alla mensa d’onore vulve di scrofa e lingue di fenicottero.
D’altra parte era raro che un povero gustasse la carne a casa sua, salvo
quella, un po’ selvatica, degli animali scannati nell’arena: l’alimentazione
comune consisteva in pane, legumi e polenta di farro, magari insaporita
da un po’ di moretum, il profumatissimo formaggio all’aglio la cui ricetta
risaliva agli etruschi. La moglie di Gaio, dal canto suo, non se ne stava
affatto a casa a filar la lana come le sue antenate. Andava anche lei alle
terme - in quelle riservate alle donne se era molto pudibonda, più
spesso in quelle miste, con grande scandalo dei benpensanti - e non rinunciava
a farsi bella nemmeno con pochi soldi in tasca: di ornamenti femminili
a Roma ce n’erano da tutti i prezzi, dalle favolose armille di oro e smeraldi
esposte dai gioiellieri del Clivius Argentarius, ai ninnoli di metallo
fatti in serie, in vendita sulle bancarelle, e anche la più modesta
delle schiave possedeva una collana, un anellino, un po’ di bistro per
sottolineare gli occhi. Con qualche asse ci si poteva far tingere i capelli
di rosso con la schiuma batava, o schiarirli col sapo di Marsiglia, sognando
di acquistare un giorno uno dei toupet di capelli indiani in vendita presso
il tempio di Ercole, o addirittura un’elegante parrucca ricavata dalle
chiome biondissime delle barbare germane. Parrucchiere ed estetiste prosperavano,
oltre ovviamente ai tonsores che sbarbavano quotidianamente le guance dei
quiriti, operazione non sempre indolore, data l’inadeguatezza di molti
rasoi. Ma nessun romano degno di questo nome, con l’eccezione di qualche
strambo filosofo, si sarebbe mai fatto vedere in giro con la barba lunga:
l’orrore per i peli superflui era tale che ci si preoccupava di toglierli
accuratamente anche dalle narici, dalle orecchie e a volte persino dalle
braccia e dalle gambe. La pulizia, la cura del corpo a tutti i livelli,
era insomma un valore irrinunciabile, e gli schiavi in questo, non erano
da meno dei liberi: quale dominus, infatti, avrebbe mai tollerato in casa
sua dei servitori sporchi e trascurati? Nell’Urbe ci si lavava in continuazione,
e ai moralisti scandalizzati si usava rispondere con l’adagio: “I bagni,
il vino e Venere forse accorciano la vita, ma allora che vivi a fare?”.
Caduto l’Impero, per quindici secoli non ci si lavò quasi più. |
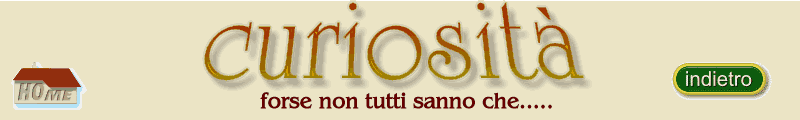 ..
..