Dicembre:
Mes’’e Idas; Nadali.
Nadàli fridu, bècciu e scorriàu/
s’urtimu fìllu de s’annu jai passàu!
Natale freddo, vecchio e rabberciato/ l’ultimo
figlio dell’anno quasi passato!
Mes’’e Idas: il termine Idas ha interessato
tanta parte dei ricercatori di linguistica sarda ed ancora oggi permangono
incertezze sul suo etimo e sul significato. Il Wagner, che tra gli
studiosi della lingua sarda rimane, sinora, il più autorevole, se
la cava con il latino Idus (le Idi), con adattamento ai sostantivi femminili
in “a”. Lo stesso latino eredita la parola dall’etrusco, nelle cui iscrizioni
appare Edus o Eidus. Le Idi cadevano a metà del mese, 13 0 15 e
ben poche relazioni hanno con l’ultimo mese dell’anno. Arricchiamo le nostre
considerazioni sul termine Idas della interpretazione, un po’ singolare,
ma comunque interessante, di un ulteriore studioso, di cui preferiamo non
far nome. Secondo il quale Idas deriverebbe da Idus latino. Data per scontata
le derivazione di Idus dal verbo etrusco Iduare = dividere (secondo Microbio
e Marrone), abbiamo quindi Idus nel significato di metà, del mese
appunto; il Nostro fa derivare Idas da vidua: ut idus vocemus diem, qui
dividit mensem; vidua quasi valde idua, id est valde divisa, aut a viro
divisa: - così come chiamiamo idus il giorno che divide il mese,
vidua o idua significa divisa, vedova, divisa dal marito; ne consegue:
mes’’e Idas = mese delle vedove; periodo in cui le vedove avrebbero maggior
bisogno di essere consolate etc! Altri ricercatori suggeriscono mes’’e
Iras, dal latino ira, furore, perché si tratta del mese in cui il
tempo più s’infuria: freddo, grandine, neve etc.
Per arrivare al termine Idas, noi indichiamo
un altro percorso. Il termine Idas, nella sua forma più antica doveva
essere Aidas (talvolta nella pronuncia di persone anziane ancora oggi si
sente la “a” mes’’e (A)ìdas). Il termine deriva chiaramente dal
greco Αίδας (Aìdas), che è la forma dorica di Αίδης (Aìdes)
= Ades (l’invisibile), dio delle tenebre e signore dell’oltretomba >Plutone.
Si tratta quindi del dio dei morti, ma non solo, poiché Plutone
è anche dio della ricchezza, dell’abbondanza e favorisce la vegetazione;
tanto è che si invocava con diversi epiteti: Еυβουλέυς (eubulèus)
= il benevolente; Аγησιλάος (Aghesilàos) = adunatore di popoli.
La figura di Ades è legata al mito di Demetra (Cerere), dea della
terra e delle messi, e di Core (Proserpina o Persefone), sua figlia, che
fu da lui rapita per farla sua sposa( vedi nell’Web: giuseppe concas –
rime e racconti: “Persefone”. Nell’antichissima città di Eleusi
(oggi Lefsìna), nella penisola dell’Attica, non lontano da Atene,
restano i ruderi del grandioso santuario di Demetra e Core, ove in due
periodi dell’anno si celebravano i Misteri Eleusini: tra le più
importanti manifestazioni religiose dell’antichità greca; chi vi
era ammesso riceveva la certezza di una vita migliore nell’aldilà.
L’imperatore cristiano Teodosio chiuse definitivamente il santuario nel
381 e nel 396 il barbaro Alarico lo rase al suolo. I Misteri Eleusini sono
antichissimi e, secondo molti studiosi, di origine preellenica, cioè
precedenti l’arrivo dei popoli parlanti lingua greca, nella Penisola Balcanica.
Il termine delle celebrazioni cadeva nell’ultima parte del mese di Boedromione,
settembre/ottobre, del nostro calendario; iniziava quindi il periodo(ultima
metà di ottobre/ novembre/ dicembre/ gennaio, sino a metà
febbraio) in cui, secondo il mito, cantato nell’Inno a Demetra da Omero,
Ade o Plutone, prendeva con se la bellissima Persefone, lasciando in lacrime
la madre Demetra, sino alla primavera(ultima metà di febbraio/marzo,
aprile etc), allorquando madre e figlia tornavano insieme. Mes’’e
Idas, dunque, mese in cui Ade (Aidas), dio dell’oltretomba, riprende con
se la bellissima sposa. L’intervallo autunno/ inverno (per noi) aveva come
punto centrale dicembre ed era inoltre il mese dei morti e di Ade(Aidas)
il loro dio. Non dimentichiamo poi che la pianta sacra per il dio Ade era
proprio il cipresso! Rimane da chiarire come e quando sia entrato in Sardegna
il mito di Demetra e Core.
2 dicembre: Santa
Bibiana:
“Si proit sa dì de Santa Bibiana, abarrat
proendi finas a sa Befana”! “Se piove il giorno di Santa Bibiana, piove
sino al giorno della Befana”! “Santa Bibiana mia, il due dicembre
ha piovuto tutto il giorno…speriamo che non arrivi Mitch…Santa Bibiana
mia”!
4 dicembre: Santa
Barbara.
Patrona dei naviganti, ma, soprattutto per
noi del Sulcis – Iglesiente(Sardegna sud occidentale), anche dei minatori.
È la nostra più amata e anche se le miniere ci sono ancora,
ma i minatori non ci sono più, Lei continua a proteggerci. Ed insieme
a San Giacomo ci protegge dai lampi: Santa Bràbara e Santù
Jàcu, osu portàis is crais de ?elu,/ òsu portais is
crais de lampu/ no tokèis a fìllu allènu/ nì
in dòmu, ni in su sàttu! (Santa Barbara e San Giacomo/ voi
portate le chiavi del cielo, voi portate le chiavi dei lampi, non toccate
i “nostri” figli, né in casa né in campagna). Quando i fulmini,
non di Giove, ma quelli veri, zigzagano nella volta celeste (su “f”igu
màrras), ancora oggi le donne anziane recitano lo scongiuro. “Santa
Bràbara mia meraculòsa”! (Santa Barbara mia, dei miracoli!):
è l’esclamazione comune davanti ad incidenti o spiacevoli scene.
Aneddoto:
durante la “questua” per i festeggiamenti
appunto della Santa (a Gonnosfanadiga, facevo parte del Comitato))entrammo
in casa del Signor Battista Piras, il quale volle trattenerci (eravamo
in 4)per offrirci un bicchiere del suo “nobile” vino. “Ita bolèis
picciòccus, binu de bàlla o binu de Santa Bràbara”?
(“Che volete, giovanotti, vino di “balla” o vino di Santa Barbara”? “ De
Santa Bràbara”! Esclamammo in coro. Sorridendo ci versò il
vino di Santa Barbara. Il primo all’assaggio dell’ipotizzato nettare, fu
Antonio, il solito “svelto” del gruppo. “Santa Bràbara mia meraculosa”!
Esclamò, aggiungendo: “ Custu est axèdu”! (“Questo è
vero e proprio aceto”!). Con gli occhi bene aperti e sempre sorridendo:
“Provai cust’atru, piccioccus”! – suggerì quindi tziu Battista,
offrendoci altri 4 bicchieri, ben pieni: “ Balla, balla! Ita bellu! – gridammo
in coro, sorseggiando il divino nettare. “Binu de bàlla, piccioccus”!
– soggiunse, tziu Battista.
13 dicembre:
Santa Lucia:
“ Sa dì de Santa Luxìa o proit
o fait cilixìa” = Il giorno di Santa Lucia o piove o fa la brina
(la gelata). Santa Lucia protegge uomini ed animali dal malocchio. Lo sapevate
che le corna di bue, di capra o di montone, oltre al consueto ferro di
cavallo, proteggono dal malocchio? E che il malocchio non ha effetto né
sugli asini, né sulle galline? …” A su molenti ogu liàu nienti;
a sa pudda, ogu liàu nùdda”!
17 dicembre:
San Lazzaro.
A Napoli opera ancora oggi La Ditta dei “Fratelli
Lazzaroni”; proprio di recente, entrando in un negozio di frutta e verdura,
su una cassetta di uva da tavola ho letto, “I F. Lazzaroni”. Il fatto
mi ha riportato alla mente un singolare episodio avvenuto a Napoli nel
1939, ai primi di luglio, se non vado errato, in occasione di una
visita ufficiale del F?rer Hadolf Hitler, circa un mese e mezzo dopo
la firma del “Patto D’Acciaio”, tra Germania e Italia. Il F?rer, dopo la
visita alla Capitale, volle visitare Napoli, delle cui decantate bellezze
aveva sentito parlare. Sembra che Hitler alla fine della visita, durante
la quale il nostro “Duce” Benito Mussolini, gli fece da perfetto cicerone,
senza staccarsi da lui per un solo attimo, abbia voluto immortalare il
fatto con una foto ricordo, con Mussolini, è chiaro. Per richiesta
del fotografo, il migliore di tutta Napoli, per l’occasione, per il fatto
che il Duce era di un palmo più basso del F?rer, per non farlo sfigurare
chiese che gli mettessero qualcosa sotto i piedi. In fretta e furia fu
trovata una cassetta di legno, su cui salì in fretta il Duce perché
già il F?rer dava segni di impazienza. Ne uscì una foto eccezionale,
unica più che rara: sotto i due “grandi” uomini si leggeva chiaramente,
“I Fratelli Lazzaroni”! N. B. I libri di storia non riportano l’episodio,
che però molti napoletani ricordano ancora!
23 dicembre:
Scolari e studenti iniziano la pausa o vacanza
natalizia, che durerà sino al giorno dell’Epifania: “ Dopo l’Epifania,
tutte le feste se ne vanno via”! Proverbio dello studente: “Chi studia
molto…impara ben poco; chi studia poco…non impara niente”!
24 dicembre:
Sa notti de Paskixèdda = la notte di
Natale. Natale con i tuoi; Pasqua con chi vuoi.
Sa Notti de Paskixèdda, un tempo (vedi
in rime e racconti, sempre in “Giuseppe Concas”): “Prima della sera, quando
già si fa sentire il freddo pungente, col vento gelido che penetra
sino alle ossa, il padre di famiglia(pater familias) carica il caminetto
con dei bei ceppi secchi, in modo che l’ambiente sia ben caldo, quando
arrivano amici e parenti per trascorrere in allegra comitiva la Sacra Notte.
Verso le nove delle sera è tutto pronto; il tavolo imbandito di
dolci tradizionali, tra cui spiccano quelli con le mandorle e nocciole:
amaretti, bianchini, pane di sapa, guèffus, pistokèddus grussus
e finis. Al centro del tavolo campeggiano le bottiglie di buon vino(vedi
in rime: Natale ieri e oggi): il rosso, il bianco, a scelta; non manca
l’aranciata per i più piccini. Arrivano man mano gli invitati a
riempire la stanza, a dir la verità, non tanto spaziosa. C’è
un vociare continuo, stipante: hanno tante cose da dirsi; è da tanto
che non si vedono: a dir poco dalla mattina o addirittura dalla sera prima.
Il caminetto, manco a farlo apposta, non tira bene, o meglio, meno del
solito ed il fumo finisce di riempire l’ambiente già saturo. Tutto
ciò non impedisce l’inizio dei giochi: con la trottolina(a baddarìncu
– tottu, poni, mesu, nudda), a pìtzu cù, a cavalieri in porta
etc. si da ampio spazio all’abbuffata: è un “crikcrokare”, di mandorle,
noci, nocciole, ceci, castagne infrante, torchiate, pressate da poderose
mascelle, in più o meno perfetta sintonia. I giovani, prima della
mezzanotte, si recano in chiesa per la messa della vigilia: “Sa Missa de
Puddus”: “la messa del gallo”, la chiamano i sassaresi; in realtà
“Puddus”, ha ben poco a che vedere con “gallo”, perché il termine
viene dal latino Pullus, con lettera maiuscola e significa rampollo, Divino
Rampollo, cioè figlio di Dio: si tratta infatti della messa in onore
della nascita di Gesù Bambino!
31 dicembre.
San Silvestro.
San Silvestro, fu eletto papa il 31 gennaio
del 314 e morì il 31 dicembre del 335. Il nome del santo è
legato al dono di fine d’anno. 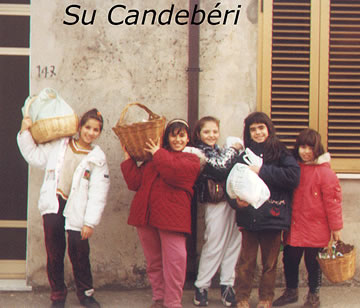 È
ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire
un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa
che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani
concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,
alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,
vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino
del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare
la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera
di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto
di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:
Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno
è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”
( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione
o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel
suo significato più antico, su candelèri
(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,
insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più
o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente
truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente
di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono
il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,
còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu
nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più
o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci
di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle
e quanto altro. È
ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire
un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa
che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani
concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,
alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,
vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino
del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare
la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera
di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto
di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:
Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno
è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”
( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione
o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel
suo significato più antico, su candelèri
(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,
insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più
o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente
truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente
di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono
il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,
còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu
nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più
o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci
di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle
e quanto altro.
Su Candelèri
Su trint’unu de mes’’e Idas
Cun corbeddas e scartèddus,
fiat costumu in custas biddas,
po pippias e picciokkèddus,
de pedì is ladixèddas,
trigu cottu, pistokkèddus,
caramellas e nuxèddas.
Tzerriaiàus cun custus fuèddus
:
« Candelèri cottu nd’hànti
» ?
A ki a palas, a ki anànti,
De bixànu, in bixànu.
Andaiàus de manjànu:
a merì a dòmu, prexàda,
furriàt sa cambaràda !
Peppi
|
Traduzione (letterale) in italiano
La « focaccia “ – il dono di fine d’anno.
Il trentuno di dicembre
Con cestini e corbelli,
era usanza in questi borghi,
per bambine e bambini,
chiedere le “focaccine”
grano cotto, biscottini,
caramelle, noccioline.
Con queste parole:
“La focaccia l’hanno cotta?
Chi dietro e chi davanti,
di vicinato in vicinato,
Partivamo di buon mattino:
nel meriggio a casa contenta,
rientrava tutta la compagnia!
Peppe
|
|


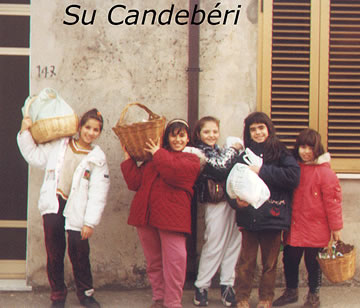 È
ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire
un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa
che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani
concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,
alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,
vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino
del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare
la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera
di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto
di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:
Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno
è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”
( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione
o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel
suo significato più antico, su candelèri
(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,
insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più
o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente
truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente
di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono
il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,
còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu
nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più
o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci
di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle
e quanto altro.
È
ancora in uso, in molte regioni d’Italia, e non solo, fare un regalo, offrire
un dono, ai poveri ad esempio. In questa consuetudine vi è qualcosa
che si ricollega alla tradizione romana ed al periodo in cui i nobili romani
concedevano un giorno o alcuni giorni di licenza, insieme a svariati doni,
alla propria servitù. Senz’altro però, nel dono di fine d’anno,
vi è un chiaro riferimento alla Donazione dell’imperatore Costantino
del 313, per i cui effetti i cristiani potevano liberamente professare
la propria religione. La Donazione di Costantino è legata all’opera
di convincimento esercitata da Silvestro vescovo nei confronti non tanto
di Costantino, quanto invece della madre Elena “Augusta” (vedi nell’Web:
Elena Augusta madre dell’imperatore Costantino). Il dono di fine d’anno
è comunemente chiamato da noi in Medio Campidano “su candelèri”
( su candelàriu, su candelàrtzu, in altre parti): una manifestazione
o meglio una “festa”, che coinvolge soprattutto bambini e bambine. Nel
suo significato più antico, su candelèri
(candelariu, candelartzu) è una “focaccia” preparata per l’occasione,
insieme ad altri dolci tipici. Il giorno di fine d’anno, gruppi, più
o meno folti, di bambini e bambine, non manca qualche adulto, opportunamente
truccato, vanno per le strade del borgo, armati di cestini (possibilmente
di vimini o di canne), più o meno grossi, di porta in porta, chiedono
il dono. “ Candelèri cottu nd’hanti”! “Candelèri, Candelèri,
còscias de peringhèri, coscias de perr’’e ‘oi, nonna fattu
nosi dh’has su coccòi”? A fine giornata quei cestini, più
o meno grandi, tracimano di dolci: caramelle, cioccolati, biscotti, dolci
di mandorle e nocciole, mandarini, fichi secchi, noccioline, noci, mandorle
e quanto altro.