|
Modena |
Mutina,
in greco Moutίnh,
im Itin. Geros. 616 auch Mutena, deve le frequenti menzioni, soprattutto
nella storia bellica, alla sua posizione su passi e strade. M. si trova tra i
fiumi Scultenna e Secchia. Dalla valle dello Scultenna il passo di Fiumalbo (1388
m) porta intorno al Monte Cimone; risalendo lo Scultenna si giunge nella valle
del Reno, attraversata oggi da una ferrovia molto importante e dove allora
c’era l’insediamento etrusco di Marzabotto che dominava la valle. Nella valle
della Secchia il passo di Sassalbo (1261) porta a Luna, tra i due fiumi c’è
ancora un terzo valico sull’Appennino verso Lucca. Infine una vecchia strada
porta da M. a Hostilia dove c’era, anche qui, un vecchio passaggio del Po.
Inoltre M. si trovava sulla via Emilia che tagliava quasi ad angolo retto i
fiumi e le valli menzionate, ed era distante 75 mp. da Placentia, 25 mp. da
Bononia e 101 mp. da Ariminum. Se ci si raffigura la pianura padana meridionale
come una mezza ellisse il cui diametro è formato dalla via Emilia, i due fuochi
sono rappresentati da M. e Bononia. Questa città è privilegiata dal suo
migliore collegamento con l’Etruria, quella domina tre passaggi stradali sul Po
(Nissen It. Ldk. II 264). Il collegamento stradale di M. con Hostilia sul Po,
il nodo stradale più importante, è del tempo dell’imperatore Augusto, cioè la
strada è stata terminata allora. Presso S. Martino Carano, 2 km a occidente di
Mirandola, è stata trovata la pietra miliare di Augusto (CIL XI p. 170 nr.
6650). L’Itin. Ant. 282 calcola in 50 mp. la distanza da M. a Hostilia, in eccesso di 10 mp. Lontano 50 km in linea
d’aria da Hostilia si trovava Brixellum, dove c’era l’altro passaggio del
fiume. Da M. si poteva però arrivare a Brixellum sulla strada Cremona-Regium in
35 mp. M. come Felsina = Bononia era senza dubbio una vecchia città degli Etruschi, i cui insediamenti sono stati accertati anche nella valle del Reno. Livio XXXIX 55 sottolinea l’etruschità di M. nell’epoca in cui i Boi celtici conquistarono la pianura. Prima degli Etruschi sono stati probabilmente i Liguri i padroni del territorio poiché accanto agli Etruschi nella città, ai Boi = Celti nella pianura troviamo nelle valli nei dintorni di M. i Liguri e precisamente verso l’Appennino. Questo risulta da Livio XLI 12. 18. Vicino alla città, nella pianura, vengono nominati i Campi Macri, il cui nome sopravvive oggi nel paese di Magreta, 7 km a occidente di Modena (Nissen op. cit.). Essi sono menzionati soprattutto per il mercato bestiame che si teneva qui anno dopo anno fino all’epoca di Nerone: Liv. XLI 18. XXXXV 12. Varr. r. r. 2 praef. VI. Colum. VII 2, 3, Strab. V p. 216 (CIL X 1401 XI p. 170 A = Niessen It. Ldk. II 265). In ogni caso, dunque, a M. c’erano abitanti molto prima dei romani e M. non è una fondazione di questi. L’annessione della città etrusca a Roma avvenne per paura dei Boi e dei Liguri già prima della seconda guerra punica. Ma già nel 183 a.C., come a Parma e Aquileia, furono insediati 2000 cittadini romani i quali, poiché gli antichi abitanti rimasero e nei terreni intorno alla città si erano stabiliti i Boi celtici, poterono ottenere soltanto 5 iugeri di terreno a testa, in totale 2500 ha. (Polyb. I1I 40 Motίnh. Liv. XXI 25; inoltre Liv. XXVII 21. XXXV 4. XLI 12.14.16.18). L’annessione a Roma, che assegnò la località alla tribus Pollia, non la salvò dalle complicazioni che per i Celti dell’Italia settentrionale sorsero dopo la sconfitta di Annibale. Nel 177 i Liguri sono temporaneamente signori della città (Liv.), solo 6 anni da quando M. era diventata colonia romana! Poiché i romani erano in città e i Celti nella pianura, il territorio della colonia non era grande, come mostrano le iscrizioni (CIL XI p. 151). Il confine a ovest era la Secchia, a nord c’era nella zona di Carpi una comunità il cui nome è scomparso; a oriente Otesia vicino a S. Agata. Sulla via Emilia, verso sud est, la piana arrivava fino al Samoggia, che la separava da quella bolognese. Essa comprendeva da questo lato il Vicus Forum Gallorum, presso l’odierna Castelfranco, posto a 8 mp. da M. e 17 da Bononia, dove nell’aprile 43 a.C. Antonio vinse e fu sconfitto; Cic. fam. X 30. Appiano bell. civ. III 70. Frontino strat. II 5, 39. Tab. Peut. Geogr Rav. IV 33. Verso sud ovest si estendeva sicuramente fino a Sassuolo, dove ci sono pozzi di petrolio e un cratere spento (Salsa verso Montegibbio); l’eruzione, alla quale esso deve la sua nascita nel 91 a.C., viene ascritta espressamente come altri fenomeni vulcanici al territorio di M. (Plin. n. h. II 199. 240). Tuttavia, poiché lo stesso contiene un’isola galleggiante (Plin. n. h. II 209) e si sono formati laghi solo vicino alla catena principale, si dovrà supporre che le tribù liguri erano dislocate dalla Secchia e dallo Scoltenna fino allo spartiacque della città. (Nissen) All’epoca della guerra civile, M. era ritenuta
una città solida e bella (Cic. Phil. V 24. Mela II 60) e prospera (Appian.
bell. civ. III 49); qui Antonio assediò D. Bruto dal dicembre 44 fino al 14 aprile 43, dopo che nel 78 a.C. Bruto aveva
assediato Cn. Pompeo, e nel 72 Spartaco Cassio; nel 312 d. C. si svolse qui la
battaglia fra Costantino e Massenzio; inoltre M. fu quartier generale del
senato quando Otone e Vitellio combatterono nel 69 d.C.; Plut. Pomp. 16.
Appiano bell. civ. III 49. Flor. II. 8, 10. Frontino strat. IlI 14, 3,
13, 7, Cass. Dio. XLVI 35 segg. Tac. hist. II 52. Paneg. Lat. X 27. Queste guerre portarono molte sofferenze alla
città poiché dopo la battaglia di Filippi furono insediati anche a M. veterani
romani senza che i cittadini fossero risarciti (cfr. Appiano bell. civ. IV 3. V
5. 12 segg.). Nonostante queste guerre, fra le quali è particolarmente noto il bellum
Mutinense (Suet. Aug. 9. 84. Ovid. Fast. IV 627. Plin. n. h. X 110), M. deve essere annoverata fra
le metropoli dell’antichità; ha dunque avuto più di 50000 abitanti. Nei
dintorni della città, nello ager Mutinensis (Plin n. h. II 199),
prosperava soprattutto buona lana di pecora, alla quale dà risalto Strabone V
218, e vino eccellente lodato da Plinio n. h. XIV 39. Inoltre c’erano le
decantate ceramiche (Pl. n. h. XXXV 101; cfr. inoltre Marziale III 59 und
Blümner nella Ed. Diocl. XIX 13: da Nissen It. Ldk. II 266, 6). Altre menzioni della città: Strab. IV 205. V 216. Tolem. III
1, 46. Nep. Att. 9. Ovid. Met. XV 823. Svet. Aug. 9. Iscrizioni greche: Keibel 2287, 2288. Iscrizioni di soldati: Efem. Epigr.
V p. 255. Iscrizione: CIL XI 148. Anche sotto gli imperatori Costantino e Massenzio
M. riaffermò il suo ruolo di città solida, cfr. Cass. Dio. XLVI 35 segg.
Ammiano Marc. XXXI 9; essa compare anche negli Itinerari: Itin. Ant. Itin.
Geros. Tab. Peut. Geogr. Rav. Ma in epoca longobarda M. si spopola e per essa
pare esserci il nome tedesco Muden (W. Matthias Die geographische
Nomenclatur ltaliens im altdeutschen Schrifttum, Lipsia, 1912, non menziona a
pag. 143 questa forma). Alla fine del VII secolo, poi, il re Cuninchert viene
lodato in una preghiera per una ricostruzione di M. (Carmen de synodo
Ticinensi: appendice a Paolo Diac. hist. Langob. Hannover 1878). Direttamente
in prossimità di M. c’era allora il ricco convento longobardo di Nonantula,
dove Astolfo nel 756 avrebbe portato il corpo di S. Silvestro. Nel 890
Nonantula viene distrutta dagli Ungari. M. venne invece a far parte del dominio
dei signori di Canossa e andò a comporre, insieme con Parma e Reggio, la famosa
eredità di Matilde di Toscana. La battaglia di M.: la battaglia di M. è
collegata inseparabilmente con la doppia battaglia di Forum Gallorum precedente
ad essa. I racconti principali degli avvenimenti sono: Appiano, bell. civ. IlI 66 - 70, che si basa sullo storico
Asinio Pollione; inoltre Cic. fam. X 33, 3 - 4, dove si tratta egualmente di un
resoconto di Asinio Pollione che questi stese più di 40 giorni dopo
l’avvenimento servendosi di comunicazioni orali e rapporti scritti dalla
provincia di Lepido. Inoltre c’è la lettera del cesaricida Ser. Galba Cic. Fam.
X 30, compilata il giorno dopo la battaglia a cui egli aveva partecipato, mentre Cicerone nella Fil. XIV 25-28 indica
come fonti le comunicazioni dei consoli Irzio e Pansa e del propretore Cesare. La situazione prima della battaglia decisiva (nel febbraio 43) è ben delineata da Cic. fam. XII 5, 2, dove Cicerone comunica a Cassio che Antonio stesso stava davanti a M. e aveva dislocato un forte reparto a Bononia per fermare l’esercito dei consoli e di Cesare che accorrevano in aiuto. A M. Dec. Bruto era in gravi angustie e aspettava rinforzi. Irzio sta a Claterna, Cesare vicino a Forum Cornelii, a Roma Pansa arruola ancora truppe fino al 19 marzo. L’Italia settentrionale sta con la repubblica, solo Bononia, Regium Lepidi e Parma, dove comandava Lucio Antonio, stanno con Antonio. Questi decide, dopo un vano tentativo di allacciare un rapporto scritto con Irzio e Cesare, (Cic. Fil. XIII 22 segg.), di sgomberare Claterna e Bononia, perchè è troppo debole per assediare M. e per resistere ai rinforzi. La situazione di Dec. Bruto a M. si fa difficile, perché con le sue 3 legioni (Appiano bell. civ. III 59. Cic. fam. X 33, 5) è molto inferiore ad Antonio. Egli era assediato da 4 mesi per cui le difficoltà di approvvigionamento si erano fatte grandi. Verso “la
fine dell’inverno” avvenne l’avanzata dei rinforzi. Dopo l’entrata in Bononia
lo Scultenna, il fiume presso M., diventa la nuova linea del fronte.
Inutilmente si fecero andare giù per lo Scultenna botti piene di sale e carne
per aiutare gli assediati a M., con i quali si entrò in comunicazione anche
tramite piccioni viaggiatori e segnali luminosi (Frontino Strat. III 13, 7 e III 14, 3-4; cfr. Cass. Dio. XXXXVI 36. Plin
n. h. X 110), vi fu anche un subacqueo che attraversò lo Scultenna portando ai
rinforzi una lettera incisa nel piombo. Cosi come scorre oggi lo Scultenna e
per l’acqua che ha, ciò non è possibile; inoltre non si è completamente
d’accordo sulla identificazione dello Scultenna. M. sta fra i fiumi Secchia e
Panaro, che nascono entrambi dalla montagna con parecchie braccia sorgive e
attraversano la via Emilia. Se si
paragona lo Scultenna alla Secchia, questo andrebbe benissimo poiché il suo
braccio secondario orientale si avvicina a M. e ne è anche attestata la
navigabilità (Dizionario Corografico dell'Italia v. Secchia; stampato in V.
Gardthausen Augustus und seine Zeit II 1, 38). Ma a ragione si obietta (cfr.
Nissen It. Ldk. I 199 seg.),
La strada certa di avvicinamento era la via
Emilia poiché a destra e a sinistra della strada c’era il bosco (Liv.
XXI 25: silvae tunc circa viam erant plerisque incultis), inoltre
il terreno era argilloso, come deduce Gardthausen da Plin. n. h. XXXV 161. A ciò si aggiungevano i fiumi ancora senza
argini che con il loro corso impreciso rendevano difficilmente attraversabile
la campagna discosta dalla strada militare. Anzi, presso Forum Gallorum ( =
Castel Franco) la via Emilia era una diga artificiale che secondo Appiano bell.
civ. III 66-67 conduceva a destra e a sinistra attraverso un terreno paludoso:
schizzo 2. Ma M. non era ancora salva. I repubblicani
unirono le loro truppe contro Antonio che il senato dichiarò “nemico della
patria”. Ovid. fast. IV 627 e anche CIL X 8357 mostrano che ufficialmente fu il
14 aprile il giorno nel quale Cesare vinse Lucio Antonio presso M. (Cic. Fil.
XIV 14, 37. CIL X 3375), quando Lucio assalì lui e Irzio nell’accampamento,
così che Cic. fam. X 30 la datazione iniziale a. d. XVII cal. maggio non è
esatta, la data finale a. d. XII cal. maggio è sbagliata e da modificare perché
nella lettera si intendono due giorni di seguito. Si deve dunque scrivere
all’inizio: a. d. XVIII. cal. maggio e alla fine a. d. XVII cal. maggio. In
ogni caso anche Ottaviano ebbe una parte nel successo, pertanto è falsa
l’osservazione di Antonio (Suet. Aug. 10), che Ottaviano fosse fuggito. Per la
datazione della seconda battaglia combattuta proprio davanti a M., è importante
il fatto che il 5 maggio c’era a Dertona una notizia proveniente da Roma che fu
spedita solo dopo l’arrivo della notizia della battaglia; per il primo tratto
il messaggero impiegò 8 o 9 giorni, per il tratto Mutina-Roma 5/6 giorni, la
battaglia deve dunque essere stata combattuta da 13 a 15 giorni prima del 5
maggio, dunque il 21 o 22 aprile: Bardt spiegazione a Cic. fam. XI 9. Secondo
Drumann I 309, al quale si associa Gardthausen 102, il giorno della battaglia
fu il 27 aprile. Comunque a M. aumentò molto la miseria tanto che Irzio dovette
assolutamente affrettare la battaglia conclusiva mentre Antonio aspettava
nell’accampamento la caduta della fortezza e osservava Irzio con la cavalleria
(Appiano bell. civ. III 71). Ma alla fine Irzio girò intorno all’accampamento,
tenne in scacco coi suoi cavalieri quelli di Antonio e si trasferì verso la
città. Allora Antonio, che voleva aspettare i reparti di Ventidio e Bagienno,
dovette mandargli dietro due legioni. Così si giunse alla seconda battaglia di
M. nella quale Irzio vinse. Mentre la quarta legione di Irzio fu annientata nell’accampamento
dalla quinta legione di Antonio, l’ottava legione di Irzio si fece onore e
ricevette l’appellativo di Mutinensis (CIL X 4786). Irzio cadde ma
Antonio perse aquilas duas, signa LX (Cic. fam. X 30). Secondo Suet.
Aug. 10 Cesare si distinse nella battaglia, salvò la salma del console caduto e
un’aquila della legione, h men strathgiV h KaisaroV apasa diejqarh (Appiano bell, civ. III 69). Contemporaneamente
gli assediati a M. fecero un’efficace sortita della quale (eruptio Mutina)
parla Cic. fam. XI 14, 1, così che in tal modo viene confermata la “falsa
lettera di Bruto“ (ep. IV). Nella sortita cadde un legato di Bruto, Ponzio
Aquila: Cass. Dio XXXXVI 40. Cic. fam. X 33, 4 (così Gardthausen 40). Dunque Antonio trasse le conclusioni da questa
situazione e abbandonò l’assedio di M. La bibliografia sulla battaglia di M. è
raccolta da Gardthausen Augustus und seine Zeit II 1, 36 n. 12. Opere
fondamentali sono: R. Bodewig De proeliis apud Mutinam commissis, Diss. 1866. R. Brielreiher Der
mutinensische Krieg, Progr. 1891. M. v. Hagen Quaestiones criticae de bello
Mutinensi, Diss. 1886. B. Kästner Die Haltung des röm. Senats während d.
Belagerung von Mutina, Progr 1886. Drumann-Groebe 1² 453. Ferrero Größe und
Niedergang Roms, tedesco di Kapff. Bd
III (Stoccarda, 1909) Gurlitt Philol. Suppl. IV 564. Schmidt N. Jahrb. 1892. 323 segg.
Kromayer Hist. Ztschr. XCV 17. La strada Mutina - Bononia: lo schizzo stradale 1
fa vedere che intrico di fiumi e ruscelli incroci la strada Mutina - Bononia;
il principale fra tutti questi fiumi è il Reno. Ancor oggi il letto del Reno è
perlopiù troppo largo per la sottile vena d’acqua che, scorrendo nell’ampio
letto ora sulla riva destra, ora su quella sinistra, crea un gran numero di
punti asciutti, di “isolette”. Gardthausen 129 ha ragione a contestare che i
triumviri si siano incontrati qui, su una di queste isole del Reno. Perciò egli
sposta l’incontro sulla “penisola compresa a est del Reno e a ovest del Lavino
che, unito al Samoggia, sfocia nel Reno. Entrambi nascono vicini l’uno
all’altro sull’Appennino, scorrono poi a destra e a sinistra in cerchio fino
alla via Emilia per poi riunirsi al di là di essa, così che il territorio in
mezzo, su in montagna, è unito al territorio circostante solo in una striscia
(Atti e memor. della R. deputazione di storia
patria per le provincie di Romagna vol. 6, Bologna 1868) dove si riferisce che
nel Reno sono state trovate le fondamenta di un antico ponte, 130 m. a valle
del fiume rispetto al ponte moderno. Ciò fisserebbe il corso della via Emilia
Bononia-Mutina. L’obiezione che si tratterebbe allora non di un’isola ma di una
penisola viene respinta da Gardthausen con sufficienti motivi, p. es. Polib.
III 49, 5 e Livio XXI 31, 4 parlano nello stesso senso della insula
Allobrogum. Si intende con Appiano op. cit. il ponte sul Lavinius, non
quello sul Reno a Bononia. Sull’antico corso del Reno: St. Fischer Die
Schicksalswege des italienischen Rheins (Reno): Mitt. d. k. k. Geogr. Ges. Wien 1888, 2, 65. Dizionario corografico s.
Reno e il mio articolo Renus. [Hans Philipp] |

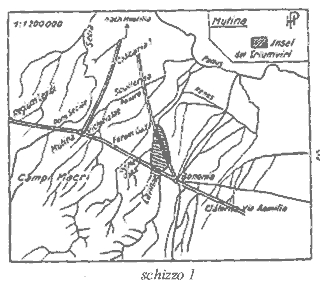 che ormai il nome dello Scultenna: Scoltenna
corrisponde “al braccio sorgentifero occidentale del Panaro”, che taglia la via
Emila a oriente di Modena presso S. Ambrogio. Anche Paolo Diac. Hist. IV 44 menziona
questo fluvius Aemiliae qui Scultenna dicitur, senza che con questo sia
assicurata l’identificazione Scultenna = Panaro. Il menzionato Dizionario
corografico dell’Italia identifica Scoltenna anche col braccio del Panaro “in
vicinanza al villaggio della Tagliole”. Allora si è costretti a supporre che
anche questi affluenti del Po, come tanti altri, abbiano mutato il loro corso
nella pianura padana così che il “braccio del Panaro Scoltenna” avesse una
maggior portata d’acqua e scorresse più vicino a M.: cfr. lo schizzo 1.
che ormai il nome dello Scultenna: Scoltenna
corrisponde “al braccio sorgentifero occidentale del Panaro”, che taglia la via
Emila a oriente di Modena presso S. Ambrogio. Anche Paolo Diac. Hist. IV 44 menziona
questo fluvius Aemiliae qui Scultenna dicitur, senza che con questo sia
assicurata l’identificazione Scultenna = Panaro. Il menzionato Dizionario
corografico dell’Italia identifica Scoltenna anche col braccio del Panaro “in
vicinanza al villaggio della Tagliole”. Allora si è costretti a supporre che
anche questi affluenti del Po, come tanti altri, abbiano mutato il loro corso
nella pianura padana così che il “braccio del Panaro Scoltenna” avesse una
maggior portata d’acqua e scorresse più vicino a M.: cfr. lo schizzo 1.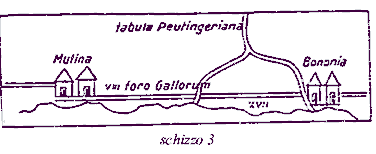 sottile”.
sottile”. 