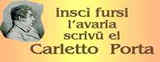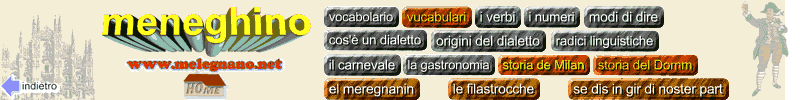|
Cos'è
un dialetto
Dal punto
di vista glottologico ed espressivo, non c'è alcuna differenza tra
lingua letteraria e dialetto: entrambe hanno una formazione storica dovuta
a fattori assai complessi, anche se i dialetti esprimono una tradizione
di cultura e letteratura meno complessa ed autorevole. Perciò è
errato ritenere che i dialetti siano una degradazione della lingua letteraria.
La verità è che tra il concetto di "dialetto" e l'altro di
"lingua letteraria" esiste solo un rapporto logico, per cui l'una cosa
non può intendersi senza l'altra, tanto che sarebbe assurdo parlare
di dialetto senza presupporre una lingua nazionale e viceversa. Sono false
polemiche, quindi, quelle sulla maggior o minor espressività della
lingua o dei dialetti, quando deve esser chiaro che l'espressività
deriva solo dallo spirito dei parlanti. Per letteratura dialettale intendiamo
un complesso di opere letterarie composte in una particolare lingua che
diciamo appunto dialetto, rispetto alla lingua nazionale. Il dialetto può
essere regionale o urbano, cittadinesco o rustico, a testimonianza della
estrema varietà in relazione al luogo. D'altra parte appare in essi
evidente la tendenza ad una koinè linguistica, ovvero una spinta
verso un tipo di cultura e di sensibilità più larga ed aperta,
che è tendenza imprescindibile di ogni atto di comunicazione o espressivo,
specie se artistico. Alcuni temi sono prevalenti o prediletti nella letteratura
dialettale, come per esempio la poesia del ridere nelle sue più
varie forme, il carattere ridanciano, comico, burlesco, eroicomico; la
produzione dialettale moderna è piuttosto lirica e drammatica, e
di una drammaticità non soltanto comica o farsesca, ma anche seria
e percorsa da acuti problemi psicologici e morali, e persino tragica. Gli
studi intorno alle letterature dialettali in Italia sono gravemente deficienti,
non abbiamo indagini critiche apprezzabili, mancano studi sistematicamente
e organicamente condotti intorno alle vicende delle singole letterature
dialettali. Prima dell'unità, in Italia, esistevano essenzialmente
la lingua letteraria, prevalentemente scritta e conosciuta da una ristretta
cerchia di borghesi, e una vasta moltitudine di dialetti urbani e rurali.
In seguito all'unità, il processo di nazionalizzazione della lingua
complica la realtà linguistica italiana; non avverrà infatti,
come auspicato dal Manzoni, che una lingua già strutturata si imponga
sulle altre. La diffusione della lingua letteraria subisce numerose contaminazioni
e influssi dovuti alle aree geografiche dialettali segnando una miriade
di varietà linguistiche, registri e livelli d'uso. Tanto che dopo
l'unità a lungo i maestri elementari specie delle zone rurali, per
scarsa preparazione culturale e per necessità di farsi intendere
dagli allievi, continuavano ad usare i dialetti locali. È questo
l'italiano popolare, una varietà dell'italiano utilizzata da persone
per lo più di basso ceto sociale, scarsamente acculturate, nel momento
in cui per varie ragioni abbandonano il dialetto. Rimane così viva
e vitale la realtà dei dialetti regionali e locali, condannati allora
dalle istituzioni, considerati oggi invece una parte importante della tradizione
linguistica nazionale. Il dialetto fece la sua prima comparsa con il neorealismo,
in seno all'esigenza di una letteratura realisticamente documentaria e
di una letteratura nazional-popolare, secondo la tendenza ad utilizzare
un linguaggio semplice, disadorno, antiletterario. |