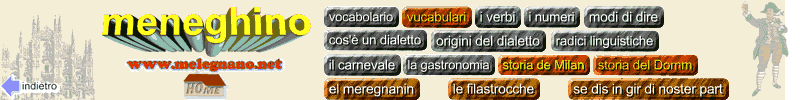Meneghin:
la maschera milanese Meneghin:
la maschera milanese
da
"Il Carnevale Meneghino e Carlo Maria Maggi" di
Vitantonio Palmisano
La vita che conduceva gran parte
degli italiani nel XVIII° secolo era solitamente austera, ma in certi
momenti dell'anno si faceva più lieta, specie durante il carnevale.
Con altre più serie ricorrenze si offriva la possibilità
di soddisfare quel gusto della scenografia nei cortei o nelle processioni
interminabili e pompose alle quali erano di pretesto l'insediamento di
Un nuovo cardinale, la visita di un grande personaggio o la sua morte,
oltre ad un'infinità di altre ricorrenze religiose. Il carnevale
milanese prevedeva una mascherata molto particolare, che aveva per protagonisti
i membri di una delle innumerevoli accademie che pullulavano in Italia,
quella dei Facchini della Valle del Blenio, formata da artisti e gentiluomini
completamente estranei alla professione da cui prendevano il nome. In realtà
gli abitanti della valle del Blenio abitualmente scendevano numerosi dalle
loro montagne a Milano per fare davvero i facchini. Le maschere dei facchini
partecipavano, quindi, in abiti di panno grigio e cappello dello stesso
colore con un grande pennacchio, e alla cintura si annodavano un grembiule
ricamato d'oro e d'argento con gli emblemi di ogni categoria di facchini.
Un sacco sulle spalle e una maschera sul viso completavano poi il travestimento.
La stirpe ambrosiana però ebbe a prediligere la sua identificazione
nella maschera di "Meneghino", ritenuta da alcuni una creazione di Carlo
Maria Maggi. Il Maggi nacque a Milano il 3 maggio 1630 e lì morì
il 22 aprile 1699 lasciando pubblicati 626 sonetti, 189 canzoni. 140 componimenti,
8 melodrammi per musica, 5 tragedie, 86 prologhi, intermezzi e frammenti
drammatici, 286 componimenti latini, 122 traduzioni italiane dal greco,
7 canzoni in lingua spagnola, 44 componimenti diversi in dialetto milanese
e 5 commedie italiane con parlate milanesi di quel Meneghino ch'egli fu
il primo ad introdurre nel teatro e nella letteratura dialettale lombarda.
Quanto all'origine dei nome, si fanno diverse ipotesi di cui la più
persuasiva è quella che vorrebbe far risalire il nome Meneghino
da un adattamento di "Domenichino" o meglio un'aferesi di Domenichino.
Domenichino era attribuito a quel servo che veniva ingaggiato solo per
i servizi domenicali; era infatti uso frequente dei milanesi, per ostentare
dovizia di personale nel giorno delle visite e dei ricevimenti, assumere
per la sola domenica un servo. Meneghin era quindi un servo di gente mediocremente
provveduta e ambiziosa: ne abbiamo riscontro nel ruolo divertente del Meneghin
biroeu di ex monegh di Carlo Porta. Altre
ipotesi riconducono a Meneghino quale diminutivo di Domenico (Menico, Menechino);
indicando in Domenico il nome che un tempo sarebbe stato proverbiale per
i servitori: non molto diverso quindi dall'odierno Battista. L'origine
del nome di questa "maschera", anzi di questo tipo umano, è quindi
attribuita al Maggi: egli ne ha fatto un servo ora sciocco, ora accorto,
mai furbo, devoto ai padroni, servizievole, virtuoso, che fa il suo dovere,
dà consigli di prudenza, o si lascia infinocchiare per dabbenaggine,
sempre però simpatico e di animo generoso. Fatto sta che Meneghino,
da personaggio principale del teatro dialettale milanese, affiancato in
un secondo tempo alla compagna Cecca, si trasforma in tipico rappresentante
dell'anima popolare milanese. Anche il cognome di Meneghino Pecenna ha
origini dibattute: derivato quasi certamente dal verbo milanese peccenà
affine a pettenà e significante, appunto, "pettinare". Sicchè
Meneghino sarebbe per antonomasia "colui che pettina". Ma resta poi da
stabilire Se il verbo vada inteso in senso proprio, e allora alle funzioni
dei servo si aggiungerebbero quelle, e non sappiamo perchè, del
parrucchiere, oppure si tratti di pettinature figurate: cioè, rabbuffi,
prediche mordaci, esplosioni di indignata ironia. E in questo caso, più
accettabile, avremo l'idea programmatica di una creatura pronta al sarcasmo,
alla satira didattica. Non ci rimane ora che parlare del "carnevale" come
divertimento popolare, anche se mi rendo conto che non è più
possibile fare confronti tra il carnevale di un tempo, seppur non molto
distante da noi, e quello di oggi: sarebbe un errore grossolano cercare
dei confronti. Oggi il carnevale è diventato una festa come tutte
le altre; nei tempi passati era una delle feste più caratteristiche,
rumorose, nella quale la gente dava libero sfogo alla sfrenata passione
per il divertimento e l'allegria. Ho cercato di raccogliere frammenti e
storia di tutte quelle feste tradizionali che andavano sotto il nome di
carnevale, mettendo insieme quel poco che ci è rimasto al fine di
conservarle e non perderne la memoria. Un tempo, relativamente lontano,
il passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile transitava attraverso
il carnevale e ciò determinava, in un certo senso, la cancellazione
dei mali e delle privazioni della brutta stagione e nel medesimo tempo
il rifiorire delle speranze per il rinascere della primavera. Per liberarsi
delle vecchie angustie ed appropriarsi di nuove speranze si usava bruciare
il carnevale sull'aia o sulla piazza principale del paese: un carnevale
fatto di stracci e riempito di foglie secche di granoturco che veniva issato
su una catasta di foglie e di legna; veniva quindi dato fuoco mentre la
folla ballava intorno cantando una filastrocca bene augurante. Sempre a
carnevale, ultimo giorno dedicato all'allegria ed alla spensieratezza,
in Val Padana si usava altresì rompere le pentole di terracotta
sulla piazza del paese. Le pentole, che erano riempite di dolci e regali,
una volta rotte da un giovane armato di bastone e con gli occhi bendati,
lasciavano cadere a terra tutto il loro contenuto: ogni persona poteva
rompere una sola pentola e se il contenuto era fatto di cose buone anche
l'anno le sarebbe stato propizio, ma se conteneva cenere o carbone, l'anno
sarebbe stato sicuramente non dei più felici. Per divertirsi poi
nei giorni dei carnevale i nostri avi erano disposti ad impegnarsi anche
economicamente con un oggetto di valore o altro pur di comperarsi un vestito
da pagliaccio o per partecipare , a pieno titolo, ad una cena o una serata
di ballo mascherato sulla pubblica piazza, diventando almeno per una volta
in un anno protagonisti. cancellando così. per pochi giorni, i restanti
periodi di sofferenze e di umiliazioni. Era altresì uso effettuare
anche il pranzo di carnevale che doveva essere necessariamente a base di
salumi, faticosamente salvati dall'inverno appena trascorso. Si pensava
anche che a carnevale i "morti si facevano vivi" o meglio si credeva essere
certa la presenza dei morti nelle campagne lombarde proprio al fine di
stare vicini ai parenti in un periodo di gioie e di allegria; una metafora
per liberare i viventi in modo definitivo e sicuro dalle mortificazioni
e patimenti dell'inverno. Il carnevale infine era, nei secoli passati l'ultima
opportunità di abbondanti mangiate e bevute preludio di un periodo
di digiuno pre-primavera cioè prima della lunga astinenza quaresimale
proprio forse per renderla meno insopportabile. |
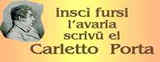


 Meneghin:
la maschera milanese
Meneghin:
la maschera milanese