| melegnano.net |
|
|
pag.
2 |
A pochi metri dalla via Emilia,
tra il verde dei campi e le nuove abitazioni della periferia, quasi lambita
dalle tranquille acque del Lambro, in una zona che anticamente era invidiata
per la pace e dolce romitaggio, sorge, modesta ed austera, la chiesa del
Carmine.  La
sua storia, raccolta faticosamente dai documenti monumentali e letterari
si e snodata, ora umile, ora gloriosa attraverso tutti i secoli, dal periodo
carolingio ad oggi, sempre partecipe delle ore liete e dolorose di Melegnano.
La primitiva costruzione della chiesa, forse una semplice cappelletta, non
è più rintracciabile dalla indagine topografica. Tuttavia
sappiamo che nell'anno 836, durante il Sacro Romano Impero, un ricco personaggio
chiamato Unger, abitante in Milano, volle, nel mese di febbraio, assegnare
molti suoi beni per la istituzione di opere pie: i suoi beni erano distribuiti
nella Bassa Milanese e nel Pavese, ai borghi di Gnignano, Maiano, Carpiano
e Melegnano. Il ricco possidente Unger dona alcuni campi perché nel
"borgo di Meloniano venga istituita una casa del pellegrino dedicata a San
Giuseppe e a Maria". Non si tramanda nulla della vita di questa benefica
istituzione. Tuttavia è probabile che doveva essere fuori delle mura
della città, perchè i cittadini volevano cautelarsi contro
ogni contagio e malattia che veniva diffusa dai viaggiatori; inoltre, una
casa del pellegrino, detta anche foresteria, era quasi sempre istituita
accanto ad una chiesa o cappella, perché, assieme alle cure materiali
e corporali, i pellegrini ricevessero anche quelle spirituali e morali;
ma in Melegnano l'unica chiesa o cappella esistente fuori le mura, a ricordo
d'uomo e di documentazione, era l'attuale chiesa del Carmine. Più
tardi, in un periodo non precisabile, forse dopo il Mille, la nostra chiesa
è chiamata "san Bartolomeo fuori le mura", ed anche "San Bartolomeo
in corte", cioè era una chiesa fuori dal vero abitato cittadino,
fuori dal Borgo di Melegnano chiuso nel circuito delle antiche mura di difesa
entro cui troneggiava il castello. Ed un santo eremita, nel 1210,
Gualtiero da Lodi, vi istituisce un piccolo ospedale per il ricovero degli
ammalati. Ad ogni modo, l'opera benefica dovette essere fiorente per molti
anni, se il ricordo si è tramandato nei secoli. Ma bisogna pur dire
che la piccola chiesa era testimone, talvolta impotente, delle vicende che
nell'alto Medioevo accadevano a Melegnano e nella Bassa Milanese, Anzitutto
gli straripamenti del fiume Lambro che correva disordinatamente negli avvallamenti
dei campi, visibili ancora attraverso il piano irregolare di sedimentazione
ai fianchi della odierna valle fluviale in zona Cimitero, Carmine, Ricovero
Vecchi, Cappuccina, termine di via Cavour e zona Servi. Nell'anno
871 il cronista Andrea Presbiter ricorda che nella landa tra il lodigiano
e il milanese, quindi nei campi melegnanesi, si lanciarono nubi di cavallette
e di locuste che per diversi giorni completamente indisturbate, a dense
torme, quasi novelli barbari, consumarono i grani ed i frutti dei campi
sotto gli occhi dei contadini. Dall'anno 899 al 900 gli Ungheresi
devastano le nostre belle distese di prati, tornando nuovamente assetati
di rapina ed avidi di grassi raccolti nel 921. Il cronista Regino, loro
contemporaneo, scrive che "essi violano e saccheggiano le chiese, profanano
empiamente le sacre reliquie, bruciano le messi massacrano i maschi, mutilano
i fanciulli: questi Slavi, gente ferocissima e più crudele delle
belve, desiderano solo rapinare, far bottino, uccidere". L'opera cristiana
di San Gualtiero quindi fu una provvidenza durante e dopo periodi di terrore
e di stragi. Il Magistretti in Liber Notitiae sanctorum Mediolani,
databile nel 1304, stampato a Milano nel 1917, riporta, a pagina 234, una
notizia che ci può interessare da vicino, ma la cui interpretazione
è ardua: "Nella pieve di san Giuliano, all'ospedale di Melegnano
vi è la chiesa di santa Maria Maddalena" (In
plebe sancti Iuliani, ad Hospitale Meregnani, ecclesiae sancte Marie Magdalene).
Forse è la nostra chiesa del Carmine, dal momento che l'ospedale
esistente era quello di San Gualtiero; tuttavia non sappiamo nulla sul motivo
della dedicazione a Maria Maddalena. Che la chiesa di santa Maria
Maddalena sia la chiesa attuale del Carmine può dedursi dal fatto
che il culto a santa Maria Maddalena esistette solo nella chiesa del Carmine:
ma più tardi Santa Maria Maddalena del Vangelo fu forse scambiata
in santa Maria Maddalena de' Pazzi, carmelitana. La notizia di un
ospedale dedicato a santa Maria Maddalena è dell'anno 1304. La
sua storia, raccolta faticosamente dai documenti monumentali e letterari
si e snodata, ora umile, ora gloriosa attraverso tutti i secoli, dal periodo
carolingio ad oggi, sempre partecipe delle ore liete e dolorose di Melegnano.
La primitiva costruzione della chiesa, forse una semplice cappelletta, non
è più rintracciabile dalla indagine topografica. Tuttavia
sappiamo che nell'anno 836, durante il Sacro Romano Impero, un ricco personaggio
chiamato Unger, abitante in Milano, volle, nel mese di febbraio, assegnare
molti suoi beni per la istituzione di opere pie: i suoi beni erano distribuiti
nella Bassa Milanese e nel Pavese, ai borghi di Gnignano, Maiano, Carpiano
e Melegnano. Il ricco possidente Unger dona alcuni campi perché nel
"borgo di Meloniano venga istituita una casa del pellegrino dedicata a San
Giuseppe e a Maria". Non si tramanda nulla della vita di questa benefica
istituzione. Tuttavia è probabile che doveva essere fuori delle mura
della città, perchè i cittadini volevano cautelarsi contro
ogni contagio e malattia che veniva diffusa dai viaggiatori; inoltre, una
casa del pellegrino, detta anche foresteria, era quasi sempre istituita
accanto ad una chiesa o cappella, perché, assieme alle cure materiali
e corporali, i pellegrini ricevessero anche quelle spirituali e morali;
ma in Melegnano l'unica chiesa o cappella esistente fuori le mura, a ricordo
d'uomo e di documentazione, era l'attuale chiesa del Carmine. Più
tardi, in un periodo non precisabile, forse dopo il Mille, la nostra chiesa
è chiamata "san Bartolomeo fuori le mura", ed anche "San Bartolomeo
in corte", cioè era una chiesa fuori dal vero abitato cittadino,
fuori dal Borgo di Melegnano chiuso nel circuito delle antiche mura di difesa
entro cui troneggiava il castello. Ed un santo eremita, nel 1210,
Gualtiero da Lodi, vi istituisce un piccolo ospedale per il ricovero degli
ammalati. Ad ogni modo, l'opera benefica dovette essere fiorente per molti
anni, se il ricordo si è tramandato nei secoli. Ma bisogna pur dire
che la piccola chiesa era testimone, talvolta impotente, delle vicende che
nell'alto Medioevo accadevano a Melegnano e nella Bassa Milanese, Anzitutto
gli straripamenti del fiume Lambro che correva disordinatamente negli avvallamenti
dei campi, visibili ancora attraverso il piano irregolare di sedimentazione
ai fianchi della odierna valle fluviale in zona Cimitero, Carmine, Ricovero
Vecchi, Cappuccina, termine di via Cavour e zona Servi. Nell'anno
871 il cronista Andrea Presbiter ricorda che nella landa tra il lodigiano
e il milanese, quindi nei campi melegnanesi, si lanciarono nubi di cavallette
e di locuste che per diversi giorni completamente indisturbate, a dense
torme, quasi novelli barbari, consumarono i grani ed i frutti dei campi
sotto gli occhi dei contadini. Dall'anno 899 al 900 gli Ungheresi
devastano le nostre belle distese di prati, tornando nuovamente assetati
di rapina ed avidi di grassi raccolti nel 921. Il cronista Regino, loro
contemporaneo, scrive che "essi violano e saccheggiano le chiese, profanano
empiamente le sacre reliquie, bruciano le messi massacrano i maschi, mutilano
i fanciulli: questi Slavi, gente ferocissima e più crudele delle
belve, desiderano solo rapinare, far bottino, uccidere". L'opera cristiana
di San Gualtiero quindi fu una provvidenza durante e dopo periodi di terrore
e di stragi. Il Magistretti in Liber Notitiae sanctorum Mediolani,
databile nel 1304, stampato a Milano nel 1917, riporta, a pagina 234, una
notizia che ci può interessare da vicino, ma la cui interpretazione
è ardua: "Nella pieve di san Giuliano, all'ospedale di Melegnano
vi è la chiesa di santa Maria Maddalena" (In
plebe sancti Iuliani, ad Hospitale Meregnani, ecclesiae sancte Marie Magdalene).
Forse è la nostra chiesa del Carmine, dal momento che l'ospedale
esistente era quello di San Gualtiero; tuttavia non sappiamo nulla sul motivo
della dedicazione a Maria Maddalena. Che la chiesa di santa Maria
Maddalena sia la chiesa attuale del Carmine può dedursi dal fatto
che il culto a santa Maria Maddalena esistette solo nella chiesa del Carmine:
ma più tardi Santa Maria Maddalena del Vangelo fu forse scambiata
in santa Maria Maddalena de' Pazzi, carmelitana. La notizia di un
ospedale dedicato a santa Maria Maddalena è dell'anno 1304. 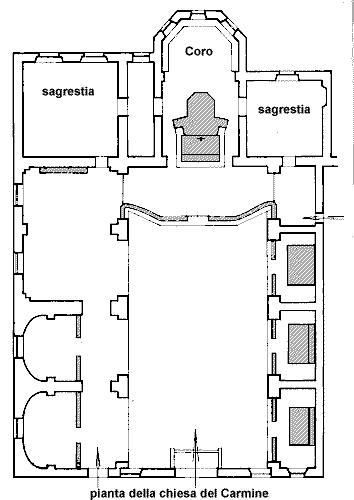 Ma
non sappiamo con precisione gli avvenimenti che prepararono all'entrata
dei frati Carmelitani nel 1393: essi occuparono quel luogo ritirato e pieno
di pace per fondarvi il loro convento, servendosi dell'antica chiesa per
le sacre funzioni, e la posero sotto l'invocazione della Vergine Annunciata.
Pochi anni dopo, il miracolo accaduto ad una fanciulla, che nella caduta
rompe le uova e, invocando la Madonna, le ritrova intatte, come si legge
negli Annali del Carmelo, avrebbe istillato nel popolo la maggior devozione
alla Madonna, E' di questo periodo la prima donazione ai frati di 40 pertiche
di terra vicino alla chiesa, secondo la testimonianza del priore del convento
Gerolamo Del Monte che, nel 1671, compila il Libro campione delle proprietà
del convento del Carmine di Melegnano; questo priore chiama la chiesa del
Carmine con il nome di "Ospitale di santa Maria risana l'ovo". Dal
1393, anno fondamentale per la nostra storia, lo sviluppo sociale ed economico
di Melegnano, in verità molto lento e modestissimo, coinvolge anche
la chiesa del Carmine. Infatti il 9 luglio 1442 questa chiesa cessa di essere
autonoma e viene aggregata con altre per formare la parrocchia di San Giovanni
in Melegnano: la chiesa, dedicata a santa Maria, con l'ospedale dedicato
a santa Maria Maddalena, è ancora chiamata "San Bartolomeo in corte".
Con il passare del tempo i frati costruirono il convento, con un triplice
porticato, ampliarono la chiesa e conservarono nell'abside l'antica costruzione.
Ed aumenta il beneficio dei beni del convento: nel 1524, il giorno 11 luglio,
alla Confraternita della Beata Vergine del Carmine, la famiglia De Capitani
di Landriano lascia, per testamento, una somma di denaro per assicurare
un ufficio funebre annuale ed una messa settimanale in perpetuo. Già
nel 1579 nel convento vi abitavano cinque frati che celebravano messa ogni
mattino e due frati laici per la direzione della sacristia e del convento:
il convento però era stato costruito perchè potesse ospitare
bon quindici frati. Nei 1588 viene firmata una convenzione tra il
Priore del convento e Gabriele De Martini con la quale si rinuncia ad una
lite relativa al possesso di un pezzo di terra di 16 pertiche al Costigè,
con l'obbligo reciproco di stabilire la divisione per mezzo di un amico
comune; ed ancora il giorno 11 maggio 1591 i padri Carmelitani acquistano
duo pertiche di terra nel territorio di Vizzolo. Però la proprietà
e l'amministrazione dei beni non erano senza preoccupazioni e affanni:
nel 1592 dove intervenire perfino il papa Clemente VIII° che dà
disposizioni al parroco di Melegnano per dirimere una lite tra i "padri
del convento dell'Annunciazione della Beata Maria, della terra di' Meregnano,
dell'Ordine dei frati della medesima Maria del Monte Carmelo, della Diocesi
di Milano" ed i membri della famiglia Bondioli. Il patrimonio immobiliare
aumenta sempre più: il 31 luglio 1629 il melegnanese Fernando Bussori
lascia per testamento ai padri del Carmine una casa con orto di 7 pertiche,
poste a fianco della chiesa del Carmine, con peso annuo di un canone da
versarsi al provosto ed ai canonici curati della chiesa di San Giovanni.
Ed in due secoli, i frati del Carmine si videro proprietari di una ricchezza
terriera non indifferente: i campi erano lavorati dai contadini che dipendevano
direttamente dal convento; erano allevati animali da cortile; ed i prodotti
alimentavano il mercato agricolo di Melegnano e Milano; abbiamo però
anche notizia di terreni dati in affitto. La principale occupazione
dei frati era la chiesa e l'amministrazione dei sacramenti nella cura delle
anime con la predicazione anche nei dintorni. Nel 1600 i frati da cinque,
divennero sei e poi sette: essi ottennero dal papa Alessandro VII°,
nel 1660, con lettera su pergamena, il beneficio dell'altare privilegiato,
per sette anni; non risulta se dopo tale periodo il privilegio sia stato
ancora richiesto. Continua sempre la buona condizione economica: il
3 luglio 1645 viene acquistata una casa in centro a Melegnano, e un altro
terreno di 12 pertiche vicino allo stesso convento; il 1° luglio 1665
si contratta e si compera un terreno di 7 pertiche, chiamato il Vignolo,
a fianco ancora del convento, con l'aiuto dei Fabbricieri della chiesa di
San Giovanni che riscattano il terreno dal canone Ma
non sappiamo con precisione gli avvenimenti che prepararono all'entrata
dei frati Carmelitani nel 1393: essi occuparono quel luogo ritirato e pieno
di pace per fondarvi il loro convento, servendosi dell'antica chiesa per
le sacre funzioni, e la posero sotto l'invocazione della Vergine Annunciata.
Pochi anni dopo, il miracolo accaduto ad una fanciulla, che nella caduta
rompe le uova e, invocando la Madonna, le ritrova intatte, come si legge
negli Annali del Carmelo, avrebbe istillato nel popolo la maggior devozione
alla Madonna, E' di questo periodo la prima donazione ai frati di 40 pertiche
di terra vicino alla chiesa, secondo la testimonianza del priore del convento
Gerolamo Del Monte che, nel 1671, compila il Libro campione delle proprietà
del convento del Carmine di Melegnano; questo priore chiama la chiesa del
Carmine con il nome di "Ospitale di santa Maria risana l'ovo". Dal
1393, anno fondamentale per la nostra storia, lo sviluppo sociale ed economico
di Melegnano, in verità molto lento e modestissimo, coinvolge anche
la chiesa del Carmine. Infatti il 9 luglio 1442 questa chiesa cessa di essere
autonoma e viene aggregata con altre per formare la parrocchia di San Giovanni
in Melegnano: la chiesa, dedicata a santa Maria, con l'ospedale dedicato
a santa Maria Maddalena, è ancora chiamata "San Bartolomeo in corte".
Con il passare del tempo i frati costruirono il convento, con un triplice
porticato, ampliarono la chiesa e conservarono nell'abside l'antica costruzione.
Ed aumenta il beneficio dei beni del convento: nel 1524, il giorno 11 luglio,
alla Confraternita della Beata Vergine del Carmine, la famiglia De Capitani
di Landriano lascia, per testamento, una somma di denaro per assicurare
un ufficio funebre annuale ed una messa settimanale in perpetuo. Già
nel 1579 nel convento vi abitavano cinque frati che celebravano messa ogni
mattino e due frati laici per la direzione della sacristia e del convento:
il convento però era stato costruito perchè potesse ospitare
bon quindici frati. Nei 1588 viene firmata una convenzione tra il
Priore del convento e Gabriele De Martini con la quale si rinuncia ad una
lite relativa al possesso di un pezzo di terra di 16 pertiche al Costigè,
con l'obbligo reciproco di stabilire la divisione per mezzo di un amico
comune; ed ancora il giorno 11 maggio 1591 i padri Carmelitani acquistano
duo pertiche di terra nel territorio di Vizzolo. Però la proprietà
e l'amministrazione dei beni non erano senza preoccupazioni e affanni:
nel 1592 dove intervenire perfino il papa Clemente VIII° che dà
disposizioni al parroco di Melegnano per dirimere una lite tra i "padri
del convento dell'Annunciazione della Beata Maria, della terra di' Meregnano,
dell'Ordine dei frati della medesima Maria del Monte Carmelo, della Diocesi
di Milano" ed i membri della famiglia Bondioli. Il patrimonio immobiliare
aumenta sempre più: il 31 luglio 1629 il melegnanese Fernando Bussori
lascia per testamento ai padri del Carmine una casa con orto di 7 pertiche,
poste a fianco della chiesa del Carmine, con peso annuo di un canone da
versarsi al provosto ed ai canonici curati della chiesa di San Giovanni.
Ed in due secoli, i frati del Carmine si videro proprietari di una ricchezza
terriera non indifferente: i campi erano lavorati dai contadini che dipendevano
direttamente dal convento; erano allevati animali da cortile; ed i prodotti
alimentavano il mercato agricolo di Melegnano e Milano; abbiamo però
anche notizia di terreni dati in affitto. La principale occupazione
dei frati era la chiesa e l'amministrazione dei sacramenti nella cura delle
anime con la predicazione anche nei dintorni. Nel 1600 i frati da cinque,
divennero sei e poi sette: essi ottennero dal papa Alessandro VII°,
nel 1660, con lettera su pergamena, il beneficio dell'altare privilegiato,
per sette anni; non risulta se dopo tale periodo il privilegio sia stato
ancora richiesto. Continua sempre la buona condizione economica: il
3 luglio 1645 viene acquistata una casa in centro a Melegnano, e un altro
terreno di 12 pertiche vicino allo stesso convento; il 1° luglio 1665
si contratta e si compera un terreno di 7 pertiche, chiamato il Vignolo,
a fianco ancora del convento, con l'aiuto dei Fabbricieri della chiesa di
San Giovanni che riscattano il terreno dal canone  annuo
di lire otto. E questa proprietà permette ai frati di concedere un
mutuo ad una certa Vittoria Del Monte di mille fiorini. Il peso amministrativo
dunque divenne sensibile ed occorreva una revisione o almeno una precisa
amministrazione: ed essa venne attuata nel 1671 dal priore Gerolamo Del
Monto che compila il "libro campione" di tutti i beni del convento: il citato
priore non immaginava che cento anni dopo la sua fatica ed i suoi beni sarebbero
stati confiscati da mani estranee. E nell'anno seguente, il 1672, ancora
viene acquistato un terreno di 20 pertiche al Ponte di Milano. Nella lunga
permanenza in convento i padri si meritarono la stima e l'affetto dei melegnanesi
che li onoravano con protezione e benefici. Ed anche molti melegnanesi illustrarono
l'Ordine Carmelitano: Carlo Caraccioli figlio del tenente generale Andrea
e di Andronica De Medici, che fu uomo di vasta cultura e salì per
tutti i gradi dell'Ordine e venne consacrato vescovo di Bobbio, ed il suo
ritratto si conserva nella sacristia parrocchiale; Carlo Cornegliano e Giovanni
Spernazzatì, che furono padri Provinciali dell'Ordine. E nel
secolo 1700 le donazioni continuano: il 3 marzo del 1710 Gerolamo Spernazzati
dona al convento un orto di una pertica vicino alla piazza della chiesa
prima in possesso di Giuseppe Montorfano. I padri del Carmine erano
dunque tenuti in alta considerazione: la chiesa era ufficiata regolarmente;
i sacramenti distribuiti in abbondanza e la partecipazione dei melegnanesi
era notevolissima; non solo da parte dei poveri, ma anche dei benestanti,
alcuni dei quali vollero essere sepolti in chiesa, come fu di un certo Ambrogio
Corneliani nel 1722. Essi erano anche invitati alle funzioni in parrocchia
e partecipavano della vita della chiesa di san Giovanni: una volta, nel
1725, inviano perfino una protesta allo stesso parroco della chiesa di San
Giovanni per differente trattamento in un funerale. E' in questo secolo,
il 1700, in cui si sviluppano le pratiche di pietà rimaste ancora
fino ai nostri giorni: novene; feste ai santi dell'ordine Carmelitano; tridui
di predicazione; particolari celebrazioni liturgiche. Melegnano era in continuo
aumento, ed i bisogni spirituali erano ancor più richiesti. Messe
cantate, benedizioni eucaristiche, uffici funebri, processioni, recita in
coro del breviario, lavoro e spiegazione del catechismo: queste le benemerenze
dei nostri frati, anche se il solito peso dell'amministrazione dei beni
poteva insinuarsi nel loro impegno spirituale: il 1° aprile 1716 viene
preso in affitto per 35 anni un pezzo di terra di 8 pertiche al Costigé,
l'11 settembre 1744 sono acquistate 68 pertiche di terra detta la vigna
di San Francesco, più altre 60 pertiche di un terreno denominato
La Brasca, e nel 1751 il convento acquista un prato denominato il Prato
del restello, dai Montorfani, di 12 pertiche. Il sano e robusto
patrimonio immobiliare, che ormai diventava ampio, può permettere
al convento di concedere ulteriori prestiti di forti somme. Le continue
lotte, i transiti militari e la permanenza di truppa, portarono un forte
peso al bilancio comunale. I promessi aiuti governativi non arrivavano mai,
ed il Comune si vide costretto a chiedere prestiti per far fronte alle spese:
il convento del Carmine concede, nel 1762 lire 3000 al 3% e lire 3000 al
4,10%, in prestito chiesto dai Sindaci della Comunità di Melegnano.
E due anni più tardi, nel 1764 il priore dei frati, Alessandro Granata,
può concedere una sovvenzione di 400 zecchini gigliati fiorentini,
all'interesse del 4%, alla famiglia Montorfani che versava in difficoltà
economiche. Ed è sempre in aumento il culto alla Vergine: nel
1771 il 28 giugno, il padre Alberto Maria Ercolini, procuratore nella Curia
Romana e Commissario Generale dei frati di tutto l'Ordine Carmelitano, concede
al parroco don Giovanni Candia, Prevosto della chiesa di San Giovanni, di
imporre l'abitino del Carmelo e di sottodelegare altri sacerdoti o frati.
Ma il fervore religioso ed il possesso dei beni dei frati vengono a crudo
contatto con la realtà politica nuova. All'inizio del 1700, Vienna
si sostituisce alla Spagna in lombardia, legandola agli interessi austriaci
fino al 1796, quando l'esercito francese entra in Lombardia: avviene in
questo periodo la soppressione del convento e la cacciata dei frati.
L'imperatrice austriaca Maria Teresa, dopo la morte del marito Francesco
Stefano di Lorena, assume come aiutante di reggenza il figlio Giuseppe II°.
I provvedimenti di natura ecclesiastica presi dallo zelo riformatore del
figlio e del cancelliere Kaunitz si spingono oltre i limiti puramente politici.
Con il pretesto di provvedere a molti piccoli conventi o comunità
sparsi nelle campagne e nelle città, mancanti di un numero sufficiente
di religiosi le cui proprietà non bastavano alla loro conservazione,
con un Rescritto del 20 marzo 1769, si manomisero i beni di tanti asili
di pace e di beneficenza: chiese spogliate di molti arredi preziosi; disperse
tante opere d'arte; scacciati gli abitatori dei conventi; distribuiti gli
oggetti di culto. Il convento dei Carmelitani di Melegnano non stentava
la vita perchè era proprietario di terre e possedeva molti legati
di beneficenza che costituivano la Pia Opera di Misericordia per i vivi
e per i morti. Si tenta di non far incamerare i beni immobili e di salvare
il patrimonio dei nostri frati melegnanesi con qualunque mezzo; non bisognava
lasciare nulla di intentato, ma cercare una via per salvare il frutto e
la ricchezza accumulata ed amministrata in tre secoli. Per la sistemazione
dei beni del convento del Carmine il prevosto di Melegnano, don Giovanni
Candia, melegnanese di nascita, ottiene di essere nominato Regio Subeconomo
Delegato dal governo austriaco, e studia, d'accordo con il cardinale arcivescovo
di Milano, Pozzobonelli, un piano per la miglior sistemazione di ogni cosa.
Nonostante difficoltà di ogni genere, i rischi di natura finanziaria,
i continui controlli governativi che per un momento sembravano tutto far
crollare, viene approvato il piano proposto con un editto imperiale austriaco,
firmato da Francesco Antonio Lugano Cancelliere Generale del Regio Ufficio
dell'Economato Austriaco Ed ecco il testo dell'editto: "Essendosi
degnata Sua Maestà con Imperiale Reale Dispaccio del 31 maggio 1770
approvare ed ordinare l'esecuzione del Piano proposto da questo Eminentissimo
e Reverendissimo Cardinale Arcivescovo per la soppressione del piccolo convento
di Santa Maria dei Carmelitani della Provincia di Lombardia nel Borgo di
Melegnano, ed erezione di un Luogo Pio di Carità nello stesso Borgo,
mediante l'unione dei beni del detto piccolo convento; del Legato istituito
dal fu Pietro Gallina; e dell'ospitale de' Pellegrini del Borgo suddetto
cogli obblighi al detto Luogo Pio, come abbasso. Si avvisa perciò
qualunque persona, che aspira alla compra de' Mobili soltanto profani del
detto convento a comparire il giorno di Mercoledì, che sarà
alli diecinove del futuro mese di giugno, e successivi giorni alle ore dodici
della mattina, e ventuna del dopo pranzo nei detto soppresso convento, mentre
ivi alla presenza del m. r. sig. Giovanni Candia Preposto di Melegnano e
Regio Sostituto all'infrascritto Cancelliere del Regio Economato si apriranno
gli incanti per la vendita di detti mobili descritti nell'inventario firmato
dal suddelegato di questo Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale
Arcivescovo, e dal Padre Procuratore di detto soppresso convento.
La sagra supellettile poi, parte si lascerà alla chiesa del detto
soppresso convento per il necessario servizio divino, ed il restante si
distribuirà secondo verrà disposto dall'Eminentissimo Sig.
Cardinale Arcivescovo. Similmente si avvisa qualunque persona laica,
che aspira alla compra degli infrascritti Beni stabili spettanti alli detti
soppressi conventi ed OspitaLe de' Pellegrini da vendersi unitamente, o
separatamente, qualmente dentro il termine di giorni quindici dall'infrascritta
Data debba fare in iscritto la sua oblazione, in tanti gigliati di giusto
peso, e colle opportune cauzioni, o nelle mani del detto Notaro Cancelliere
abitante in P.N.P.S. Andrea alla Pusterla Nuova di Milano, o in quelle del
Sig. Antonio Buttafava abitante nel Borgo di Melegnano: passato il qual
termine s'avvisa qualunque persona come sopra a comparire il giorno di venerdì,
che sarà alli ventuno del detto mese di giugno alle ore tredici della
mattina, e vent'una del dopo pranzo, e successivi giorni nella Casa Prepositurale
del detto Borgo di Melegnano; mentre ivi in detti giorni ed ore alla presenza
e coll'intervento come sopra si aprirà l'Asta per la deliberazione
di detti Fondi a chi avrà fatta miglior obtazione, se così
parerà, e piacerà; cosicchè il presente affisso a'
luoghi soliti servirà d'avviso tanto per le Obblazioni che per le
deliberazioni suddette. Alla vendita de' suddetti stabili potranno
intervenire il predetto Suddelegato della Curia Arcivescrn,ile, ed un Delegato
della detta Confraternita de' Santi Pietro e Biaggio per tutti quegli utili
suggerimenti che si troveranno al caso. Col prezzo che si ricaverà
dalle vendite de' Mobili e Stabili del detto soppresso convento si pagheranno
li debiti al medesimo incombenti ed il restante s'invertirà su Monte
Camerale di Santa Teresa, o in altro de' modi permessi dalla Reale Prammatica
d'Ammortizzazione, e l'annuo frutto, unitamente alle altre rendite del detto
soppresso convento, si convertirà nelle seguenti cause, e cioè: annuo
di lire otto. E questa proprietà permette ai frati di concedere un
mutuo ad una certa Vittoria Del Monte di mille fiorini. Il peso amministrativo
dunque divenne sensibile ed occorreva una revisione o almeno una precisa
amministrazione: ed essa venne attuata nel 1671 dal priore Gerolamo Del
Monto che compila il "libro campione" di tutti i beni del convento: il citato
priore non immaginava che cento anni dopo la sua fatica ed i suoi beni sarebbero
stati confiscati da mani estranee. E nell'anno seguente, il 1672, ancora
viene acquistato un terreno di 20 pertiche al Ponte di Milano. Nella lunga
permanenza in convento i padri si meritarono la stima e l'affetto dei melegnanesi
che li onoravano con protezione e benefici. Ed anche molti melegnanesi illustrarono
l'Ordine Carmelitano: Carlo Caraccioli figlio del tenente generale Andrea
e di Andronica De Medici, che fu uomo di vasta cultura e salì per
tutti i gradi dell'Ordine e venne consacrato vescovo di Bobbio, ed il suo
ritratto si conserva nella sacristia parrocchiale; Carlo Cornegliano e Giovanni
Spernazzatì, che furono padri Provinciali dell'Ordine. E nel
secolo 1700 le donazioni continuano: il 3 marzo del 1710 Gerolamo Spernazzati
dona al convento un orto di una pertica vicino alla piazza della chiesa
prima in possesso di Giuseppe Montorfano. I padri del Carmine erano
dunque tenuti in alta considerazione: la chiesa era ufficiata regolarmente;
i sacramenti distribuiti in abbondanza e la partecipazione dei melegnanesi
era notevolissima; non solo da parte dei poveri, ma anche dei benestanti,
alcuni dei quali vollero essere sepolti in chiesa, come fu di un certo Ambrogio
Corneliani nel 1722. Essi erano anche invitati alle funzioni in parrocchia
e partecipavano della vita della chiesa di san Giovanni: una volta, nel
1725, inviano perfino una protesta allo stesso parroco della chiesa di San
Giovanni per differente trattamento in un funerale. E' in questo secolo,
il 1700, in cui si sviluppano le pratiche di pietà rimaste ancora
fino ai nostri giorni: novene; feste ai santi dell'ordine Carmelitano; tridui
di predicazione; particolari celebrazioni liturgiche. Melegnano era in continuo
aumento, ed i bisogni spirituali erano ancor più richiesti. Messe
cantate, benedizioni eucaristiche, uffici funebri, processioni, recita in
coro del breviario, lavoro e spiegazione del catechismo: queste le benemerenze
dei nostri frati, anche se il solito peso dell'amministrazione dei beni
poteva insinuarsi nel loro impegno spirituale: il 1° aprile 1716 viene
preso in affitto per 35 anni un pezzo di terra di 8 pertiche al Costigé,
l'11 settembre 1744 sono acquistate 68 pertiche di terra detta la vigna
di San Francesco, più altre 60 pertiche di un terreno denominato
La Brasca, e nel 1751 il convento acquista un prato denominato il Prato
del restello, dai Montorfani, di 12 pertiche. Il sano e robusto
patrimonio immobiliare, che ormai diventava ampio, può permettere
al convento di concedere ulteriori prestiti di forti somme. Le continue
lotte, i transiti militari e la permanenza di truppa, portarono un forte
peso al bilancio comunale. I promessi aiuti governativi non arrivavano mai,
ed il Comune si vide costretto a chiedere prestiti per far fronte alle spese:
il convento del Carmine concede, nel 1762 lire 3000 al 3% e lire 3000 al
4,10%, in prestito chiesto dai Sindaci della Comunità di Melegnano.
E due anni più tardi, nel 1764 il priore dei frati, Alessandro Granata,
può concedere una sovvenzione di 400 zecchini gigliati fiorentini,
all'interesse del 4%, alla famiglia Montorfani che versava in difficoltà
economiche. Ed è sempre in aumento il culto alla Vergine: nel
1771 il 28 giugno, il padre Alberto Maria Ercolini, procuratore nella Curia
Romana e Commissario Generale dei frati di tutto l'Ordine Carmelitano, concede
al parroco don Giovanni Candia, Prevosto della chiesa di San Giovanni, di
imporre l'abitino del Carmelo e di sottodelegare altri sacerdoti o frati.
Ma il fervore religioso ed il possesso dei beni dei frati vengono a crudo
contatto con la realtà politica nuova. All'inizio del 1700, Vienna
si sostituisce alla Spagna in lombardia, legandola agli interessi austriaci
fino al 1796, quando l'esercito francese entra in Lombardia: avviene in
questo periodo la soppressione del convento e la cacciata dei frati.
L'imperatrice austriaca Maria Teresa, dopo la morte del marito Francesco
Stefano di Lorena, assume come aiutante di reggenza il figlio Giuseppe II°.
I provvedimenti di natura ecclesiastica presi dallo zelo riformatore del
figlio e del cancelliere Kaunitz si spingono oltre i limiti puramente politici.
Con il pretesto di provvedere a molti piccoli conventi o comunità
sparsi nelle campagne e nelle città, mancanti di un numero sufficiente
di religiosi le cui proprietà non bastavano alla loro conservazione,
con un Rescritto del 20 marzo 1769, si manomisero i beni di tanti asili
di pace e di beneficenza: chiese spogliate di molti arredi preziosi; disperse
tante opere d'arte; scacciati gli abitatori dei conventi; distribuiti gli
oggetti di culto. Il convento dei Carmelitani di Melegnano non stentava
la vita perchè era proprietario di terre e possedeva molti legati
di beneficenza che costituivano la Pia Opera di Misericordia per i vivi
e per i morti. Si tenta di non far incamerare i beni immobili e di salvare
il patrimonio dei nostri frati melegnanesi con qualunque mezzo; non bisognava
lasciare nulla di intentato, ma cercare una via per salvare il frutto e
la ricchezza accumulata ed amministrata in tre secoli. Per la sistemazione
dei beni del convento del Carmine il prevosto di Melegnano, don Giovanni
Candia, melegnanese di nascita, ottiene di essere nominato Regio Subeconomo
Delegato dal governo austriaco, e studia, d'accordo con il cardinale arcivescovo
di Milano, Pozzobonelli, un piano per la miglior sistemazione di ogni cosa.
Nonostante difficoltà di ogni genere, i rischi di natura finanziaria,
i continui controlli governativi che per un momento sembravano tutto far
crollare, viene approvato il piano proposto con un editto imperiale austriaco,
firmato da Francesco Antonio Lugano Cancelliere Generale del Regio Ufficio
dell'Economato Austriaco Ed ecco il testo dell'editto: "Essendosi
degnata Sua Maestà con Imperiale Reale Dispaccio del 31 maggio 1770
approvare ed ordinare l'esecuzione del Piano proposto da questo Eminentissimo
e Reverendissimo Cardinale Arcivescovo per la soppressione del piccolo convento
di Santa Maria dei Carmelitani della Provincia di Lombardia nel Borgo di
Melegnano, ed erezione di un Luogo Pio di Carità nello stesso Borgo,
mediante l'unione dei beni del detto piccolo convento; del Legato istituito
dal fu Pietro Gallina; e dell'ospitale de' Pellegrini del Borgo suddetto
cogli obblighi al detto Luogo Pio, come abbasso. Si avvisa perciò
qualunque persona, che aspira alla compra de' Mobili soltanto profani del
detto convento a comparire il giorno di Mercoledì, che sarà
alli diecinove del futuro mese di giugno, e successivi giorni alle ore dodici
della mattina, e ventuna del dopo pranzo nei detto soppresso convento, mentre
ivi alla presenza del m. r. sig. Giovanni Candia Preposto di Melegnano e
Regio Sostituto all'infrascritto Cancelliere del Regio Economato si apriranno
gli incanti per la vendita di detti mobili descritti nell'inventario firmato
dal suddelegato di questo Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale
Arcivescovo, e dal Padre Procuratore di detto soppresso convento.
La sagra supellettile poi, parte si lascerà alla chiesa del detto
soppresso convento per il necessario servizio divino, ed il restante si
distribuirà secondo verrà disposto dall'Eminentissimo Sig.
Cardinale Arcivescovo. Similmente si avvisa qualunque persona laica,
che aspira alla compra degli infrascritti Beni stabili spettanti alli detti
soppressi conventi ed OspitaLe de' Pellegrini da vendersi unitamente, o
separatamente, qualmente dentro il termine di giorni quindici dall'infrascritta
Data debba fare in iscritto la sua oblazione, in tanti gigliati di giusto
peso, e colle opportune cauzioni, o nelle mani del detto Notaro Cancelliere
abitante in P.N.P.S. Andrea alla Pusterla Nuova di Milano, o in quelle del
Sig. Antonio Buttafava abitante nel Borgo di Melegnano: passato il qual
termine s'avvisa qualunque persona come sopra a comparire il giorno di venerdì,
che sarà alli ventuno del detto mese di giugno alle ore tredici della
mattina, e vent'una del dopo pranzo, e successivi giorni nella Casa Prepositurale
del detto Borgo di Melegnano; mentre ivi in detti giorni ed ore alla presenza
e coll'intervento come sopra si aprirà l'Asta per la deliberazione
di detti Fondi a chi avrà fatta miglior obtazione, se così
parerà, e piacerà; cosicchè il presente affisso a'
luoghi soliti servirà d'avviso tanto per le Obblazioni che per le
deliberazioni suddette. Alla vendita de' suddetti stabili potranno
intervenire il predetto Suddelegato della Curia Arcivescrn,ile, ed un Delegato
della detta Confraternita de' Santi Pietro e Biaggio per tutti quegli utili
suggerimenti che si troveranno al caso. Col prezzo che si ricaverà
dalle vendite de' Mobili e Stabili del detto soppresso convento si pagheranno
li debiti al medesimo incombenti ed il restante s'invertirà su Monte
Camerale di Santa Teresa, o in altro de' modi permessi dalla Reale Prammatica
d'Ammortizzazione, e l'annuo frutto, unitamente alle altre rendite del detto
soppresso convento, si convertirà nelle seguenti cause, e cioè:
Annue lire 1109 per limosina di tante messe, uffici e loro manutenzione, che erano a carico del detto soppresso convento da celebrarsi parte nella chiesa del detto soppresso convento, e parte da trasferirsi nell'Oratorio di Santa Brigida in Brera membro della Prepositura di Melegnano per comodo di quegli abitanti. Annue lire I8 alli Padri Minori Osservanti di S. Francesco di Melegnano in adempimento del Pio Legato Tenca. Annue lire 100 per Livello al Padre Antonio Maria Rosalini figlio del detto soppresso convento vita sua naturale durante, come da obbligazione assunta dal detto soppresso convento per Istromento 21 marzo 1764, rogato dal Notaro di Milano Antonio Bonomi. Finalmente si pagheranno le vitalizie pensioni a' Religiosi, che stanziavano nel detto convento in ragione di lire 300 per cadauno, quando vi sia luogo, in difetto a rata del ricavo col jus accrescendi sino a detta somma. Il frutto poi del capitale, che si ritraerà dalla vendita de' Fondi spettanti al detto soppresso Ospitale de' Pellegrini da investirsi come sopra; le altre annue rendite del medesimo, dedotte annue lire 22 per limosina di Messe incombenti al detto Ospitale; e la somma che, adempiuti li pesi come sopra spettanti al detto soppresso convento, potrà avanzare, si convertiranno in erigere di presente il detto Luogo Pio di Carità in Melegnano, al qual Luogo Pio si accolleranno ancora il Pio lascito del fu Pietro Gallina, e le dette Pensioni vitalizie al cessare che faranno di mano in mano colla morte dei prelati Religiosi. Di più si consegneranno al detto compratore, o compratori tutte le scritture, che si ritroveranno nel detto soppresso convento ed Ospitale, e che potranno servire alla difesa di quanto si venderà come sopra. Dat. in Milano li 29 Maggio 1771". I fondi in vendita, cioè i beni del soppresso convento di santa Maria del Carmine, assommavano a pertiche 259,5 complessivamente. Nei beni da vendersi erano stati compresi il caseggiato del convento e i due giardini annessi circondati con muro; erano stati esclusi la chiesa e le stanze del suo soffitto, le due sagrestie annesse alla medesima, e il piazzale davanti alla chiesa. Attuata la sistemazione delle proprietà a norma del piano approvato, venne steso l'Istromento di erozione del Luogo Pio di Carità, con rogito del 18 febbraio 1775 del notaio Francesco Maria Lugano. Fu nominato il Candia amministratore del Luogo Pio. Alla soppressione del convento vi erano sette frati. 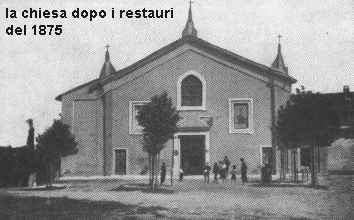 Nel
1821 vi erano ancora i padri Carlo Antonio Grancini Giovanni Terzaghi e
Francesco Alemanni; quest'ultimo rimasto come assistente della chiesa e
della confraternita del Carmine morì nel 1830. La proprietà
del convento ed adiacenze fu acquistata dai Conti Annoni di Milano, poi
passò alla Casa Cicogna, ed in seguito alla famiglia del ragionier
Angelo Castelfranchi. La famiglia Menicatti fu per oltre un secolo custode
della chiesa e fiduciaria delle famiglie proprietarie. Nella serie
dei sacristi della chiesa, per diversi anni dopo il 1919, ci fu anche la
famiglia di Cesare Beccaria, (nonno dell'autore di queste note Don Cesare
Amelli). Scacciati i pacifici ed esemplari ministri del Carmine, nonostante
le cure dei custodi laici successivi, la chiesa, per le continue profanazioni,
divenne cadente e trascurata nei lavori di manutenzione: usata talvolta
come deposito di materiale bellico, alloggio per truppe, teatro di mille
profanazioni. Cessò l'attività della Confraternita del Carmine
che era molto fiorente e che radunava tanti melegnanesi attorno al culto
della Vergine. Si tolse dal tabernacolo il Santissimo Sacramento, e di anno
in anno gli antichi affreschi del 1400 e del 1500 scomparvero sotto le tinteggiature
di calce usata per le disinfezioni: l'antica chiesa, ricca di tradizione,
di grazia, di beni, di storia, ora piangeva al cielo la sua desolazione;
nel presbiterio non più le solenni cerimonie, nella navata non più
masse di popolo orante, nel coro non più il salmodiare dei frati.
Ma le radici del bene compiuto e della tradizione cristiana erano profonde
al Carmine: si era seminato per tre secoli, e il frutto doveva necessariamente
maturare. L'amore per la chiesa del Carmine spinse i melegnanesi ad aggiungere
nel 1836 una terza campana come ex voto per lo scampato colera. E pochi
anni più tardi, nel 1868, si istituisce l'Associazione della Dottrina
Cristiana, con un priore, un cassiere, due revisori, e centinaia di soci,
tanto del paese quanto dei dintorni, Rocca, Rampina, Santa Brera, Costigè,
Cappuccina. Questa associazione teneva lezioni di catechismo tutte le domeniche,
pagava ogni anno le spese necessarie per tenere in piedi almeno i muri della
chiesa, offriva le suppellettili necessarie: i quattro busti argentati dei
vescovi milanesi Ambrogio, Carlo, Galdino, Barnaba; candelieri e lampade,
le intere bussole alla porta, raccolta di fondi per il restauro architettonico.
Il canonico Saresani parla a lungo di questa benefica istituzione.
Ancora oggi alla quarta domenica del mese di luglio si celebra la festa
della Madonna del Carmine, ed anticamente era l'unica processione con quella
del Corpus Domini. La festa attirava immensa folla per le funzioni e le
messe che furono fino a trenta nel medesimo giorno. La processione risultava
un trionfo e tutto il paese con i dintorni e le loro Scuole religiose partecipavano
con vivo interesse. La Madonna benedicente passava nelle vie e nei campi
a benedire e a consolare: e se la fede a Melegnano ancora non si è
spenta, nonostante che sia stata messa a dura prova, dobbiamo essere grati
anche alla Madonna del Carmine e alle sue feste. Naturalmente l'accorrere
di gente stimolavà i soliti ambulanti, le chiassoso giostre e i baracconi
da fiera: ma la preoccupazione religiosa, qui, a differenza della Festa
del Perdono, aveva il netto sopravvento. Nel
1821 vi erano ancora i padri Carlo Antonio Grancini Giovanni Terzaghi e
Francesco Alemanni; quest'ultimo rimasto come assistente della chiesa e
della confraternita del Carmine morì nel 1830. La proprietà
del convento ed adiacenze fu acquistata dai Conti Annoni di Milano, poi
passò alla Casa Cicogna, ed in seguito alla famiglia del ragionier
Angelo Castelfranchi. La famiglia Menicatti fu per oltre un secolo custode
della chiesa e fiduciaria delle famiglie proprietarie. Nella serie
dei sacristi della chiesa, per diversi anni dopo il 1919, ci fu anche la
famiglia di Cesare Beccaria, (nonno dell'autore di queste note Don Cesare
Amelli). Scacciati i pacifici ed esemplari ministri del Carmine, nonostante
le cure dei custodi laici successivi, la chiesa, per le continue profanazioni,
divenne cadente e trascurata nei lavori di manutenzione: usata talvolta
come deposito di materiale bellico, alloggio per truppe, teatro di mille
profanazioni. Cessò l'attività della Confraternita del Carmine
che era molto fiorente e che radunava tanti melegnanesi attorno al culto
della Vergine. Si tolse dal tabernacolo il Santissimo Sacramento, e di anno
in anno gli antichi affreschi del 1400 e del 1500 scomparvero sotto le tinteggiature
di calce usata per le disinfezioni: l'antica chiesa, ricca di tradizione,
di grazia, di beni, di storia, ora piangeva al cielo la sua desolazione;
nel presbiterio non più le solenni cerimonie, nella navata non più
masse di popolo orante, nel coro non più il salmodiare dei frati.
Ma le radici del bene compiuto e della tradizione cristiana erano profonde
al Carmine: si era seminato per tre secoli, e il frutto doveva necessariamente
maturare. L'amore per la chiesa del Carmine spinse i melegnanesi ad aggiungere
nel 1836 una terza campana come ex voto per lo scampato colera. E pochi
anni più tardi, nel 1868, si istituisce l'Associazione della Dottrina
Cristiana, con un priore, un cassiere, due revisori, e centinaia di soci,
tanto del paese quanto dei dintorni, Rocca, Rampina, Santa Brera, Costigè,
Cappuccina. Questa associazione teneva lezioni di catechismo tutte le domeniche,
pagava ogni anno le spese necessarie per tenere in piedi almeno i muri della
chiesa, offriva le suppellettili necessarie: i quattro busti argentati dei
vescovi milanesi Ambrogio, Carlo, Galdino, Barnaba; candelieri e lampade,
le intere bussole alla porta, raccolta di fondi per il restauro architettonico.
Il canonico Saresani parla a lungo di questa benefica istituzione.
Ancora oggi alla quarta domenica del mese di luglio si celebra la festa
della Madonna del Carmine, ed anticamente era l'unica processione con quella
del Corpus Domini. La festa attirava immensa folla per le funzioni e le
messe che furono fino a trenta nel medesimo giorno. La processione risultava
un trionfo e tutto il paese con i dintorni e le loro Scuole religiose partecipavano
con vivo interesse. La Madonna benedicente passava nelle vie e nei campi
a benedire e a consolare: e se la fede a Melegnano ancora non si è
spenta, nonostante che sia stata messa a dura prova, dobbiamo essere grati
anche alla Madonna del Carmine e alle sue feste. Naturalmente l'accorrere
di gente stimolavà i soliti ambulanti, le chiassoso giostre e i baracconi
da fiera: ma la preoccupazione religiosa, qui, a differenza della Festa
del Perdono, aveva il netto sopravvento.  Talvolta
non si poteva celebrare con tutta la solennità e lo sfarzo la festa;
lo impedivano misure igieniche contro epidemie, come nel 1883; talora l'inclemenza
del tempo che infieriva con forti temporali; talora invece gli attriti tra
l'intemperanza del popolino ed il clero locale. Sotto il portatile dorato,
sostenuto dai portatori del Carmine, passava la Madonna del Carmelo, vestita
di raso bianco con corona d'argento, il bambino in braccio, ornata di ori
e di argenti. Le vie e le soglie delle case si ornavano a lieta festa; i
davanzali rifiorivano di rose e gigli e pulsavano di lumini e candele miniate;
le finestre ricamate di verde; lunghe distese di lenzuola candidissime riabbellivano
i muri; tappeti sulla strada; archi trionfali e festoni di rami verdeggianti;
ed iscrizioni alla Vergine, come la seguente tramandataci dal Saresani:
"Esulta, popolo di Melegnano, la Vergine del Carmelo viene a visitarti.
Maria, i tuoi occhi pietosi rivolgi a noi, al sommo gerarca Leone XIII°,
alla Chiesa tutta, volgili pietosi all'Italia (era l'anno 1886) al Re nostro
(era re Umberto I°), dissipa tu le discordie e civili sommosse, i nemici
della Chiesa e di Dio, e feconda questa terra di uomini che onorino la Patria
terrestre e siano degni della celeste" (in Saresani, op. cit., p. 262).
Ma nel 1868 si radunano alcuni volonterosi per studiare il restauro che
era impellente: la chiesa cadeva da tutti i lati; e il crollo improvviso
del tetto il 21 maggio 1872 diede la decisione ai lavori e la chiesa divenne
meno brutta e più accogliente. Però vennero coperti
con calce altri affreschi e decorazioni che oggi è impossibile ricuperare.
Nel 1895 viene istituita la pratica delle Quarant'Ore durante il periodo
natalizio; e nel 1912 si inaugurò la statua. della Madonna eseguita
dalla ditta Nardini di Milano. La chiesa possedeva anche un organo
del 1500 che non era pregevole per il suono, ma per la forma e il materiale
usato nella costruzione; la sua particolarità era quella di avere
la tastiera primitiva, senza i bemolle ed i diesis: era cioè un pezzo
archeologico molto raro. Già dicemmo che nei tempi passati
le spese del culto erano affrontate dalla Confraternita del Carmine, dalla
Società della Dottrina Cristiana e da una larga messe di benefattori
che qui vogliamo ricordare: Bertuzzi Rosa, Buttafava don Andrea, Buttafava
don Antonio, Ciceri don Francesco Antonio prevosto, Cremonesi Baldassare,
Fondrini Giacomo, Frassi Isabella, Gallina Pietro, Lapis don Giovanni, Lapis
Giuseppe, Maiocchi don Giuseppe e fratello Gerolamo, Martinenghi Sebastiano,
Melli Carlo, Messa Giuseppe, Restelli contessa Schiaffinati, Saresani don
Ferdinando, Securi canonico Giovanni Battista, Senna dott. Felice, Sesti
Giovanni, Spernazzati Talvolta
non si poteva celebrare con tutta la solennità e lo sfarzo la festa;
lo impedivano misure igieniche contro epidemie, come nel 1883; talora l'inclemenza
del tempo che infieriva con forti temporali; talora invece gli attriti tra
l'intemperanza del popolino ed il clero locale. Sotto il portatile dorato,
sostenuto dai portatori del Carmine, passava la Madonna del Carmelo, vestita
di raso bianco con corona d'argento, il bambino in braccio, ornata di ori
e di argenti. Le vie e le soglie delle case si ornavano a lieta festa; i
davanzali rifiorivano di rose e gigli e pulsavano di lumini e candele miniate;
le finestre ricamate di verde; lunghe distese di lenzuola candidissime riabbellivano
i muri; tappeti sulla strada; archi trionfali e festoni di rami verdeggianti;
ed iscrizioni alla Vergine, come la seguente tramandataci dal Saresani:
"Esulta, popolo di Melegnano, la Vergine del Carmelo viene a visitarti.
Maria, i tuoi occhi pietosi rivolgi a noi, al sommo gerarca Leone XIII°,
alla Chiesa tutta, volgili pietosi all'Italia (era l'anno 1886) al Re nostro
(era re Umberto I°), dissipa tu le discordie e civili sommosse, i nemici
della Chiesa e di Dio, e feconda questa terra di uomini che onorino la Patria
terrestre e siano degni della celeste" (in Saresani, op. cit., p. 262).
Ma nel 1868 si radunano alcuni volonterosi per studiare il restauro che
era impellente: la chiesa cadeva da tutti i lati; e il crollo improvviso
del tetto il 21 maggio 1872 diede la decisione ai lavori e la chiesa divenne
meno brutta e più accogliente. Però vennero coperti
con calce altri affreschi e decorazioni che oggi è impossibile ricuperare.
Nel 1895 viene istituita la pratica delle Quarant'Ore durante il periodo
natalizio; e nel 1912 si inaugurò la statua. della Madonna eseguita
dalla ditta Nardini di Milano. La chiesa possedeva anche un organo
del 1500 che non era pregevole per il suono, ma per la forma e il materiale
usato nella costruzione; la sua particolarità era quella di avere
la tastiera primitiva, senza i bemolle ed i diesis: era cioè un pezzo
archeologico molto raro. Già dicemmo che nei tempi passati
le spese del culto erano affrontate dalla Confraternita del Carmine, dalla
Società della Dottrina Cristiana e da una larga messe di benefattori
che qui vogliamo ricordare: Bertuzzi Rosa, Buttafava don Andrea, Buttafava
don Antonio, Ciceri don Francesco Antonio prevosto, Cremonesi Baldassare,
Fondrini Giacomo, Frassi Isabella, Gallina Pietro, Lapis don Giovanni, Lapis
Giuseppe, Maiocchi don Giuseppe e fratello Gerolamo, Martinenghi Sebastiano,
Melli Carlo, Messa Giuseppe, Restelli contessa Schiaffinati, Saresani don
Ferdinando, Securi canonico Giovanni Battista, Senna dott. Felice, Sesti
Giovanni, Spernazzati  Antonio,
Visconti canonico Alessandro. Fu concesso il privilegio dell'Indulgenza
Plenaria nella festa dell'Annunciazione di Maria il 25 marzo. Si celebravano
feste particolari: il 15 gennaio san Mauro abate, il 5 febbraio Sant'Agata,
il primo mercoledì di marzo in onore a San Giuseppe, il 19 marzo
in onore a San Giuseppe, il 25 marzo festa dell'Annunciazione, 30 maggio
santa Maria Maddalena de' Pazzi, 13 giugno sant'Antonio da Padova, 16 luglio
Madonna del Carmine, 19 luglio inizio novena della festa del Carmine, quarta
domenica di luglio festa patronale, lunedì successivo festa di santa
Teresina, 15 ottobre santa Teresa carmelitana, 2 novembre inizio ottava
dei Morti, 12 novembre san Diego, 25 dicembre esposizione delle 40 ore,
31 dicembre Te Deum solenne. Attualmente la chiesa è sempre
linda e pulita, confortante esempio di cura amorosa e decoro degno di un
tempio di Dio: l'amministrazione e le riparazioni sono dirette dal parroco
mons. Arturo Giovenzana, e il candore della pulizia è tenuto dal
sacrista, e con una passione ammirevole ed esemplare dal concittadino signor
Antonio Cremonesi. La tranquilla solitudine, il dolce isolamento dell'eremitaggio
del Carmine, l'ambiente riposante e risanatore dello spirito e del corpo,
ilmistico angolo che la nostra storia aveva creato, ora però sono
definitivamente scomparsi. Costruzioni moderne ed imponenti sono sorte e
continuano a sorgere: il paese si avanza con la sua vita pulsante di esigenze
e di progresso; il rione antico vede accanto a sè altri tre nuovi
massicci rioni la zona dell'Ossario, la zona oltre la via Emilia, la zona
tra il Ricovero Vecchi e il Lambro: è la vita che continua la sua
strada è l'eterna giovinezza che si rinnova nel cammino dei secoli. Antonio,
Visconti canonico Alessandro. Fu concesso il privilegio dell'Indulgenza
Plenaria nella festa dell'Annunciazione di Maria il 25 marzo. Si celebravano
feste particolari: il 15 gennaio san Mauro abate, il 5 febbraio Sant'Agata,
il primo mercoledì di marzo in onore a San Giuseppe, il 19 marzo
in onore a San Giuseppe, il 25 marzo festa dell'Annunciazione, 30 maggio
santa Maria Maddalena de' Pazzi, 13 giugno sant'Antonio da Padova, 16 luglio
Madonna del Carmine, 19 luglio inizio novena della festa del Carmine, quarta
domenica di luglio festa patronale, lunedì successivo festa di santa
Teresina, 15 ottobre santa Teresa carmelitana, 2 novembre inizio ottava
dei Morti, 12 novembre san Diego, 25 dicembre esposizione delle 40 ore,
31 dicembre Te Deum solenne. Attualmente la chiesa è sempre
linda e pulita, confortante esempio di cura amorosa e decoro degno di un
tempio di Dio: l'amministrazione e le riparazioni sono dirette dal parroco
mons. Arturo Giovenzana, e il candore della pulizia è tenuto dal
sacrista, e con una passione ammirevole ed esemplare dal concittadino signor
Antonio Cremonesi. La tranquilla solitudine, il dolce isolamento dell'eremitaggio
del Carmine, l'ambiente riposante e risanatore dello spirito e del corpo,
ilmistico angolo che la nostra storia aveva creato, ora però sono
definitivamente scomparsi. Costruzioni moderne ed imponenti sono sorte e
continuano a sorgere: il paese si avanza con la sua vita pulsante di esigenze
e di progresso; il rione antico vede accanto a sè altri tre nuovi
massicci rioni la zona dell'Ossario, la zona oltre la via Emilia, la zona
tra il Ricovero Vecchi e il Lambro: è la vita che continua la sua
strada è l'eterna giovinezza che si rinnova nel cammino dei secoli. |
|
tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |