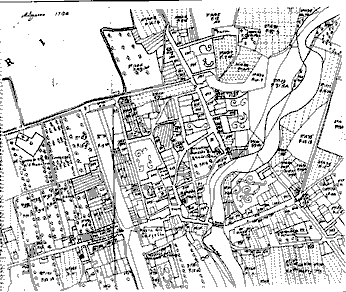 La
misura della pianta di Melegnano La
misura della pianta di Melegnano
Melegnano ebbe la propria mappa catastale nel 1722 rilevata direttamente
sul luogo in scala 1:2000 mediante l’utilizzazione della tavoletta pretoriana.
Per ogni particella sono indicati: il numero d’ordine, la qualità
della coltura e la superficie. Nel sommarione a margine, i dati sono completati
da indicazioni relative alla proprietà. Scarsi sono i dati relativi
ai fabbricati che non venivano rilevati, ma misurati in un sol corpo con
i cortili adiacenti. Gli originali rilevati sul posto venivano poi trasferiti
in ufficio, in mappe a fogli componibili. Le diverse qualità di
coltura venivano evidenziate con simboli grafici di differente colorazione
ad acquarello, i diversi mappali venivano poi distinti da una numerazione
progressiva che a volte veniva riportata anche a margine unitamente alle
indicazioni del proprietario, di cui veniva segnalata anche la classe sociale
di appartenenza. L’elaborazione dei dati del censimento e le operazioni
di misura dei terreni portarono alla costituzione dei sommarioni e delle
mappe tutt’ora esistenti. La distribuzione alle comunità del materiale
elaborato, avvenuta tra il 1723 e il 1726, costituì l’atto conclusivo
del censimento. Nel 1725 ebbe inizio la stima delle proprietà e
sulla base di questa, la riorganizzazione dell’esazione dei tributi, era
così’ stato raggiunto il fine che aveva dato inizio a tutte le operazioni
di censimento, quindi un irreversibile riordino della politica fiscale.
Le politiche riformiste degli Asburgo
Vennero emanate quindi delle riforme che si dimostrarono di stimolo
eccezionale per l’agricoltura in quanto i miglioramenti dei terreni, dovuti
a dissodamenti di terre incolte, ad una più intensiva coltivazione
dei fondi o a piantumazione di essenze produttive come gelsi o viti non
erano soggetti a ulteriori tassazioni. Reciprocamente, l’abbandono delle
colture non dava diritto ad alcuna detrazione del carico. Si vennero così
a penalizzare le grandi proprietà che non avevano adeguati mezzi
di sfruttamento e si premiò invece la industriosità dei piccoli
proprietari che trovarono, nell’immutabilità del carico, l’incentivo
ad una maggiore razionalizzazione delle colture. Ne conseguì un’enorme
sviluppo dell’agricoltura, nel miglioramento delle tecniche agricole, ed
un alleggerimento del carico tributario che veniva più equamente
distribuito. L’immutabilità del carico determinò anche il
passaggio da una conduzione signorile diretta dei fondi al sistema dei
fittabili. Le operazioni catastali, interrotte per gli eventi bellici del
1733, furono riprese dalla figlia di Carlo VI, Maria Teresa d’Austria,
nel 1749 e si protrassero sino al 1757. Si rendeva infatti necessario un
aggiornamento delle mappe catastali di molte zone ed in particolare di
quelle attraversate da fiumi che avevano eroso territorio e delle zone
di confine che si erano andate modificando in conseguenza di vari trattati
di pace. Fu inoltre inderogabile l’aggiornamento delle intestazioni di
proprietà e la rilevazione dei beni dì seconda stazione (gli
edifici). Le operazioni, dirette dalla seconda Giunta dei censimento furono
presiedute dal toscano Pompeo Neri e portarono alla redazione di vari registri
catastali. Per Melegnano rimase in vigore la mappa di Carlo VI che fu affiancata,
nel 1751, dalle Tavole del nuovo estimo e dalla descrizione dei beni di
seconda stazione . Esaurito il suo compito, la Giunta si sciolse il 3 marzo
1758. Il catasto asburgico non fu senz’altro perfetto ma certamente fu
una delle più importanti operazioni di grande portata innovativa
di tutto il territorio milanese.
I cambiamenti urbanistici
Il passaggio del ducato di Milano sotto il dominio degli Asburgo d’Austria,
agli inizi del Settecento, non portò cambiamenti urbanistici immediati
e visibili all’interno della città quanto a forma e immagine. Ci
fu un rilancio dell’iniziativa edilizia nobiliare che incominciò
ad investire denaro nella trasformazione dei propri palazzi come segno
distintivo di nobiltà, gareggiando apertamente col potere religioso,
anche i nobili ripensarono le loro dimore urbane e a partire dal 1710 numerosi
palazzi sorsero dalla ristrutturazione di più antiche proprietà
immobiliari accresciute lentamente nel corso dei secoli precedenti. |



