| Elisabetta da Melegnano, monaca
Sec. XIII. In Coldani-Saresani pag. 140, si legge: “Beata Elisabetta che
si segnalò per santità nel monastero di S. Chiara di Mortara,
e dormì nel Signore il 22 maggio del 1530. Sul manoscritto di Giacinto
Coldani, alla pagina 81, si legge precisamente così: “La B.
Ippolita e la B. Lisabetta amendue del terzordine del succennato santo
(S. Francesco) che ripiene di santità riposarno nel Signore, nel
1530 nel Monistero di S. Chiara presso Mortara. La prima il dì 28
Aprile, e la seconda il giorno 22 maggio”. |
| Farina Giacomo, militare.
Colonnello e governatore d’Alicante in Spagna. In Coldani-Saresani è
riportata questa notizia in modo scarno e senza altre indicazioni
biografiche a pag. 161. |
| Federico da Melegnano, amministratore.
Sec. XV. Il suo nome appare negli “Annali della Fabbrica del duomo di Milano”
dal 1401 al 1404. |
| Ferrario Bernardo Antonio, militare.
Sec. XVII-XVIII. Colonnello e tenente regio nell’isola di Maiorca al servizio
del re cattolico Filippo V (1683-1746). La notizia è in Coldani-Saresani,
pag. 161. |
| Ferrario Carlo, militare.
Sec. XVIII. Sergente maggiore di un reggimento dei corazzieri al servizio
di Carlo VI imperatore (1685-1740), così in Coldani-Saresani a pag.
161. |
Filippolo da Melegnano, artista.
pittore. Sec. XV.  Pittore
di vetrate del duomo di Milano. Nell’archivio del duomo di Milano, registro
63 nel Liber mandatorum 1402, foglio 77 verso, in data 4 marzo 1402 si legge
Filipolus de Melegnano pictor... e segue con la descrizione del contratto
per i disegni di alcune vetrate del duomo di Milano ( il testo è
in lingua latina). Vedi anche Provincia di Milano, Le vetrate del
Duomo di Milano, Le Monnier, Firenze 1986, pag. 34. Vedi anche archivio
della chiesa di S. Giovanni, armadio 17, n. 14. Sul Dizionario della Chiesa
Ambrosiana, ed. NED, Milano, !989, vol. terzo, pagg. 1612-1613, si legge
che il pittore Filippolo da Melegnano preparò quattro disegni per
le vetrate del duomo, nel finestrone absidale detto della “raza. Pittore
di vetrate del duomo di Milano. Nell’archivio del duomo di Milano, registro
63 nel Liber mandatorum 1402, foglio 77 verso, in data 4 marzo 1402 si legge
Filipolus de Melegnano pictor... e segue con la descrizione del contratto
per i disegni di alcune vetrate del duomo di Milano ( il testo è
in lingua latina). Vedi anche Provincia di Milano, Le vetrate del
Duomo di Milano, Le Monnier, Firenze 1986, pag. 34. Vedi anche archivio
della chiesa di S. Giovanni, armadio 17, n. 14. Sul Dizionario della Chiesa
Ambrosiana, ed. NED, Milano, !989, vol. terzo, pagg. 1612-1613, si legge
che il pittore Filippolo da Melegnano preparò quattro disegni per
le vetrate del duomo, nel finestrone absidale detto della “raza. |
| Fiocchi Francesco, pittore
(1856-1936). Nacque da famiglia benestante e questo gli consentì
di dedicarsi a quei tempi, più che ai nostri, alla vocazione artistica.
Visse solo in una casetta a metà della attuale via Dezza con un
orticello che lui stesso coltivava. La formazione artistica di Fiocchi
passò per Milano all’Accademia di Brera con insigni maestri. In
modo speciale due docenti gli furono vicini: Giovanni Segantini e Francesco
Hayez. Il Fiocchi è stato un forte disegnatore di ritratti.
Soprattutto è varia la tematica del paesaggio con una tavolozza
ricca di verdi secondo diverse sfumature, dando colore alla natura, alle
acque del Lambro e dell’Addetta, che sono due corsi d’acqua cari ai Melegnanesi.
In Archivio Amelli, cartella A-2, vi è un fascicolo a lui dedicato
con una lunga nota di Guido Oldani, poeta melegnanese vivente e critico
d’arte e di letteratura. Su questo fascicolo vi è il suo autoritratto
che sostituisce la fotografia. Vedi “Il Melegnanese”, anno 8, n. 8 (15
aprile 1975), pag. 4 e con fotografia. |
| Folli Costantina, suora
missionaria canossiana, maestra delle novizie (+ 1 febbraio 1926 a 77 anni).
Entrò nella Suore Canossiane di Pavia. Fu maestra della novizie:
Fu superiora per 18 anni e missionaria in Cina. Si ritirò negli
ultimi anni nella Casa di Riposo Amigazzi di Legnano. |
| Francesco di Melegnano, commerciante.
Sec. XIV. Il suo nome appare nella “Matricola” dei mercanti di lana sottile.
La “Matricola” era un registro in cui stavano elencati i nomi dei mercanti
di lana sottile, quando i mercanti si erano costituiti in corporazione
nei secoli XIV e XV. |
Frassi Giacomo, 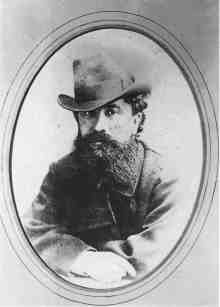 amministratore
di vari Enti, ingegnere, benefattore (1831-1893). Dal Registro dello Stato
d’Anime, 105 (1852-53), alla Contrada del Ponte n. 146 si legge quanto segue: amministratore
di vari Enti, ingegnere, benefattore (1831-1893). Dal Registro dello Stato
d’Anime, 105 (1852-53), alla Contrada del Ponte n. 146 si legge quanto segue:
Frassi Giuseppe, anni 61 - fu Giovanni Battista
Lapis Marina. moglie, anni 59
Isabella, figlia, anni 20
Angiola, figlia, anni 29
Giacomo, figlio, anni 21, studente matematica (Morì
a Milano).
Vedi anche in archivio della parrocchia di S. Giovanni
Battista in Melegnano, armadio n. 1, cartella n. 2, fascicolo n. 7, dove
si riporta la nomina del Frassi a presidente dell’Ospedale Predabissi di
Melegnano in data 19 luglio 1887, ma anche la nomina a presidente della
locale Congregazione di Carità da parte del Municipio di Melegnano
a firma del sindaco Giuseppe Sangregorio Galli in data 20 novembre 1886.
Vi è anche un foglio, in data 28 luglio 1861 dove è riportato,
da parte del sindaco della città di Torino e indirizzato a Giacomo
Frassi, l’Estratto del Regolamento del Campo-Santo adottatto dal Consiglio
comunale torinese. La famiglia Frassi donò alla parrocchia
di S. Giovanni in Melegnano una casa situata nell’attuale via Paolo Frisi,
sulla quale sta ancora una lapide con le seguenti parole: “In memoria /
dell’ingegnere / Giacomo Frassi / impareggiabile amministratore / dei beni
della Chiesa e dei poveri / i concittadini riconoscenti / 1831-1893”.
La sua fotografia è in un grosso quadro presso la Casa di Riposo
di Melegnano in via Cavour., cioè Giacomo Frassi fu uno dei promotori
di iniziative che hanno portato alla fondazione di quella che oggi si chiama
“Casa di Riposo” o Ricovero Vecchi: morendo ha lasciato la sua eredità
dell’Albergo Madonna (dove oggi è la sede della Cariplo in via Roma)
perché servisse alla creazione di una casa di riposo per anziani.
Vedi “Il Melegnanese”, anno 1, n: 19 (15 ottobre 1968) con sua fotografia.
La sua sorella Angela Frassi fu una delle prime benefattrici del Ricovero
Vecchi.
Seguendo l’esempio del fratello, alla di lei morte, ha lasciato le sue
proprietà di via Senna e di via Roma all’istituto che ancora doveva
essere eretto in Ente Morale, come poi avvenne con regio decreto il 25
maggio 1911. .Vedi anche il libro dal titolo Casa di Riposo - Cento
anni - 1894, 1994, a cura di don Cesare Amelli ed Ernesto Prandi, collocato
in archivio della parrocchia di S. Giovanni di Melegnano, armadio 1, n.
105. |
Frisi Paolo,  sacerdote.
scienziato, matematico, fisico, scrittore (1728-1784), Nato da Giovanni
Mattia e Francesca Magnetti il 13 aprile 1728, morì il 22 novembre
1784. Frequentò le Scuole Arcimboldi di Milano e la Biblioteca Ambrosiana
che conserva parecchie sue lettere. Entrò tra i Barnabiti e si distinse
per l’insegnamento anche universitario. Fu nominato membro delle
principali Accademie scientifiche europee; fu socio delle Accademie Scientifiche
di Londra, Berlino, Pietroburgo, Bologna, Kobenhavn, Stockolm, Upsala, Harlem,
Siena, Lione, Berna, Napoli ed altre, fu corrispondente dell'Accademia delle
Scienze di Parigi. sacerdote.
scienziato, matematico, fisico, scrittore (1728-1784), Nato da Giovanni
Mattia e Francesca Magnetti il 13 aprile 1728, morì il 22 novembre
1784. Frequentò le Scuole Arcimboldi di Milano e la Biblioteca Ambrosiana
che conserva parecchie sue lettere. Entrò tra i Barnabiti e si distinse
per l’insegnamento anche universitario. Fu nominato membro delle
principali Accademie scientifiche europee; fu socio delle Accademie Scientifiche
di Londra, Berlino, Pietroburgo, Bologna, Kobenhavn, Stockolm, Upsala, Harlem,
Siena, Lione, Berna, Napoli ed altre, fu corrispondente dell'Accademia delle
Scienze di Parigi. 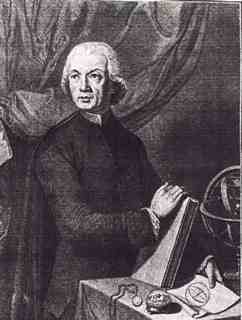 Ricevette
benemerenze da diversi governanti. Collaborò a riviste scientifiche
e letterarie, tra cui la rivista milanese “Il Caffè”. Nei suoi viaggi
a Parigi incontrò gli esponenti dell’Illumunismo francese. Per le
sue idee lasciò la Congregazione dei Barnabiti, ma non l’abito ecclesiastico.
Ricordiamo che Paolo Frisi fu il primo a far cenoscere e ad introdurre il
parafulmine in Italia inventato da Beniamino Franklin nel 1852. Pietro
Verri scrisse di lui questo giudizio: “Egli coll’esempio, colle lezioni,
cogli scritti fu il primo che scosse dal sonno la nazione... sostituì
alle opinioni scolastiche le verità dimostrate, alle frivole questioni,
la cognizione del cielo e dei fenomeni terrestri. all’araba dialettica infallibile,
il calcolo. Ne’ Barnabiti si moltiplicarono gli studi, nella città
si dilatarono”. Per le notizie sulla vita come breve ma succoso riassunto,
vedi Dizionario della Chiesa ambrosiana, NED, Milano 1988, vol. II. pp.
1288-1290, con bibliografia essenziale. Vedi anche l’opera di Arnaldo
Masotti, Scritti inediti di Paolo Frisi, Milano 1943-1949: Due copie sono
in archivio della parrocchia di S. Giovanni di Melegnano, armadio 1, n.
183 e 184, con inserita anche l’illustrazione raffigurante Paolo Frisi.
Vedi anche l’Enciclopedia Melegnanese, fascicolo 17, a cura di don Cesare
Amelli. Vedi anche Guida storica commerciale-industriale di Melegnano, 1942,
pp. 23-25, nell’archivio della parrocchia di S. Giovanni Battista
in Melegnano, armadio 1, n. 31. I giudizi che si sono dati su Paolo
Frisi da parte di tanti studiosi sono molto numerosi, ne basta uno significativo,
dato dallo storico Stuart J. Woolf, in Il Risorgimento Italiano, ed. Einaudi,
Torino 1981: “Paolo Frisi, uomo di interessi cosmopoliti, matematico e consigliere
tecnico degli Asburgo, era considerato il D’Alembert italiano; ed egli stesso
si riteneva molto vicino all’enciclopedista francese, per il quale
l’esperienza pratica aveva maggior valore delle ipotesi teoriche. Il suo
Elogio del Galileo, (uno dei maggiori scritti di Frisi) secondo l’opinione
di Alessandro Verri, ebbe un grandissimo successo, perché aveva saputo
animare la fredda geometria con qualche vampa di filosofica eloquenza.
Cioè, il Frisi, come filosofo, era sulla linea degli intellettuali
più forti europei, secondo i quali il compito dell’intellettuale
era, in questa visione, eminentemente pratico e doveva occuparsi della diffusione
della conoscenza utile, oltre che della sua scoperta. Il Frisi, dunque,
era tra il gruppo dei giovani patrizi milanesi che si raccolsero attorno
al Verri fra il 1762 e il 1766, nella “Società dei Pugni” (Cesare
Beccaria, Alessandro Verri fratello di Pietro e alcuni altri), i quali rifiutavano
l’erudizione formale delle accademie e i superstiziosi riti delle logge
massoniche, ma preferivano gli incontri aperti e animati da spirito egualitario.
Vedi anche Archivio Amelli, cartella F-1, fascicolo 1. Nella collana
“Letteratura e Testi”, dell’editore Riccardo Ricciardi, Milano-Napoli 1958,
volume 46, tomo III, dal titolo Illuministi italiani, riformatori lombardi,
piemontesi e toscani, il nostro Frisi occupa da pagina 289 a pagina 382.
Vedi “Il Melegnanese”, anno 7, n. 18 ( 1 ottobre 1974), pag. 3 con fotografia,
e il numero 22 (1 dicembre 1974), pag. 1. Vedi “Il Melegnanese”, anno 10,
n. 21 (15 novembre 1977), pag. 2. Vedi “Il Melegnanese”, anno XI, n. 18
(1 ottobre 1978) con interessanti fotografie. A Paolo Frisi è
dedicata una via a Melegnano: E’ pure dedicata una via a Milano, in zona
Corso Buenos Aires, sulla destra verso via Melzo. Ricevette
benemerenze da diversi governanti. Collaborò a riviste scientifiche
e letterarie, tra cui la rivista milanese “Il Caffè”. Nei suoi viaggi
a Parigi incontrò gli esponenti dell’Illumunismo francese. Per le
sue idee lasciò la Congregazione dei Barnabiti, ma non l’abito ecclesiastico.
Ricordiamo che Paolo Frisi fu il primo a far cenoscere e ad introdurre il
parafulmine in Italia inventato da Beniamino Franklin nel 1852. Pietro
Verri scrisse di lui questo giudizio: “Egli coll’esempio, colle lezioni,
cogli scritti fu il primo che scosse dal sonno la nazione... sostituì
alle opinioni scolastiche le verità dimostrate, alle frivole questioni,
la cognizione del cielo e dei fenomeni terrestri. all’araba dialettica infallibile,
il calcolo. Ne’ Barnabiti si moltiplicarono gli studi, nella città
si dilatarono”. Per le notizie sulla vita come breve ma succoso riassunto,
vedi Dizionario della Chiesa ambrosiana, NED, Milano 1988, vol. II. pp.
1288-1290, con bibliografia essenziale. Vedi anche l’opera di Arnaldo
Masotti, Scritti inediti di Paolo Frisi, Milano 1943-1949: Due copie sono
in archivio della parrocchia di S. Giovanni di Melegnano, armadio 1, n.
183 e 184, con inserita anche l’illustrazione raffigurante Paolo Frisi.
Vedi anche l’Enciclopedia Melegnanese, fascicolo 17, a cura di don Cesare
Amelli. Vedi anche Guida storica commerciale-industriale di Melegnano, 1942,
pp. 23-25, nell’archivio della parrocchia di S. Giovanni Battista
in Melegnano, armadio 1, n. 31. I giudizi che si sono dati su Paolo
Frisi da parte di tanti studiosi sono molto numerosi, ne basta uno significativo,
dato dallo storico Stuart J. Woolf, in Il Risorgimento Italiano, ed. Einaudi,
Torino 1981: “Paolo Frisi, uomo di interessi cosmopoliti, matematico e consigliere
tecnico degli Asburgo, era considerato il D’Alembert italiano; ed egli stesso
si riteneva molto vicino all’enciclopedista francese, per il quale
l’esperienza pratica aveva maggior valore delle ipotesi teoriche. Il suo
Elogio del Galileo, (uno dei maggiori scritti di Frisi) secondo l’opinione
di Alessandro Verri, ebbe un grandissimo successo, perché aveva saputo
animare la fredda geometria con qualche vampa di filosofica eloquenza.
Cioè, il Frisi, come filosofo, era sulla linea degli intellettuali
più forti europei, secondo i quali il compito dell’intellettuale
era, in questa visione, eminentemente pratico e doveva occuparsi della diffusione
della conoscenza utile, oltre che della sua scoperta. Il Frisi, dunque,
era tra il gruppo dei giovani patrizi milanesi che si raccolsero attorno
al Verri fra il 1762 e il 1766, nella “Società dei Pugni” (Cesare
Beccaria, Alessandro Verri fratello di Pietro e alcuni altri), i quali rifiutavano
l’erudizione formale delle accademie e i superstiziosi riti delle logge
massoniche, ma preferivano gli incontri aperti e animati da spirito egualitario.
Vedi anche Archivio Amelli, cartella F-1, fascicolo 1. Nella collana
“Letteratura e Testi”, dell’editore Riccardo Ricciardi, Milano-Napoli 1958,
volume 46, tomo III, dal titolo Illuministi italiani, riformatori lombardi,
piemontesi e toscani, il nostro Frisi occupa da pagina 289 a pagina 382.
Vedi “Il Melegnanese”, anno 7, n. 18 ( 1 ottobre 1974), pag. 3 con fotografia,
e il numero 22 (1 dicembre 1974), pag. 1. Vedi “Il Melegnanese”, anno 10,
n. 21 (15 novembre 1977), pag. 2. Vedi “Il Melegnanese”, anno XI, n. 18
(1 ottobre 1978) con interessanti fotografie. A Paolo Frisi è
dedicata una via a Melegnano: E’ pure dedicata una via a Milano, in zona
Corso Buenos Aires, sulla destra verso via Melzo. |