Associazioni
| melegnano.net | Melegnano.net
Associazioni |
|||
| Ubertino capitaneo di Melegnano |
Capitaneo o capitano, deriva
dal latino caput =
testa, cioè chi è alla testa di qualcosa e qualcuno, era
un titolo che identificava soprattutto nel MilaneseVassalli valvassori
a capo di importanti comunità, soprattutto rurali, era un capo militare,  politico
e a volte anche di giustizia. politico
e a volte anche di giustizia.
Nel complicato e dinamico processo feudale di legami tra imperatore ed alti ecclesiastici furono interessate Milano e, come vedremo, anche Melegnano. L'imperatore Ottone I e poi Ottone Il si preoccupavano continuamente di mantenere l'autorità nominando nell'Italia settentrionale vescovi favorevoli e amici dell'impero. Alla morte dell'arcivescovo ambrosiano Arnolfo, il successore Goffredo non era accolto dal clero e non era gradito al popolo: tuttavia fu forzatamente accolto perché si mostrava fedele all'imperatore e ai suoi interessi politici. Nello stesso tempo in Milano l'autorità imperiale era rappresentata da Bonizo, che esercitava il potere con durezza e con insolenza. Per prepararsi alla conquista del potere anche in campagna e per rendere effettiva e legale la sua autorità in Milano, Bonizo riesce a far eleggere arcivescovo di Milano il suo figlio Landolfo, quando morì il precedente. E pare che tale elezione sia stata ottenuta mediante versamento di tesori: tale elezione si chiama, perciò, simoniaca, che è il peccato di chi opera il traffico dei beni spirituali e delle cariche ecclesiastiche, da Simone Mago che chiese a San Pietro, in cambio di danaro, le funzioni miracolose. L'arcivescovo, considerando che non poteva rimanere in città, ne uscì con i fratelli, mentre il padre ammalato fece ricorso all'imperatore Ottone. Alla fine Landolfo potè rientrare in città; 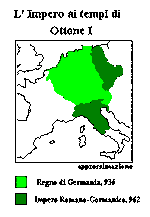 per
avere maggior forza politica ed aiuto concesse le circoscrizioni territoriali
minori rurali, o pievi, a tutti coloro che lo avevano aiutato a mantenersi
in sede arcivescovile. Tolse le pievi a quegli ecclesiastici che prima
erano i titolari ed i beneficiari. I nuovi capi di pievi erano laici
e si chiamarono capitanei: essi ottennero, quindi, in beneficio le terre
ed i diritti di riscuotere i tributi nelle loro pievi. In queste assegnazioni
fu incluso anche il territorio di Melegnano che da secoli era un sottofeudo
di Milano assegnato ad ecclesiastici e che era diviso dal Lambro dal territorio
lodigiano; la pieve di Melegnano fu concessa ad uno dei fratelli dell'arcivescovo,
Ubertino, che fu il nostro capitaneus l'anno 983. I capitanei, o
i capi di pieve, divennero così, attraverso la mediazione della
Chiesa, i padroni dell'amministrazione dei territori e vassalli dell'arcivescovo:
fu un assalto di gente nuova alla cattedra ed ai beni arcivescovili. Andava
in frantumi non soltanto il patrimonio terriero della Chiesa, ma anche
la dignità religiosa delle sue gerarchie. Erano uomini in capite,
alla testa, e quindi capitanei. E dal secolo X furono appellati capitanei
coloro che dal re, da un ufficiale, da un marchese, da un conte, ricevevano
una pieve o una parte della pieve. E, in pratica, con il nome pieve si
intendeva una qualche parte di regione o di territorio che era formata
da più villaggi o paesetti o borgate; e tale appellazione e tale
realtà si mantennero per parecchi secoli. per
avere maggior forza politica ed aiuto concesse le circoscrizioni territoriali
minori rurali, o pievi, a tutti coloro che lo avevano aiutato a mantenersi
in sede arcivescovile. Tolse le pievi a quegli ecclesiastici che prima
erano i titolari ed i beneficiari. I nuovi capi di pievi erano laici
e si chiamarono capitanei: essi ottennero, quindi, in beneficio le terre
ed i diritti di riscuotere i tributi nelle loro pievi. In queste assegnazioni
fu incluso anche il territorio di Melegnano che da secoli era un sottofeudo
di Milano assegnato ad ecclesiastici e che era diviso dal Lambro dal territorio
lodigiano; la pieve di Melegnano fu concessa ad uno dei fratelli dell'arcivescovo,
Ubertino, che fu il nostro capitaneus l'anno 983. I capitanei, o
i capi di pieve, divennero così, attraverso la mediazione della
Chiesa, i padroni dell'amministrazione dei territori e vassalli dell'arcivescovo:
fu un assalto di gente nuova alla cattedra ed ai beni arcivescovili. Andava
in frantumi non soltanto il patrimonio terriero della Chiesa, ma anche
la dignità religiosa delle sue gerarchie. Erano uomini in capite,
alla testa, e quindi capitanei. E dal secolo X furono appellati capitanei
coloro che dal re, da un ufficiale, da un marchese, da un conte, ricevevano
una pieve o una parte della pieve. E, in pratica, con il nome pieve si
intendeva una qualche parte di regione o di territorio che era formata
da più villaggi o paesetti o borgate; e tale appellazione e tale
realtà si mantennero per parecchi secoli.
Madelberto e Hungeer Mentre si svolgono i grandi avvenimenti storici interessanti la zona milanese per il periodo dell'Alto Medioevo, emergono due fatti di cronaca locale melegnanese che hanno come protagonisti Madelberto e Hungeer. Madelberto, l'anno 830, è presente in qualità di teste per il contratto di vendita di terreni in Cologno Monzese. La vendita è fatta all'Abbazia di sant'Ambrogio. La fonte storica dice: Madelbertus clericus de Meloniano (Madelberto chierico da Melegnano), il che significa che il nostro personaggio era nella classe sociale degli intellettuali: sapeva scrivere, leggere bene, e capire il valore di un contratto. Madelberto era una persona consacrata al sacro ministero, perchè soltanto negli ultimi secoli del Medioevo erano detti clerici anche le persone dotte, senza essere nel rango ecclesiastico. Tuttavia non sappiamo la posizione nella gerarchia. Neppure dal fatto che sia stato scelto come teste, è possibile trarre qualche indizio, perché vi sono parecchi casi di testimoni nei contratti presi da ogni ceto sociale. Hungeer invece è un abitante di Milano (avitator civitatis Mediolani così dice la fonte storica) che l'anno 836, nel mese di febbraio, stabilisce che i suoi beni immobili nella Bassa Milanese siano, dopo la sua morte, lasciati al senodochio (luogo pio dove sono accolti i pellegrini) situato nel vico di Meloniano; il senodochio era dedicato a Santa Maria Genitrice di Dio. Questa notizia, apparentemente scarna, apre invece diverse prospettive storiche; e vediamo perchè. Nell'ultimo periodo del loro dominio, i Longobardi incominciarono ad ammettere nei loro stati alcuni forestieri, ed a permettere loro di seguire le patrie leggi nel tribunale dei contratti ed in altri atti legali. Ancora prima dell'arrivo massiccio, armato, militare dei Franchi conquistatori (l'anno 744) già si trovano alcuni di loro, che possiedono terreni e che trasmettono ai figli i loro beni. E' vero che il nostro Hungeer stende l'atto notarile l'anno 836; ma tutto lascia a credere che da tempo la sua famiglia fosse in Italia, ancora prima dell'arrivo dei Franchi. Nell'intento di scrivere il testamento chiamò alcune persone che fossero poi gli esecutori testamentari. I terreni di sua proprietà si trovavano a Gnignano, Zeloforomagno, alla cascina delle Sette Vie, a Carpiano, a Maiano. Alcuni terreni erano lasciati in eredità ai suoi parenti e ai suoi fedeli servitori. Il fondo rustico di Maiano, tra Lodi e Sant'Angelo, era dato al senodochio di Melegnano, vico Meloniano: esecutore era Guazone diacono milanese. Se la parola vico è da prendersi in senso stretto, significa che il nostro paese era soltanto un gruppo di case senza nessuna importanza. La rovina delle cavallette Un altro fatto di cronaca. L'anno 871 il cronista Andrea Presbiter, scrittore bizantino di cui si ignora il luogo di nascita, vissuto verso il secolo IX-X, ci ricorda che nella zona tra il Lodigiano ed il Milanese, quindi nei territori melegnanesi, si lanciarono nubi di cavallette sui campi. Per diversi giorni, a torme, a densi sciami, consumarono i grani, ogni forma vegetale, ogni erba, sotto gli occhi impauriti dei contadini. |
|
tel.02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |