Nel 1532 il capitano di ventura
 Gian
Giacomo Medici, detto il Medeghino, riceveva dal duca di Milano, Francesco
II° Sforza, dopo laboriose trattative, il castello di Melegnano, diventando
primo marchese della nostra borgata. Dopo ventitrè anni di marchesato,
Gian Giacomo moriva a Milano il giorno 8 novembre
del 1555. E, non avendo figli, l'eredità del feudo melegnanese passò
al fratello Gian Angelo, che era cardinale e Pro
Legato apostolico di Bologna. Il cardinale, come nuovo marchese, dimorava
poco in castello di Melegnano, ed aveva lasciato ogni incarico amministrativo
a terze persone, non della sua famiglia; e questo nostro marchese cardinale
divenne papa con il nome di Pio IV° nel 1559,
dopo quattro anni di marchesato melegnanese. Andò a Roma in Vaticano,
ma si ricordò di Melegnano, perchè il 20 gennaio 1563 diede
a noi la famosa Bolla del Perdono.
Fin qui è la storia accertata su inequivocabili documenti severamente
passati al vaglio della critica definitiva. Invece, per quanto riguarda
la modalità e le circostanze della concessione, ecco che verità
storica e fantasia sono tra loro mescolate e difficili da separare.
Vi è una tradizione secolare, radicata profondamente nel tessuto
del popolo melegnanese che dice così: il nostro cardinale marchese,
un giorno in cui era stanco e forse ammalato, dovendo recarsi da Milano
a Bologna, passò da Melegnano e decise di fermarsi nel suo castello
per trascorrere la notte. Ma in castello viveva, solitaria e misantropa,
la sua cognata, moglie di quel primo marchese morto, e che conduceva una
vita vedovile scontrosa ed ostile, non volendo cedere i diritti del suo
morto marito Gian Giacomo al nuovo marchese cardinale.
Quando il cardinale giunse in castello sul far della sera, la cognata vedova
ordinò ai servi di alzare il ponte levatoio e di non ricevere il
cardinale marchese, e neppure il suo seguito: l'oltraggio tra parenti era
così clamoroso; ed il buon e mite cardinale trovò ospitalità
in casa parrocchiale, presso il parroco Giovanni Battista De Pavesiis, mentre
il popolo si univa in stretta solidarietà attorno al prelato. E quando
il nostro cardinale divenne papa, l'atto di ospitalità fruttò
una bolla dell'Indulgenza detta del Perdono,
come atto solenne pubblico di stima e di ringraziamento del papa, ex melegnanese,
ai suoi amici cari e ospitali.
Gian
Giacomo Medici, detto il Medeghino, riceveva dal duca di Milano, Francesco
II° Sforza, dopo laboriose trattative, il castello di Melegnano, diventando
primo marchese della nostra borgata. Dopo ventitrè anni di marchesato,
Gian Giacomo moriva a Milano il giorno 8 novembre
del 1555. E, non avendo figli, l'eredità del feudo melegnanese passò
al fratello Gian Angelo, che era cardinale e Pro
Legato apostolico di Bologna. Il cardinale, come nuovo marchese, dimorava
poco in castello di Melegnano, ed aveva lasciato ogni incarico amministrativo
a terze persone, non della sua famiglia; e questo nostro marchese cardinale
divenne papa con il nome di Pio IV° nel 1559,
dopo quattro anni di marchesato melegnanese. Andò a Roma in Vaticano,
ma si ricordò di Melegnano, perchè il 20 gennaio 1563 diede
a noi la famosa Bolla del Perdono.
Fin qui è la storia accertata su inequivocabili documenti severamente
passati al vaglio della critica definitiva. Invece, per quanto riguarda
la modalità e le circostanze della concessione, ecco che verità
storica e fantasia sono tra loro mescolate e difficili da separare.
Vi è una tradizione secolare, radicata profondamente nel tessuto
del popolo melegnanese che dice così: il nostro cardinale marchese,
un giorno in cui era stanco e forse ammalato, dovendo recarsi da Milano
a Bologna, passò da Melegnano e decise di fermarsi nel suo castello
per trascorrere la notte. Ma in castello viveva, solitaria e misantropa,
la sua cognata, moglie di quel primo marchese morto, e che conduceva una
vita vedovile scontrosa ed ostile, non volendo cedere i diritti del suo
morto marito Gian Giacomo al nuovo marchese cardinale.
Quando il cardinale giunse in castello sul far della sera, la cognata vedova
ordinò ai servi di alzare il ponte levatoio e di non ricevere il
cardinale marchese, e neppure il suo seguito: l'oltraggio tra parenti era
così clamoroso; ed il buon e mite cardinale trovò ospitalità
in casa parrocchiale, presso il parroco Giovanni Battista De Pavesiis, mentre
il popolo si univa in stretta solidarietà attorno al prelato. E quando
il nostro cardinale divenne papa, l'atto di ospitalità fruttò
una bolla dell'Indulgenza detta del Perdono,
come atto solenne pubblico di stima e di ringraziamento del papa, ex melegnanese,
ai suoi amici cari e ospitali. La critica storica
Il racconto della tradizione che presenta la cognata vedova che alza il ponte levatoio per rifiutare il cardinale è una storiella, è una fantasiosa colorita fiaba da letteratura infantile. In castello non è mai esistita nessuna vedova, perchè Marzia Orsini (tale era il nome della moglie del primo marchese, morì prima del suo marito, ed il vedovo era lui. Il fatto di essere chiamata "vedova" venne da una grossa confusione ed equivoco: Marzia Orsini, quando sposò il primo marchese Gian Giacomo non era nè vergine nè al suo primo matrimonio; era già sposata e rimasta vedova del primo marito; Gian Giacomo era il suo secondo marito che muore dopo di lei. La Bolla del Perdono, conservata presso il parroco di Melegnano, è autentica: anche personalmente Don Cesare Amelli ha condotto uno studio sulla Bolla e in altra parte ha esposto i risultati della ricerca. Quindi quella pergamena la Bolla che viene esposta il giovedì santo con solenne cerimonia in chiesa San Giovanni, è quella che ci concesse di sua mano il papa Pio IV° il 20
 gennaio
1563. Ma il testo linguistico della Bolla, scritto in un bel latino classico,
ha uno schema fraseologico simile ad altre Bolle concesse ad altre comunità
e per altri motivi da parte dello stesso Pio IV°.
Quindi lo schema del testo linguistico non ha nulla di originale se non
la citazione della chiesa di Melegnano e delle circostanze dell'indulgenza.
A fondamento della concessione della Bolla non sta, dunque, una bieca arruffata
vicenda familiare, e neppure un atto di specifica eccezionale riconoscenza
campanilistica; ma sta il desiderio del papa Pio IV°
di diffondere l'uso delle indulgenze, secondo il rinnovato clima religioso
morale della Controriforma e la nuova disciplina conciliare. Difatti il
Concilio di Trento, chiuso proprio da Pio IV°,
dopo quello di Lione e di Vienna tornò ad occuparsi delle indulgenze,
soprattutto in vista della spietata guerra dichiarata dai riformatori Lutero,
Calvino, Zuiglio. Nella sessione 25 del Concilio di Trento si emanò
il celebre decreto “De Indulgentiis”, nel quale si approvava l'uso delle
indulgenze perché molto benefiche al popolo cristiano (“christiano
populo maxime salutares”). E tra le parrocchie favorite da queste concessioni
vi fu anche Melegnano. Il papa Pio IV° concesse
un altro Perdono a Melegnano, il 25
febbraio i 562 al convento di Santa Maria della Misericordia, ora demolito;
e si potrebbe accennare anche al famoso Perdono
di Milano, concesso all'Ospedale Maggiore, il 1° marzo 1560, come giubileo
perpetuo. Melegnano, dunque, il 20 gennaio 1563, ebbe il privilegio dell'indulgenza
plenaria del Perdono, che significa,
in altre parole, assicurarsi la strada direttissima al cielo dei beati,
senza fare soste temporanee al purgatorio; e ciò compiendo alcune
pratiche religiose, come, per esempio, la visita alla chiesa di San
Giovanni nei giorni prescritti dalla Bolla. Ora passiamo in rassegna
alcuni dati di fatto che hanno favorito lo sviluppo nei secoli del Perdono,
creandosi attorno un movimento di interessi vari, da quelli economici a
quelli ricreativi. Questi dati di fatto sono: Melegnano paese cristiano
cattolico; la presenza del mercato del giovedì; la geografia che
condiziona la storia.
gennaio
1563. Ma il testo linguistico della Bolla, scritto in un bel latino classico,
ha uno schema fraseologico simile ad altre Bolle concesse ad altre comunità
e per altri motivi da parte dello stesso Pio IV°.
Quindi lo schema del testo linguistico non ha nulla di originale se non
la citazione della chiesa di Melegnano e delle circostanze dell'indulgenza.
A fondamento della concessione della Bolla non sta, dunque, una bieca arruffata
vicenda familiare, e neppure un atto di specifica eccezionale riconoscenza
campanilistica; ma sta il desiderio del papa Pio IV°
di diffondere l'uso delle indulgenze, secondo il rinnovato clima religioso
morale della Controriforma e la nuova disciplina conciliare. Difatti il
Concilio di Trento, chiuso proprio da Pio IV°,
dopo quello di Lione e di Vienna tornò ad occuparsi delle indulgenze,
soprattutto in vista della spietata guerra dichiarata dai riformatori Lutero,
Calvino, Zuiglio. Nella sessione 25 del Concilio di Trento si emanò
il celebre decreto “De Indulgentiis”, nel quale si approvava l'uso delle
indulgenze perché molto benefiche al popolo cristiano (“christiano
populo maxime salutares”). E tra le parrocchie favorite da queste concessioni
vi fu anche Melegnano. Il papa Pio IV° concesse
un altro Perdono a Melegnano, il 25
febbraio i 562 al convento di Santa Maria della Misericordia, ora demolito;
e si potrebbe accennare anche al famoso Perdono
di Milano, concesso all'Ospedale Maggiore, il 1° marzo 1560, come giubileo
perpetuo. Melegnano, dunque, il 20 gennaio 1563, ebbe il privilegio dell'indulgenza
plenaria del Perdono, che significa,
in altre parole, assicurarsi la strada direttissima al cielo dei beati,
senza fare soste temporanee al purgatorio; e ciò compiendo alcune
pratiche religiose, come, per esempio, la visita alla chiesa di San
Giovanni nei giorni prescritti dalla Bolla. Ora passiamo in rassegna
alcuni dati di fatto che hanno favorito lo sviluppo nei secoli del Perdono,
creandosi attorno un movimento di interessi vari, da quelli economici a
quelli ricreativi. Questi dati di fatto sono: Melegnano paese cristiano
cattolico; la presenza del mercato del giovedì; la geografia che
condiziona la storia. Melegnano paese cristiano e cattolico
Melegnano era un paese totalmente cristiano cattolico, situato nella Bassa Milanese, in una zona geografica, cioè, esente da ogni infiltrazione di natura eretica e protestante. I segni della fede in Melegnano sono parecchi nel 1500: la chiesa di San Giovanni; la primitiva cappella di San Pietro; la chiesa di Santa Maria dei Servi; la chiesa del Carmine; le chiese minori di Sant'Antonio
in Colturano, di San Rocco a Riozzo, della Madonna della Neve a Mezzano, di Maria Bambina alla Rocca Brivio, di Sarmazzano, di San Pietro in Vizzolo, di Santa Maria in Calvenzano; più i conventi dei Frati francescani e dei Cappuccini, con la presenza di un affollato monastero femminile delle Suore Orsoline. Questo dato di fatto storico religioso è una delle cause immediate del primo logico grande affollamento per l’acquisto del Perdono. Vi sono documenti chiari che attestano la intensa frequenza; ne cito uno per tutti: a soli cinquant'anni di distanza, nel 1616, il parroco di Melegnano, Girolamo Pusterla avanza a Roma la richiesta al papa Paolo V° per ottenere la dispensa dalle ristrettezze del digiuno quaresimale relativamente ad alcuni cibi, perchè, dice il documento “accorre immensa folla”. E' un chiaro segno di un robusto movimento a carattere alimentare e mangereccio che aveva i suoi punti forti nei ristoranti, nelle trattorie e nelle osterie. La fede cristiana dei melegnanesi assicurò, dunque, il primo grande successo al privilegio papale. Il concentramento della folla che veniva ad acquistare l'indulgenza non è sfuggito ai commercianti ed agli esercenti, ed in genere agli operatori economici. Ed è questo un fenomeno di massa per tutti i tempi: i Greci, per esempio, chiamavano agorà o empori i mercati che si svolgevano nelle loro cittadine nei giorni di festa o di celebrazioni pubbliche; leggendo le “Siracusane” del poeta Teocrito del terzo secolo avanti Cristo, ci sentiamo trasportati nel variopinto traffico caotico della città di
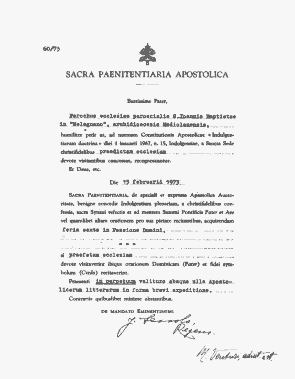 Siracusa
in un giorno solenne di festa religiosa. Talvolta è la stessa autorità
religiosa o politica che prende l'iniziativa; e, tanto per citare alcuni
esempi, nel 902 il vescovo di Bergamo ordina la costituzione di una fiera
in onore a Sant'Alessandro; a Venezia l'imperatore Ottone I° autorizza
la fiera di San Zeno; Milano nel 963 aveva la sua prima fiera detta di San
Gervasio e Protasio e che durava due settimane; a Vercelli si effettuava,
già dal decimo secolo, la Fiera di Sant'Eusebio; e per tutti i secoli
rimarrà memorabile il fatto clamoroso della scenata di Cristo contro
i mercanti che si erano stanziati entro i recinti del tempio di Gerusalemme.
Del resto, proviamo ad osservare anche oggi quello che avviene attorno a
certi santuari sparsi un po' dappertutto: luoghi che dovrebbero essere soltanto
manifestazioni di culto e di religiosità. Al limite troviamo anche
il fenomeno urbanistico di una città che è definibile come
città-santuario, per esempio Loreto nelle Marche. Ed anche a Melegnano
è avvenuto molto presto questo incontro tra religione e commercio.
Ancora per il 1600 abbiamo un prezioso documento, a mio parere eloquentissimo;
si tratta di un quadro, dipinto da ignoto ma da taluni attribuito al Sebastianone
ed è di proprietà del Borromeo. Il contenuto del quadro presenta
queste sei emergenze: movimento religioso attorno alla chiesa di San
Giovanni; affollamento nelle osterie; commercio di articoli casalinghi;
esposizione di attrezzi agricoli; vendita di articoli per abbigliamento.
Sul giornale "Il Melegnanese" del 1° aprile 1971 Don Cesare Amelli ha
descritto un commento analitico del quadro stesso. La conseguenza è
di evidente constatazione: l'unione dei due elementi, religione ed economia,
si fa strettissima già nei primi decenni della concessione della
Bolla. E così rimane anche per tutto il Settecento. Anche più
vicino a noi, nell'Ottocento, questa unione fu interpretata come benefica,
positiva e provvidenziale dal portavoce più evidente dell'Ottocento,
lo storico Ferdinando Saresani, prete della chiesa di San
Giovanni. Non ci deve sfuggire proprio questo fatto: uno storico che
è religioso e sacerdote di Melegnano parla con viva compiacenza,
dando un giudizio di valore nettamente positivo sul Perdono,
descrivendolo con profondo interesse in maniera lodevole. A pagina 49 della
sua opera (“Cenni storici dell'antico e moderno insigne Borgo di Melegnano”)
dice che il parroco di allora, Giovanni Battista De Pavesiis, ha ricevuto
la famosa Bolla per favorire “il bene spirituale ed anche terreno dei suoi
parrocchiani”. Ma più indicativo e maggiormente eloquente è
il testo che segue: “Il grido di una indulgenza
cotanto straordinaria nella sua estensione, e concessa a questo insigne
borgo, volò in poco tempo sulla bocca di tutti; ed è non poco
tripudio che da ogni buono si prova, al sentire che ne' paesi anche i più
lontani, si ripete, oggidì ancora, che il Perdono
è a Melegnano. Da ciò una gara la più divota in ogni
tempo della sua onoranza, un affollarsi dei più pietosi a fruirne
solleciti il tesoro: quindi un crescere di voti, un moltiplicarsi di offerte
alla nostra chiesa, fino a disporvi un fondo bastevole per l'erezione di
otto canonicati: quindi fonte di guadagno; estesa ad ogni ramificazione
di commercio, e tanto meravigliosa in quei giorni, particolarmente pei venditori
di comestibili, che non è raro procuri loro in poche ore quanto guadagno
ebbero in molti mesi, ed è loro necessario ai comodi per l'intera
annata”. Il testo dice, in altre parole: ben venga il Perdono,
perchè ci porta soldi e commercio e guadagni!
Siracusa
in un giorno solenne di festa religiosa. Talvolta è la stessa autorità
religiosa o politica che prende l'iniziativa; e, tanto per citare alcuni
esempi, nel 902 il vescovo di Bergamo ordina la costituzione di una fiera
in onore a Sant'Alessandro; a Venezia l'imperatore Ottone I° autorizza
la fiera di San Zeno; Milano nel 963 aveva la sua prima fiera detta di San
Gervasio e Protasio e che durava due settimane; a Vercelli si effettuava,
già dal decimo secolo, la Fiera di Sant'Eusebio; e per tutti i secoli
rimarrà memorabile il fatto clamoroso della scenata di Cristo contro
i mercanti che si erano stanziati entro i recinti del tempio di Gerusalemme.
Del resto, proviamo ad osservare anche oggi quello che avviene attorno a
certi santuari sparsi un po' dappertutto: luoghi che dovrebbero essere soltanto
manifestazioni di culto e di religiosità. Al limite troviamo anche
il fenomeno urbanistico di una città che è definibile come
città-santuario, per esempio Loreto nelle Marche. Ed anche a Melegnano
è avvenuto molto presto questo incontro tra religione e commercio.
Ancora per il 1600 abbiamo un prezioso documento, a mio parere eloquentissimo;
si tratta di un quadro, dipinto da ignoto ma da taluni attribuito al Sebastianone
ed è di proprietà del Borromeo. Il contenuto del quadro presenta
queste sei emergenze: movimento religioso attorno alla chiesa di San
Giovanni; affollamento nelle osterie; commercio di articoli casalinghi;
esposizione di attrezzi agricoli; vendita di articoli per abbigliamento.
Sul giornale "Il Melegnanese" del 1° aprile 1971 Don Cesare Amelli ha
descritto un commento analitico del quadro stesso. La conseguenza è
di evidente constatazione: l'unione dei due elementi, religione ed economia,
si fa strettissima già nei primi decenni della concessione della
Bolla. E così rimane anche per tutto il Settecento. Anche più
vicino a noi, nell'Ottocento, questa unione fu interpretata come benefica,
positiva e provvidenziale dal portavoce più evidente dell'Ottocento,
lo storico Ferdinando Saresani, prete della chiesa di San
Giovanni. Non ci deve sfuggire proprio questo fatto: uno storico che
è religioso e sacerdote di Melegnano parla con viva compiacenza,
dando un giudizio di valore nettamente positivo sul Perdono,
descrivendolo con profondo interesse in maniera lodevole. A pagina 49 della
sua opera (“Cenni storici dell'antico e moderno insigne Borgo di Melegnano”)
dice che il parroco di allora, Giovanni Battista De Pavesiis, ha ricevuto
la famosa Bolla per favorire “il bene spirituale ed anche terreno dei suoi
parrocchiani”. Ma più indicativo e maggiormente eloquente è
il testo che segue: “Il grido di una indulgenza
cotanto straordinaria nella sua estensione, e concessa a questo insigne
borgo, volò in poco tempo sulla bocca di tutti; ed è non poco
tripudio che da ogni buono si prova, al sentire che ne' paesi anche i più
lontani, si ripete, oggidì ancora, che il Perdono
è a Melegnano. Da ciò una gara la più divota in ogni
tempo della sua onoranza, un affollarsi dei più pietosi a fruirne
solleciti il tesoro: quindi un crescere di voti, un moltiplicarsi di offerte
alla nostra chiesa, fino a disporvi un fondo bastevole per l'erezione di
otto canonicati: quindi fonte di guadagno; estesa ad ogni ramificazione
di commercio, e tanto meravigliosa in quei giorni, particolarmente pei venditori
di comestibili, che non è raro procuri loro in poche ore quanto guadagno
ebbero in molti mesi, ed è loro necessario ai comodi per l'intera
annata”. Il testo dice, in altre parole: ben venga il Perdono,
perchè ci porta soldi e commercio e guadagni! Il mercato settimanale del giovedì
Un dato di fatto che non dobbiamo trascurare è il mercato del giovedì di ogni settimana, concesso otto anni prima della Bolla dalle autorità imperiali spagnole per interessamento del nostro primo marchese Gian Giacomo Medici, il 4 aprile 1555, e favorito di immunità e privilegi quanto a tasse e a imposte. Quindi la indulgenza del Perdono, l'accorrere della folla, gli operatori economici, trovano già il terreno predisposto alle contrattazioni ed alle normali operazioni di mercato; trovano, cioè, la piazza avviata. E la Fiera del Perdono non solo fu uno sviluppo maggiore del mercato del giovedì, ma anche un incoraggiamento ad ogni tipo di mercato, se pensiamo che nel corso dei secoli giunsero leggi locali e provinciali per interventi migliorativi del mercato stesso con decreti del 16 maggio 1657; 31 agosto 1715; 5 ottobre 1730 e 12 luglio 1835: sono date che indicano, nel corso del tempo, un continuo interesse di più vasto adeguamento nel settore commerciale di Melegnano. Più interessante sarebbe il documento dell'autorità austriaca alla vigilia del Risorgimento, in data 22 ottobre 1828, per frenare gli abusi che si verificavano sul mercato e sulle fiere di Melegnano, nel clima della Restaurazione amministrativa, pignola ma onesta, dell'Austria nel Lombardo-Veneto. Quello che ci interessa da vicino, però, è che nei documenti si parla di mercato di animali, di granaglie specialmente della biada e di prodotti della campagna: il che denota che, sulla piazza mercantile di Melegnano vi fosse una emergenza di economia agricola.
La geografia condiziona la storia
Vi è ulteriore dato di fatto: la posizione geografica di Melegnano. I fattori e gli elementi climatici (latitudine, altezza sul mare, idrografia, vegetazione; temperatura, umidità, precipitazioni, venti); il terreno irriguo e fertile; il tipo del sottosuolo, danno come risultante una economia agricola che ha uno sviluppo di coltivazioni tipiche rurali che altre zone ci invidiano. Bisogna inoltre aggiungere che al tempo della Bolla (1563) l'agricoltura melegnanese e dei dintorni sperimentava ormai da secoli la capacità di generazioni e generazioni che coltivarono questi terreni con visione consapevole del loro valore e della resa abbondante: qui i Benedettini del secolo XII°, i feudatari dei secoli XIII°, XIV° e XV°, qui la corsa francese e la cupidigia spagnola volsero i loro interessi economico-politici, nella constatazione della felice posizione dei terreni rurali, E' la tesi storiografica, non ancora pacifica in sede scientifica, della geografia che condiziona la storia. E su questi terreni era possibile prevedere il frutto positivo del lavoro di migliaia di contadini, dall'alba al tramonto, tesi in legami feudali che poco concedevano loro di libertà, nel trapasso di padre in figlio delle incombenze di lavoro in campagna o nella stalla. Qui sociologia e commercio, demografia e feudalità, geografia umana e lavoro, potrebbero trovare ampio materiale per le loro feconde e dense formulazioni scientifiche ed evocative. Sulla Mappa di Melegnano, detta di Maria Teresa d'Austria, fissata per il 1750, che si trova depositata presso l'Archivio di Stato di Milano, è segnata la zona a terreno agricolo pari al 90% dei territorio comunale di Melegnano. E nel 1860, dopo le due guerre per il Risorgimento Italiano, in clima di laboriosa e faticosa rinascita per un razionale sfruttamento rurale, la superficie di Melegnano era di 439 ettari, di cui 378 per superficie agraria, pari all'86 % del totale, mentre la popolazione superava di poco le 4000 persone. E all'indomani del Risorgimento Italiano e verso la fine dell'800 l'economia melegnanese si apre a più vaste dimensioni:
Mezzi di trasporto: è del 1880 l'installazione della linea tramviaria Milano – Melegnano – Lodi - Sant'Angelo - San Colombano. Nello stesso anno fu costruita la Stazione Ferroviaria per viaggiatori, per merci a piccolo e a grande scalo e per piccola velocità. Nel 1886 fu iniziato l'esproprio per l'installazione del secondo binario, concluso nel 1889; Piazze: da tempo immemorabile esistevano la Piazza del Mercato, la Piazza Visconti; la Piazza San Giovanni; la Piazza Codeleoncini. Nel 1891 furono allargate le prime due piazze e ne fu creata un'altra per i cavalli, buoi , mucche e maiali, che è l'attuale Piazza IV Novembre, detta in gergo melegnanese "la piàsa di nimài": la piazza degli animali; Le banche: nel 1869 la Banca Popolare di Lodi apriva uno sportello a Melegnano; e nel 1884 anche la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde metteva una dipendenza. Tuttavia devo avvertire che si tratta della ultima grande stagione commerciale agricola, dopo il periodo romano, benedettino, rinascimentale, e moderno fino ai primi decenni del 1900. Dopo il primo quarto del 1900 la Festa e la Fiera del Perdono iniziano una parabola alternante, ascendente e discendente, quantitativa e qualitativa, strumentalizzata o politicizzata, che creerà una più complessa indefinibile fisionomia.
La trasformazione del Perdono
Alla fine del 1700 e dopo il 1815, le zone agricole staccate dai centri metropolitani, dal punto di vista politico, erano totalmente refrattarie ad ogni mutamento soprattutto rivoluzionario. Le nostre popolazioni della Bassa Milanese rimanevano attaccate alle loro tradizioni secolari, e volentieri accettavano il retto paternalismo della sana amministrazione dell'Austria dopo il Congresso di Vienna del 1815. Ed anche il cambiamento politico dopo il 1859 ed il 1870 turbò pochissimo le abitudini radicate dei melegnanesi. Questo rinsaldava la perenne struttura secolare della Fiera del Perdono, che rimaneva sempre integra nella sua duplice prestazione e funzione di richiamo e affollamento per il motivo religioso, e di vitalità e prestazione economica: un motivo sosteneva l'altro e lo giustificava, e l'attaccamento alle tradizioni dei padri li difendeva. Sembrava, cioè, che al di là dei mutamenti politici e sociali, gli schemi secolari della Festa e della Fiera del Perdono rimanessero intatti e inattaccabili, come formule cristallizzate e sempre validamente incontestabili, cui ci si era da tempo immemorabile abituati a rispettare ed a ripetere; cioè la storia del Perdono era la sua garanzia di riuscita. Ancora nel 1914, alla vigilia della prima guerra mondiale, in occasione della Fiera del Perdono, venne organizzata una mostra zootecnica di equini e di bovini, che le cronache dell'epoca descrivono "splendida, significativa in ogni sua parte”. Pure vent'anni dopo, nel 1934, l'orizzonte fieristico si era ulteriormente allargato: mostra bovina, equina, suina, macchine agricole, edilizia rurale, prodotti per l'arte casearia, alimentari, vini, liquori, artigianato, pollicultura, fiori: su dodici settori, Otto sono prettamente agricoli; cioè, la preminenza dell'agricoltura è ancora innegabile fino al 1934. La Festa e Fiera del Perdono di Melegnano del 1934 rimane famosa nella storia, perchè nei manifesti pubblicitari e negli opuscoli illustrativi è chiamata "Grande Fiera del Perdono di Melegnano". Anzi, nell'introduzione all'opuscolo ufficiale si legge testualmente: “Rinnovata iniziativa della gente di Melegnano onde ottenere il rifiorir del proprio commercio e la valutazione dei propri prodotti squisiti e genuini”. Si costituirono Comitati di Onore, Comitati Esecutivi, Comitati di Zona. Però sta diventando chiaro un elemento di trasformazione: il movimento economico ha raggiunto il peso di quello religioso, ed il valore religioso del Perdono sta per essere superato. Ed è assai significativo il fatto che sull'opuscolo ufficiale del 1934, o per dimenticanza o per disinteresse, non si accenni mai al lato e all'importanza religiosa e neppure alla magnanimità di Pio IV°. E ricordiamo che non siamo ancora arrivati al periodo storico della corrosività laica antireligiosa o alla valutazione della religione come fatto privato, o addirittura al movimenti attuali di svecchiamento delle strutture anacronistiche ecclesiastiche. Ancora un rilievo importante. La Festa e la Fiera del Perdono del 1934 è indimenticabile da un punto di vista politico. Durante i giorni della Fiera, e specialmente il 2 aprile, si tenne a Melegnano la Prima grande rassegna agricola del melegnanese, che fu un misto di festa agricola, folcloristica, e come manifestazione di collaudo politico e capacità organizzativa delle masse. Difatti il programma aveva questo intreccio: passaggio per Melegnano dei migliori traini agricoli; rassegna delle "balde centurie" dei lavoratori agricoli del melegnanese; rassegna degli elementi organizzativi delle aziende agricole della zona; festa del lavoro con premiazione dei lavoratori più anziani della terra. Non bisogna tuttavia dimenticare il presupposto economico-politico programmatico che andava sotto il nome di "Battaglia del grano". Una preziosa testimonianza è un manoscritto che si conserva presso l'Archivio dell'Istituto Storico Melegnanese. Si tratta della relazione sulla Fiera del Perdono, scritta da Pellegrino Origoni, morto nel 1934, un uomo che era, già da vivo, in concetto di santità; religiosissimo, presidente e consigliere di associazioni, consigliere ed assessore comunale, portavoce ufficiale del pensiero religioso e degli orientamenti dell'apostolato laico. La sua descrizione sulla Fiera è analitica, ricca di particolari. La narrazione è un ritratto molto interessante, non soltanto per l'elencazione dei prodotti principali che sono esposti in vendita, ma soprattutto proprio per aver ceduto alla tentazione di misurare la validità della Festa del Perdono dalla riuscita della Fiera. E' Pellegrino Origoni un laico, religiosamente impegnato, onesto e stimato dagli stessi avversari, che ancora esalta, che ancora valorizza, che ancora riconosce provvidenziale il Perdono, sia come mezzo di perfezione cristiana, sia come fonte di guadagno e di sviluppo economico. Citiamo, ad esempio, le parole finali della sua lunga relazione: “Comunque la Fiera del Perdono a Melegnano è sempre attesa con ansia, ed è da augurarsi che in avvenire abbia a prendere sempre maggior sviluppo ed intensità di concorso, che riesce vantaggioso al commercio interno e forese”. Un anno dopo, la Fiera del 1935, in una relazione, il podestà Luigi Moro, per il settore agricolo ed artigiano e quello delle mostre, così si esprimeva: “una vera rivelazione della bontà dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato locale, ponendo questa comunità, come nel passato, all'avanguardia in fatto di concretazioni di indole economica e commerciale”. E nel 1936, la Fiera del Perdono assume una maggior dimensione dal punto di vista zootecnico: esposizione di cavalli, muli, asini, buoi, tori, mucche, vitelli, capretti, agnelli, pecore; con premiazione a settanta espositori. Intanto la gente arrivava ogni anno a Melegnano ed affollava la chiesa, le piazze, le esposizioni e le trattorie e i
ristoranti. Negli anni della Seconda grande guerra, dal 1939 al 1945 si nota un forte ribasso; ed è logico in una economia bellica quasi al cento per cento. Per esempio, nel 1942 la Festa e la Fiera del Perdono si svolse soltanto per tre giorni; e per il 1944 non vi fu alcuna esposizione di nessun genere. Per tutti gli anni della guerra si organizzò il minimo indispensabile, con piccole rassegne di bestiame bovino e di cavalli e con qualche minore manifestazione. Il grande avvenimento è il Perdono del 1946, dopo la guerra, in clima politico e sociale differente, e per alcuni versi, contrario al passato. Il 1946 rinnova in modo clamoroso e pieno la Festa e la Fiera del Perdono; ma in realtà, forse inconsapevolmente, si posero le premesse remote per una dissoluzione dal punto di vista religioso ed economico: i nuovi schemi distruggeranno, del Perdono, la fede religiosa e il valore merceologico rurale. Ho tra le mani il documento inviato dal Comitato Fiera del Perdono alla Camera del Lavoro di Milano, in data 11 marzo 1946; ed ho studiato a lungo tutto il materiale illustrativo e programmatico, ed avrei dedotto questi risultati: è indubbia la buona fede e la buona volontà dei membri del Comitato Fiera nel voler riportare il Perdono ad un elevatissimo livello di importanza e di efficienza; ma i presupposti ideologici guidarono la scelta programmatica; ed i presupposti ideologici erano che ogni manifestazione pubblica doveva essere popolare ed interessare ogni strato della cittadinanza nell'esigenza di democraticizzare i rapporti tra la popolazione; altro presupposto era il tipo di orientamento politico e partitico che era in maggioranza a Melegnano socialista e comunista. Era chiaro dunque che, non mettendosi in dubbio la buona fede e la buona volontà dei partecipanti al Comitato della Fiera, tuttavia ogni manifestazione avrebbe avuto come base l'indirizzo ideologico prevalente.
 Ed
allora, per la prima volta nella storia, entrano, nel 1946, certe iniziative
che erano aliene e lontane dal settore economico e religioso. Cioè,
accanto a mostre ed a rassegne zootecniche ecco le altre manifestazioni
del 1946: mostra fotografica, mostra di pittura, partita di pallone, gare
sportive, omaggio ai monumenti dei caduti, corse nei sacchi ed altri moduli
di sagra paesana popolare; e nel settore di cornice ecco gli Inni francesi,
russi, svizzeri, di Mameli, di Garibaldi, del Piave, con la finale pirotecnica
dei fuochi di artificio. La parte agricola è sempre presente, ma
gli interessi programmatici ed i fondi finanziari furono destinati e suddivisi
anche per altre attività. Intanto altre città si organizzavano
con mercati e fiere meglio specifiche e con intenti economici ben chiari
pensiamo a Verona ed a Codogno, per esempio. E' da tener conto anche di
una grave rottura sociale in Melegnano, dovuta alla massiccia organizzazione
del Partito Comunista, socialista e della Democrazia Cristiana: i primi
con base ideologica marxista, e quindi non religiosa; la seconda appariva,
invece, il partito dei preti. E siccome il Perdono,
per secoli, si sosteneva sulla parte laica economica e sulla religiosa,
fondendosi a vicenda, ora invece i due settori si sentono tra loro quasi
avversari. La stessa autorità religiosa, nella persona di mons. Arturo
Giovenzana, concepiva un distacco sospettoso per tutte le attività
della Fiera, specialmente le più rumorose. Cito, a modo, di esempio,
un documento del 5 aprile 1944 diretto dal parroco al Commissario Prefettizio
ed al maresciallo dei Carabinieri di Melegnano: “Prego cortesemente e instantemente
la S.V. di isporre una vigilanza rigorosa perchè i divertimenti della
Fiera (giostra, altalena, circo e baracconi) siano intonati alla gravità
dell'ora e alla santità del tempo liturgico corrente (settimana santa).
Sua Eminenza il card. Schuster desidera ogni anno essere informato in proposito.
Gli inconvenienti di carattere morale verificatisi alcune volte nel passato
devono essere evitati, perchè non avvenga che il Perdono
ci venga tolto, e con esso venga pure compromessa la tradizionale Fiera
del Perdono. Con ossequi distinti”.
E' un documento che sembra dire poco; ma in realtà dice molte cose
per chi è stato testimone diretto dei tentativi e dei propositi,
talvolta accesi, che sono stati concepiti per togliere o per spostare nella
data la Festa del Perdono, quando fu
intesa come opposta alle esigenze dei riti sacri della settimana santa.
Si apriva, cioè, una nuova fase nei rapporti classici e secolari,
tra economia e religione, tra Fiera del Perdono
sulle piazze e Festa del Perdono in
chiesa accanto alla Bolla. Anzi, da una parte si organizzava la piazza con
le diverse manifestazioni fieristiche e ricreative indipendentemente dalle
richieste e dalle esigenze della Bolla papale; e dall'altra parte, si esponeva
la Bolla in chiesa, indipendentemente dalla presenza dell'autorità
civica. E la stranezza e paradossalità della cosa è che, chi
ci ha donato la bolla, Pio IV°, era stato
la nostra autorità civica come marchese (lontano predecessore del
sindaco) e nella stessa persona era l'autorità religiosa come papa
(il lontano predecessore del superiore del parroco). La mirabile unità
cittadina del 1616 e del 1934, descritta da Girolamo Pusterla e da Pellegrino
Origoni, e riportata ed esaltata dallo storico Saresani, era definitivamente
rotta. Negli anni dopo il 1946 si costituirono Comitati per la celebrazione
del Perdono, e fu perfino celebrato
con solennità e dovizia di mezzi nel 1963 il Quarto Centenario della
Bolla. E gli ultimi sindaci, cav. Ermenegildo De Rossi, dott. Aristide Cavalli,
Ettore Bagnoli, Gianluigi Prinelli, arch. Luigi Danova, ed i presidenti
del Comitato Fiera ed altre Manifestazioni, Luigi Bersani, cav. Giuseppe
Recagni e Carlo Pizzini, attorniati da parecchi concittadini responsabili
e rappresentanti della vita pubblica melegnanese, mentre preparavano un
programma più o meno ricco, con lavoro intenso, lodevole e gratuito,
e talvolta anche impopolare per l'impossibilità di accontentare tutti,
e mentre curavano l'organizzazione e l'esecuzione del programma, tuttavia
parecchie volte avvertivano chiaramente il punto debole della Festa e della
Fiera del Perdono: sentivano cioè
che non vi era una manifestazione o una iniziativa prioritaria, non c'era
e non era possibile trovare mai più una iniziativa fieristica tipica,
riducibile ad una sola categoria e che da sola potesse ridare la fisionomia
della Fiera e a costituire la sua sostanza etica ed estetica. Indebolitosi
il motivo religioso che era l'attrattiva primaria nei secoli passati; perdute
le occasioni di creare un grande mercato agricolo e di bestiame; accettate
forme di folclore e di arte e di sport, la Festa e la Fiera del Perdono,
oggi, non ha un suo volto: né religioso, nè economico, nè
culturale ben definito, anche se la gente va a trovare la Bolla, osserva
le macchine agricole, si diverte e si incontra. Ma ormai non si sa bene
se la Fiera del Perdono debba o dovrà
essere una rivalutazione delle indulgenze ipotesi alquanto improbabile
e un convegno di imprenditori commerciali con rassegna della produzione
economica; oppure se debba o dovrà essere una mescolanza variopinta
di attività secondo il gusto personale degli organizzatori (e attualmente
sarebbero interessati l'Amministrazione Comunale, il Comitato Fiera,
la Pro Loco e la Pro Melegnano) e secondo il principio della selezione delle
iniziative che sono meno costose o maggiormente clamorose. Siamo, cioè,
riportati anche a Melegnano e nel nostro piccolo mondo locale, al problema
più vasto che non è religioso, sociale, economico e politico,
ma è filosofico, cioè di visione e di interpretazione globale
della realtà umana. In altre parole più semplici, anche la
Fiera del Perdono è diventata
un mezzo efficacissimo per esprimere quello che noi pensiamo individualmente
della religione, della politica, della economia e della società.
La Festa e la Fiera del Perdono, cioè,
non è più vista come realtà e sostanza oggettiva esterna
a noi e a noi superiore, da servire con organizzazione e tecnica; ma è
vista come occasione annuale per chiarire e per mostrare una volta di più
i nostri personali individuali concetti sui diversi settori della vita,
sia melegnanese, sia socialmente più vasta. Se in realtà fosse
così, possiamo dire che la Fiera del Perdono,
pur scolorata e anemizzata, ha avuto la capacità di aumentare le
nostre funzioni critiche ed il progresso, intendendo per progresso storico
la conoscenza più ampia e più profonda del corso degli eventi.
Nei secoli passati erano i fatti a creare i valori (cioè, il fatto
della Bolla e del cardinale marchese poi papa hanno creato a Melegnano i
valori di una religione più intesa e uno sviluppo più
forte in economia). Ora, invece, noi abbiamo ribaltato il rapporto: i nostri
valori individuali e le nostre idee personali sulla religione, sull'economia,
sulla politica, danno una sempre diversa fisionomia al Perdono,
cioè oggi il Perdono è
costruito da noi, ogni anno diversamente dagli anni trascorsi: sono i valori
e i concetti a creare i fatti. E davanti a questa interpretazione filosofica,
chi è tradizionalista griderà allo scandalo e definirà
questo pensiero come iconoclasta; e il progressista porterà all'esultazione
alleluiatica. In ogni punto di vista nella storia e cioè nella vita,
è come in un lunghissimo corteo, ed ognuno vede dal suo punto del
corteo e giudica: c'è chi si trova dove il corteo cammina spedito
in avanti; c'è chi si trova in un punto dove il corteo sta fermo;
c'è chi si trova dove il corteo fa una svolta all'indietro; e c'è
chi che non sa esattamente e non vuole sapere dove si trova, limitandosi
solo a camminare per portare avanti una gamba dopo l'altra.
Ed
allora, per la prima volta nella storia, entrano, nel 1946, certe iniziative
che erano aliene e lontane dal settore economico e religioso. Cioè,
accanto a mostre ed a rassegne zootecniche ecco le altre manifestazioni
del 1946: mostra fotografica, mostra di pittura, partita di pallone, gare
sportive, omaggio ai monumenti dei caduti, corse nei sacchi ed altri moduli
di sagra paesana popolare; e nel settore di cornice ecco gli Inni francesi,
russi, svizzeri, di Mameli, di Garibaldi, del Piave, con la finale pirotecnica
dei fuochi di artificio. La parte agricola è sempre presente, ma
gli interessi programmatici ed i fondi finanziari furono destinati e suddivisi
anche per altre attività. Intanto altre città si organizzavano
con mercati e fiere meglio specifiche e con intenti economici ben chiari
pensiamo a Verona ed a Codogno, per esempio. E' da tener conto anche di
una grave rottura sociale in Melegnano, dovuta alla massiccia organizzazione
del Partito Comunista, socialista e della Democrazia Cristiana: i primi
con base ideologica marxista, e quindi non religiosa; la seconda appariva,
invece, il partito dei preti. E siccome il Perdono,
per secoli, si sosteneva sulla parte laica economica e sulla religiosa,
fondendosi a vicenda, ora invece i due settori si sentono tra loro quasi
avversari. La stessa autorità religiosa, nella persona di mons. Arturo
Giovenzana, concepiva un distacco sospettoso per tutte le attività
della Fiera, specialmente le più rumorose. Cito, a modo, di esempio,
un documento del 5 aprile 1944 diretto dal parroco al Commissario Prefettizio
ed al maresciallo dei Carabinieri di Melegnano: “Prego cortesemente e instantemente
la S.V. di isporre una vigilanza rigorosa perchè i divertimenti della
Fiera (giostra, altalena, circo e baracconi) siano intonati alla gravità
dell'ora e alla santità del tempo liturgico corrente (settimana santa).
Sua Eminenza il card. Schuster desidera ogni anno essere informato in proposito.
Gli inconvenienti di carattere morale verificatisi alcune volte nel passato
devono essere evitati, perchè non avvenga che il Perdono
ci venga tolto, e con esso venga pure compromessa la tradizionale Fiera
del Perdono. Con ossequi distinti”.
E' un documento che sembra dire poco; ma in realtà dice molte cose
per chi è stato testimone diretto dei tentativi e dei propositi,
talvolta accesi, che sono stati concepiti per togliere o per spostare nella
data la Festa del Perdono, quando fu
intesa come opposta alle esigenze dei riti sacri della settimana santa.
Si apriva, cioè, una nuova fase nei rapporti classici e secolari,
tra economia e religione, tra Fiera del Perdono
sulle piazze e Festa del Perdono in
chiesa accanto alla Bolla. Anzi, da una parte si organizzava la piazza con
le diverse manifestazioni fieristiche e ricreative indipendentemente dalle
richieste e dalle esigenze della Bolla papale; e dall'altra parte, si esponeva
la Bolla in chiesa, indipendentemente dalla presenza dell'autorità
civica. E la stranezza e paradossalità della cosa è che, chi
ci ha donato la bolla, Pio IV°, era stato
la nostra autorità civica come marchese (lontano predecessore del
sindaco) e nella stessa persona era l'autorità religiosa come papa
(il lontano predecessore del superiore del parroco). La mirabile unità
cittadina del 1616 e del 1934, descritta da Girolamo Pusterla e da Pellegrino
Origoni, e riportata ed esaltata dallo storico Saresani, era definitivamente
rotta. Negli anni dopo il 1946 si costituirono Comitati per la celebrazione
del Perdono, e fu perfino celebrato
con solennità e dovizia di mezzi nel 1963 il Quarto Centenario della
Bolla. E gli ultimi sindaci, cav. Ermenegildo De Rossi, dott. Aristide Cavalli,
Ettore Bagnoli, Gianluigi Prinelli, arch. Luigi Danova, ed i presidenti
del Comitato Fiera ed altre Manifestazioni, Luigi Bersani, cav. Giuseppe
Recagni e Carlo Pizzini, attorniati da parecchi concittadini responsabili
e rappresentanti della vita pubblica melegnanese, mentre preparavano un
programma più o meno ricco, con lavoro intenso, lodevole e gratuito,
e talvolta anche impopolare per l'impossibilità di accontentare tutti,
e mentre curavano l'organizzazione e l'esecuzione del programma, tuttavia
parecchie volte avvertivano chiaramente il punto debole della Festa e della
Fiera del Perdono: sentivano cioè
che non vi era una manifestazione o una iniziativa prioritaria, non c'era
e non era possibile trovare mai più una iniziativa fieristica tipica,
riducibile ad una sola categoria e che da sola potesse ridare la fisionomia
della Fiera e a costituire la sua sostanza etica ed estetica. Indebolitosi
il motivo religioso che era l'attrattiva primaria nei secoli passati; perdute
le occasioni di creare un grande mercato agricolo e di bestiame; accettate
forme di folclore e di arte e di sport, la Festa e la Fiera del Perdono,
oggi, non ha un suo volto: né religioso, nè economico, nè
culturale ben definito, anche se la gente va a trovare la Bolla, osserva
le macchine agricole, si diverte e si incontra. Ma ormai non si sa bene
se la Fiera del Perdono debba o dovrà
essere una rivalutazione delle indulgenze ipotesi alquanto improbabile
e un convegno di imprenditori commerciali con rassegna della produzione
economica; oppure se debba o dovrà essere una mescolanza variopinta
di attività secondo il gusto personale degli organizzatori (e attualmente
sarebbero interessati l'Amministrazione Comunale, il Comitato Fiera,
la Pro Loco e la Pro Melegnano) e secondo il principio della selezione delle
iniziative che sono meno costose o maggiormente clamorose. Siamo, cioè,
riportati anche a Melegnano e nel nostro piccolo mondo locale, al problema
più vasto che non è religioso, sociale, economico e politico,
ma è filosofico, cioè di visione e di interpretazione globale
della realtà umana. In altre parole più semplici, anche la
Fiera del Perdono è diventata
un mezzo efficacissimo per esprimere quello che noi pensiamo individualmente
della religione, della politica, della economia e della società.
La Festa e la Fiera del Perdono, cioè,
non è più vista come realtà e sostanza oggettiva esterna
a noi e a noi superiore, da servire con organizzazione e tecnica; ma è
vista come occasione annuale per chiarire e per mostrare una volta di più
i nostri personali individuali concetti sui diversi settori della vita,
sia melegnanese, sia socialmente più vasta. Se in realtà fosse
così, possiamo dire che la Fiera del Perdono,
pur scolorata e anemizzata, ha avuto la capacità di aumentare le
nostre funzioni critiche ed il progresso, intendendo per progresso storico
la conoscenza più ampia e più profonda del corso degli eventi.
Nei secoli passati erano i fatti a creare i valori (cioè, il fatto
della Bolla e del cardinale marchese poi papa hanno creato a Melegnano i
valori di una religione più intesa e uno sviluppo più
forte in economia). Ora, invece, noi abbiamo ribaltato il rapporto: i nostri
valori individuali e le nostre idee personali sulla religione, sull'economia,
sulla politica, danno una sempre diversa fisionomia al Perdono,
cioè oggi il Perdono è
costruito da noi, ogni anno diversamente dagli anni trascorsi: sono i valori
e i concetti a creare i fatti. E davanti a questa interpretazione filosofica,
chi è tradizionalista griderà allo scandalo e definirà
questo pensiero come iconoclasta; e il progressista porterà all'esultazione
alleluiatica. In ogni punto di vista nella storia e cioè nella vita,
è come in un lunghissimo corteo, ed ognuno vede dal suo punto del
corteo e giudica: c'è chi si trova dove il corteo cammina spedito
in avanti; c'è chi si trova in un punto dove il corteo sta fermo;
c'è chi si trova dove il corteo fa una svolta all'indietro; e c'è
chi che non sa esattamente e non vuole sapere dove si trova, limitandosi
solo a camminare per portare avanti una gamba dopo l'altra.
